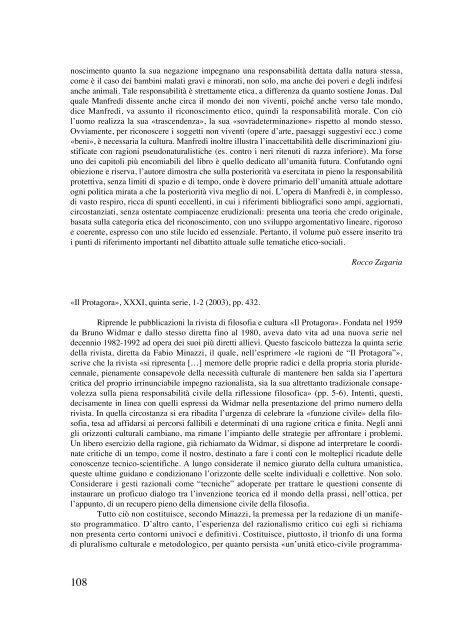Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
noscimento quanto la sua negazione impegnano una responsabilità dettata dalla natura stessa,<br />
come è il caso dei bambini malati gravi e minorati, non solo, ma anche dei poveri e degli indifesi<br />
anche animali. Tale responsabilità è strettamente etica, a differenza da quanto sostiene Jonas. Dal<br />
quale Manfredi dissente anche circa il mondo dei non viventi, poiché anche verso tale mondo,<br />
dice Manfredi, va assunto il riconoscimento etico, quindi la responsabilità morale. Con ciò<br />
l’uomo realizza la sua «trascendenza», la sua «sovradeterminazione» rispetto al mondo stesso.<br />
Ovviamente, per riconoscere i soggetti non viventi (opere d’arte, paesaggi suggestivi ecc.) come<br />
«beni», è necessaria la cultura. Manfredi inoltre illustra l’inaccettabilità delle discriminazioni giustificate<br />
con ragioni pseudonaturalistiche (es. contro i neri ritenuti di razza inferiore). Ma forse<br />
uno dei capitoli più encomiabili del libro è quello dedicato all’umanità futura. Confutando ogni<br />
obiezione e riserva, l’autore dimostra che sulla posteriorità va esercitata in pieno la responsabilità<br />
protettiva, senza limiti di spazio e di tempo, onde è dovere primario dell’umanità attuale adottare<br />
ogni politica mirata a che la posteriorità viva meglio di noi. L’opera di Manfredi è, in complesso,<br />
di vasto respiro, ricca di spunti eccellenti, in cui i riferimenti bibliografici sono ampi, aggiornati,<br />
circostanziati, senza ostentate compiacenze erudizionali: presenta una teoria che credo originale,<br />
basata sulla categoria etica del riconoscimento, con uno sviluppo argomentativo lineare, rigoroso<br />
e coerente, espresso con uno stile lucido ed essenziale. Pertanto, il volume può essere inserito tra<br />
i punti di riferimento importanti nel dibattito attuale sulle tematiche etico-sociali.<br />
«Il Protagora», XXXI, quinta serie, 1-2 (2003), pp. 432.<br />
Rocco Zagaria<br />
Riprende le pubblicazioni la rivista di filosofia e cultura «Il Protagora». Fondata nel 1959<br />
da Bruno Widmar e dallo stesso diretta fino al 1980, aveva dato vita ad una nuova serie nel<br />
decennio 1982-1992 ad opera dei suoi più diretti allievi. Questo fascicolo battezza la quinta serie<br />
della rivista, diretta da Fabio Minazzi, il quale, nell’esprimere «le ragioni de “Il Protagora”»,<br />
scrive che la rivista «si ripresenta […] memore delle proprie radici e della propria storia pluridecennale,<br />
pienamente consapevole della necessità culturale di mantenere ben salda sia l’apertura<br />
critica del proprio irrinunciabile impegno razionalista, sia la sua altrettanto tradizionale consapevolezza<br />
sulla piena responsabilità civile della riflessione filosofica» (pp. 5-6). Intenti, questi,<br />
decisamente in linea con quelli espressi da Widmar nella presentazione del primo numero della<br />
rivista. In quella circostanza si era ribadita l’urgenza di celebrare la «funzione civile» della filosofia,<br />
tesa ad affidarsi ai percorsi fallibili e determinati di una ragione critica e finita. Negli anni<br />
gli orizzonti culturali cambiano, ma rimane l’impianto delle strategie per affrontare i problemi.<br />
Un libero esercizio della ragione, già richiamato da Widmar, si dispone ad interpretare le coordinate<br />
critiche di un tempo, come il nostro, destinato a fare i conti con le molteplici ricadute delle<br />
conoscenze tecnico-scientifiche. A lungo considerate il nemico giurato della cultura umanistica,<br />
queste ultime guidano e condizionano l’orizzonte delle scelte individuali e collettive. Non solo.<br />
Considerare i gesti razionali come “tecniche” adoperate per trattare le questioni consente di<br />
instaurare un proficuo dialogo tra l’invenzione teorica ed il mondo della prassi, nell’ottica, per<br />
l’appunto, di un recupero pieno della dimensione civile della filosofia.<br />
Tutto ciò non costituisce, secondo Minazzi, la premessa per la redazione di un manifesto<br />
programmatico. D’altro canto, l’esperienza del razionalismo critico cui egli si richiama<br />
non presenta certo contorni univoci e definitivi. Costituisce, piuttosto, il trionfo di una forma<br />
di pluralismo culturale e metodologico, per quanto persista «un’unità etico-civile programma-<br />
108