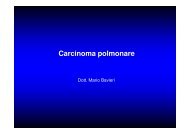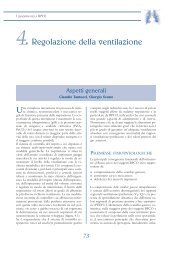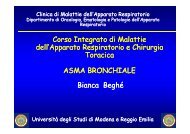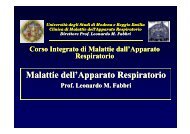1. - Clinica malattie apparato respiratorio
1. - Clinica malattie apparato respiratorio
1. - Clinica malattie apparato respiratorio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IL VOLTO DELLA BPCO CHE CAMBIA ● QUADERNO 6<br />
turale della malattia e la progressiva riduzione della<br />
funzione respiratoria nel tempo sembra attualmente<br />
possibile solo con la cessazione precoce dell’abitudine<br />
al fumo, ciò non vuol dire che il trattamento<br />
farmacologico sia inefficace. Esso, infatti,<br />
è capace di migliorare i sintomi e ridurre le limitazioni<br />
funzionali connesse alla malattia (come, per<br />
esempio,la tolleranza allo sforzo),migliorare la qualità<br />
della vita, ridurre il numero e la gravità delle<br />
riacutizzazioni e rallentare lo sviluppo delle complicazioni<br />
della malattia 1 . La sola riduzione delle<br />
riacutizzazioni può essere responsabile di una riduzione<br />
della mortalità 4 . Quindi, un atteggiamento<br />
rinunciatario nel trattamento della BPCO non<br />
è giustificato e ogni paziente dovrebbe essere attentamente<br />
valutato per ottenere il massimo miglioramento<br />
possibile nelle condizioni cliniche e<br />
funzionali connesse alla sua malattia. Per altro verso,<br />
anche un eccesso di trattamento non è giustificato,<br />
in quanto non sarebbe capace di modificare<br />
l’evoluzione della malattia.<br />
Gli obiettivi che devono essere perseguiti dal trattamento<br />
farmacologico e devono quindi essere attentamente<br />
ricercati e valutati nei controlli periodici<br />
sono riportati nella tabella <strong>1.</strong>2.<br />
La maggior parte di questi obiettivi è raggiungibile<br />
con un’adeguata scelta del trattamento farmacologico<br />
e non farmacologico e con l’educazione del<br />
paziente. Gli ultimi due obiettivi sono, al momento,<br />
difficilmente ottenibili con la terapia farmacologica,<br />
ma sia la cessazione del fumo sia l’ossigenoterapia<br />
domiciliare a lungo termine hanno mostrato<br />
la capacità di influire positivamente su questi<br />
aspetti della malattia. Molti di questi parametri<br />
sono valutabili con un’attenta indagine anamnestica,<br />
alla portata quindi anche del medico di medicina<br />
generale, altri richiedono l’utilizzo di test strumentali,a<br />
cui occorre comunque ricorrere,data anche<br />
la scarsa relazione esistente tra sintomi e alterazioni<br />
della funzione respiratoria o parametri che<br />
esprimono la tolleranza allo sforzo.<br />
Tabella <strong>1.</strong>2 Obiettivi del trattamento (modificata da 1 )<br />
Migliorare i sintomi, in particolare la dispnea<br />
Migliorare la tolleranza allo sforzo<br />
Migliorare lo stato di salute<br />
Prevenire le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni<br />
Ridurre il ricorso alle strutture sanitarie<br />
Rallentare il declino progressivo della funzione respiratoria<br />
Prevenire le complicanze (insufficienza respiratoria, cuore<br />
polmonare)<br />
Valutazione clinica<br />
I sintomi respiratori (la tosse, l’espettorazione, la dispnea<br />
da sforzo, il respiro sibilante) possono migliorare<br />
con il trattamento farmacologico, sia con<br />
l’uso dei broncodilatatori 5-8 sia, meno frequentemente,<br />
con l’uso dei corticosteroidi inalatori 9,10 o<br />
con la terapia di combinazione 11,12 .L’entità dell’effetto<br />
dipende dalle caratteristiche della malattia<br />
(in particolare dall’entità della componente di reversibiltà<br />
dell’ostruzione bronchiale di base) e dalla<br />
gravità della malattia, anche se solo pochi studi<br />
sono stati fatti in tal senso.<br />
La tosse e l’espettorazione risentono favorevolmente<br />
della cessazione del fumo e, meno frequentemente,<br />
sono riportati come migliorati dopo trattamento<br />
farmacologico. A oggi non esistono metodi<br />
standardizzati per la valutazione di questi sintomi.Valutazioni<br />
semiquantitative per i singoli sintomi<br />
sono state applicate in alcuni studi multicentrici<br />
6,11,12 , mentre altri autori hanno proposto una<br />
scala di punteggio globale dei principali sintomi (tra<br />
cui anche tosse ed espettorazione) che sembra essere<br />
sensibile al miglioramento apportato dalla terapia<br />
farmacologica 13 .<br />
La dispnea è il sintomo principale della BPCO e<br />
rappresenta quindi un obiettivo importante del<br />
trattamento farmacologico. La valutazione della<br />
dispnea è resa difficile dall’eterogeneità dei meccanismi<br />
che la determinano in ciascun soggetto<br />
(alterazioni della meccanica respiratoria, trofismo<br />
dei muscoli scheletrici, stato psicologico del paziente,<br />
comorbilità cardiovascolare ecc.) e dalla diversa<br />
modalità di espressione dei pazienti 14 .I metodi<br />
più semplici per la valutazione della dispnea<br />
sono il ricorso alla classificazione MRC (Medical<br />
Research Council) della dispnea 15 e la scala<br />
BDI/TDI (Baseline and Transition Dyspnea Indexes)<br />
16 . La prima si basa sulla distinzione in cinque<br />
gradi di attività fisica di intensità decrescente<br />
che causano dispnea. Questa classificazione è molto<br />
utile per la distinzione della gravità della dispnea<br />
tra soggetti, è parzialmente correlata con<br />
l’entità della compromissione funzionale respiratoria,<br />
ma è poco sensibile alle variazioni apportate<br />
dalla terapia farmacologica 5,10 . La scala<br />
BDI/TDI proposta da Mahler si compone di una<br />
valutazione iniziale della gravità della dispnea, distinta<br />
in diverse componenti e personalizzata per<br />
ogni individuo (baseline dyspnea index, BDI), e in<br />
una valutazione delle variazioni che si realizzano<br />
in un periodo più o meno lungo di follow-up (tran-<br />
4