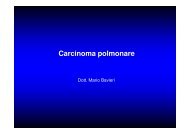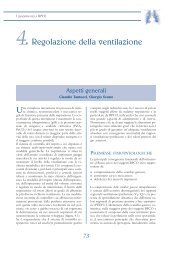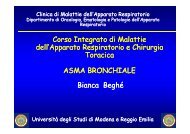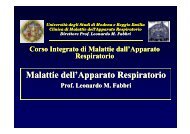1. - Clinica malattie apparato respiratorio
1. - Clinica malattie apparato respiratorio
1. - Clinica malattie apparato respiratorio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IL VOLTO DELLA BPCO CHE CAMBIA ● QUADERNO 6<br />
terzo circa dei pazienti utilizza lo “stroller” portatile<br />
quando esce di casa: ancora una volta è fondamentale<br />
l’opera di educazione del medico di medicina<br />
generale che segue e conosce bene il paziente.<br />
Quest’opera di convincimento è spesso particolarmente<br />
difficile a causa del senso di disagio<br />
che i pazienti manifestano nella comune vita di relazione:<br />
può essere necessario coinvolgere l’entourage<br />
del malato, fornendo informazioni basilari sull’ossigenoterapia<br />
a tutti coloro che ne fanno parte.<br />
Educazione e BPCO<br />
in ventiloterapia domiciliare<br />
Negli ultimi anni il paziente affetto da BPCO in<br />
insufficienza respiratoria globale, in passato purtroppo<br />
considerato per definizione non suscettibile<br />
di intervento terapeutico di tipo ventilatorio,viene<br />
sempre più frequentemente avviato a ventiloterapia<br />
domiciliare, sia pur in alcuni casi selezionati<br />
(in particolare pazienti con severa ipossiemia notturna<br />
o segni di fatica dei muscoli respiratori) e soprattutto<br />
per via non invasiva 17 .<br />
La prescrizione di una protesi ventilatoria domiciliare<br />
comporta la necessità di affrontare e risolvere<br />
numerosi problemi pratici organizzativi e gestionali<br />
e molti problemi relazionali e psicologici che<br />
coinvolgono il paziente e tutta la sua famiglia, modificandone<br />
radicalmente l’impostazione della vita<br />
quotidiana. È evidente, pertanto, che va posta grandissima<br />
attenzione a fornire sia al paziente sia al suo<br />
gruppo familiare tutte le informazioni e le spiegazioni<br />
disponibili sulla necessità e finalità della ventiloterapia,<br />
nonché tutte le informazioni pratiche<br />
per la manutenzione quotidiana dell’apparecchiatura.<br />
Il paziente non potrà essere dimesso dall’ospedale<br />
se non dopo un adeguato training, che deve<br />
coinvolgere anche i suoi familiari, e dopo aver<br />
verificato l’accettazione e la comprensione di alcuni<br />
concetti fondamentali riguardanti questa particolare<br />
terapia. È parimenti molto importante fornire<br />
un supporto psicologico al paziente e alla famiglia<br />
e prevedere la possibilità di prolungare questo<br />
intervento anche dopo le dimissioni in occasione<br />
di controlli ambulatoriali o domiciliari.<br />
Abolizione del fumo<br />
Non sarà mai sottolineato abbastanza che il fumo<br />
di sigaretta costituisce il maggiore fattore di rischio<br />
della BPCO e che la sua sospensione è il solo intervento<br />
terapeutico (con l’OLT nelle fasi avanzate<br />
della malattia) che influenzi la sopravvivenza:<br />
questi dati, di fatto, impongono al medico il dovere<br />
di fare opera di educazione in proposito in ogni<br />
possibile occasione 18 .<br />
Come evidenziato dal Lung Health Study 5 , che negli<br />
USA ha arruolato più di cinquemila pazienti<br />
fumatori con segni di moderata ostruzione bronchiale<br />
indicativi di alto rischio di sviluppare una<br />
BPCO conclamata, un programma aggressivo di<br />
eradicazione dell’abitudine tabagica riduce significativamente<br />
il declino annuale del FEV 1 , fenomeno<br />
che comincia a manifestarsi già dopo un anno<br />
e che la terapia con broncodilatatori accentua solo<br />
in piccola parte. Nonostante questi risultati, è innegabile<br />
che lo sforzo richiesto sia il più delle volte<br />
estremamente oneroso. Sempre nel caso del Lung<br />
Health Study, i pazienti venivano infatti sottoposti<br />
a colloqui individuali con il medico e a successive<br />
frequenti sedute di gruppo (12 incontri in 10 settimane)<br />
guidate da opportune figure sanitarie; in<br />
tale programma venivano considerati anche l’eventuale<br />
instaurazione di un supporto farmacologico<br />
(terapia nicotinica sostitutiva) e un tentativo precoce<br />
“di salvataggio” in caso di ricaduta.<br />
Se quindi ogni iniziativa tesa a strutturare in centri<br />
selezionati unità di riferimento per la cosiddetta<br />
smoking cessation è certamente da considerarsi<br />
di grande utilità e impatto sociale, è pur vero<br />
che anche ogni contatto tra medico e paziente,<br />
dall’ambulatorio territoriale alla corsia ospedaliera,<br />
deve essere visto come un’occasione di intervento.<br />
Anche se i messaggi che si possono trasmettere<br />
sono spesso saltuari e di scarso effetto, essi<br />
hanno il vantaggio della semplicità, dell’economicità<br />
e della vasta quota di soggetti raggiungibili,<br />
per cui in una prospettiva globale i risultati derivabili<br />
non sono poi così inferiori rispetto a quelli<br />
di interventi maggiormente strutturati su piccoli<br />
gruppi di persone.<br />
Alcune considerazioni possono opportunamente<br />
guidare l’intervento di sensibilizzazione alla cessazione<br />
del fumo che il medico può esercitare nella<br />
sua pratica quotidiana.<br />
In primo luogo è evidente che i soggetti maggiormente<br />
motivati hanno le maggiori possibilità di<br />
smettere definitivamente di fumare; tuttavia, anche<br />
in coloro che manifestano le più serie intenzioni il<br />
cammino è spesso tortuoso e costellato di insuccessi<br />
e ricadute. Esistono poi situazioni temporanee<br />
in cui, per una particolare congiuntura psico-<br />
78