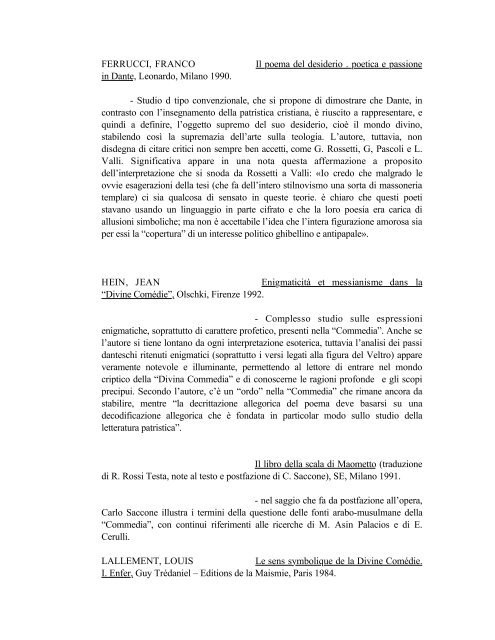Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FERRUCCI, FRANCO Il poema del desiderio . poetica e passione<br />
in Dante, Leonardo, Milano 1990.<br />
- Studio d tipo convenzionale, che si propone di dimostrare che Dante, in<br />
contrasto con l’insegnamento della patristica cristiana, è riuscito a rappresentare, e<br />
quindi a definire, l’oggetto supremo del suo desiderio, cioè il mondo divino,<br />
stabilendo così la supremazia dell’arte sulla teologia. L’autore, tuttavia, non<br />
disdegna di citare critici non sempre ben accetti, come G. Rossetti, G, Pascoli e L.<br />
Valli. Significativa appare in una nota questa affermazione a proposito<br />
dell’interpretazione che si snoda da Rossetti a Valli: «Io credo che malgrado le<br />
ovvie esagerazioni della tesi (che fa dell’intero stilnovismo una sorta di massoneria<br />
templare) ci sia qualcosa di sensato in queste teorie. è chiaro che questi poeti<br />
stavano usando un linguaggio in parte cifrato e che la loro poesia era carica di<br />
allusioni simboliche; ma non è accettabile l’idea che l’intera figurazione amorosa sia<br />
per essi la “copertura” di un interesse politico ghibellino e antipapale».<br />
HEIN, JEAN Enigmaticità et messianisme dans la<br />
“Divine Comédie”, Olschki, Firenze 1992.<br />
- Complesso studio sulle espressioni<br />
enigmatiche, soprattutto di carattere profetico, presenti nella “Commedia”. Anche se<br />
l’autore si tiene lontano da ogni interpretazione esoterica, tuttavia l’analisi dei passi<br />
danteschi ritenuti enigmatici (soprattutto i versi legati alla figura del Veltro) appare<br />
veramente notevole e illuminante, permettendo al lettore di entrare nel mondo<br />
criptico della “Divina Commedia” e di conoscerne le ragioni profonde e gli scopi<br />
precipui. Secondo l’autore, c’è un “ordo” nella “Commedia” che rimane ancora da<br />
stabilire, mentre “la decrittazione allegorica del poema deve bas<strong>ars</strong>i su una<br />
decodificazione allegorica che è fondata in particolar modo sullo studio della<br />
letteratura patristica”.<br />
Il libro della scala di Maometto (traduzione<br />
di R. Rossi Testa, note al testo e postfazione di C. Saccone), SE, Milano 1991.<br />
- nel saggio che fa da postfazione all’opera,<br />
Carlo Saccone illustra i termini della questione delle fonti arabo-musulmane della<br />
“Commedia”, con continui riferimenti alle ricerche di M. Asin Palacios e di E.<br />
Cerulli.<br />
LALLEMENT, LOUIS Le sens symbolique de la Divine Comédie.<br />
I. Enfer, Guy Trédaniel – Editions de la Maismie, Paris 1984.