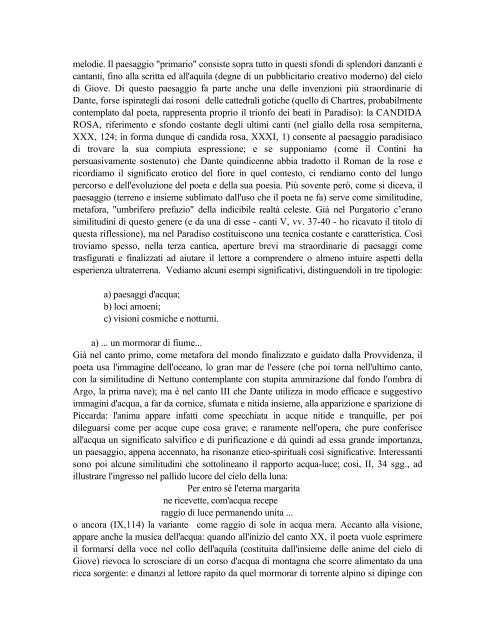You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
melodie. Il paesaggio "primario" consiste sopra tutto in questi sfondi di splendori danzanti e<br />
cantanti, fino alla scritta ed all'aquila (degne di un pubblicitario creativo moderno) del cielo<br />
di Giove. Di questo paesaggio fa parte anche una delle invenzioni più straordinarie di<br />
Dante, forse ispirategli dai rosoni delle cattedrali gotiche (quello di Chartres, probabilmente<br />
contemplato dal poeta, rappresenta proprio il trionfo dei beati in Paradiso): la CANDIDA<br />
ROSA, riferimento e sfondo costante degli ultimi canti (nel giallo della rosa sempiterna,<br />
XXX, 124; in forma dunque di candida rosa, XXXI, 1) consente al paesaggio paradisiaco<br />
di trovare la sua compiuta espressione; e se supponiamo (come il Contini ha<br />
persuasivamente sostenuto) che Dante quindicenne abbia tradotto il Roman de la rose e<br />
ricordiamo il significato erotico del fiore in quel contesto, ci rendiamo conto del lungo<br />
percorso e dell'evoluzione del poeta e della sua poesia. Più sovente però, come si diceva, il<br />
paesaggio (terreno e insieme sublimato dall'uso che il poeta ne fa) serve come similitudine,<br />
metafora, "umbrifero prefazio" della indicibile realtà celeste. Già nel Purgatorio c’erano<br />
similitudini di questo genere (e da una di esse - canti V, vv. 37-40 - ho ricavato il titolo di<br />
questa riflessione), ma nel Paradiso costituiscono una tecnica costante e caratteristica. Così<br />
troviamo spesso, nella terza cantica, aperture brevi ma straordinarie di paesaggi come<br />
trasfigurati e finalizzati ad aiutare il lettore a comprendere o almeno intuire aspetti della<br />
esperienza ultraterrena. Vediamo alcuni esempi significativi, distinguendoli in tre tipologie:<br />
a) paesaggi d'acqua;<br />
b) loci amoeni;<br />
c) visioni cosmiche e notturni.<br />
a) ... un mormorar di fiume...<br />
Già nel canto primo, come metafora del mondo finalizzato e guidato dalla Provvidenza, il<br />
poeta usa l'immagine dell'oceano, lo gran mar de l'essere (che poi torna nell'ultimo canto,<br />
con la similitudine di Nettuno contemplante con stupita ammirazione dal fondo l'ombra di<br />
Argo, la prima nave); ma è nel canto III che Dante utilizza in modo efficace e suggestivo<br />
immagini d'acqua, a far da cornice, sfumata e nitida insieme, alla apparizione e sparizione di<br />
Piccarda: l'anima appare infatti come specchiata in acque nitide e tranquille, per poi<br />
dilegu<strong>ars</strong>i come per acque cupe cosa grave; e raramente nell'opera, che pure conferisce<br />
all'acqua un significato salvifico e di purificazione e dà quindi ad essa grande importanza,<br />
un paesaggio, appena accennato, ha risonanze etico-spirituali così significative. Interessanti<br />
sono poi alcune similitudini che sottolineano il rapporto acqua-luce; cosi, II, 34 sgg., ad<br />
illustrare l'ingresso nel pallido lucore del cielo della luna:<br />
Per entro sé l'eterna margarita<br />
ne ricevette, com'acqua recepe<br />
raggio di luce permanendo unita ...<br />
o ancora (IX,114) la variante come raggio di sole in acqua mera. Accanto alla visione,<br />
appare anche la musica dell'acqua: quando all'inizio del canto XX, il poeta vuole esprimere<br />
il form<strong>ars</strong>i della voce nel collo dell'aquila (costituita dall'insieme delle anime del cielo di<br />
Giove) rievoca lo scrosciare di un corso d'acqua di montagna che scorre alimentato da una<br />
ricca sorgente: e dinanzi al lettore rapito da quel mormorar di torrente alpino si dipinge con