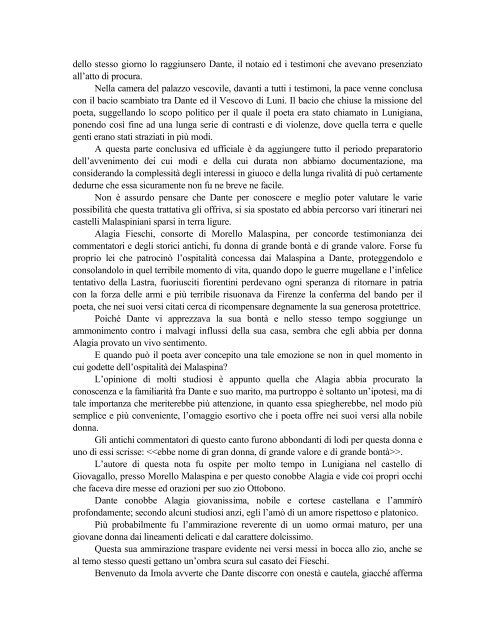You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dello stesso giorno lo raggiunsero Dante, il notaio ed i testimoni che avevano presenziato<br />
all’atto di procura.<br />
Nella camera del palazzo vescovile, davanti a tutti i testimoni, la pace venne conclusa<br />
con il bacio scambiato tra Dante ed il Vescovo di Luni. Il bacio che chiuse la missione del<br />
poeta, suggellando lo scopo politico per il quale il poeta era stato chiamato in Lunigiana,<br />
ponendo così fine ad una lunga serie di contrasti e di violenze, dove quella terra e quelle<br />
genti erano stati straziati in più modi.<br />
A questa parte conclusiva ed ufficiale è da aggiungere tutto il periodo preparatorio<br />
dell’avvenimento dei cui modi e della cui durata non abbiamo documentazione, ma<br />
considerando la complessità degli interessi in giuoco e della lunga rivalità di può certamente<br />
dedurne che essa sicuramente non fu ne breve ne facile.<br />
Non è assurdo pensare che Dante per conoscere e meglio poter valutare le varie<br />
possibilità che questa trattativa gli offriva, si sia spostato ed abbia percorso vari itinerari nei<br />
castelli Malaspiniani sp<strong>ars</strong>i in terra ligure.<br />
Alagia Fieschi, consorte di Morello Malaspina, per concorde testimonianza dei<br />
commentatori e degli storici antichi, fu donna di grande bontà e di grande valore. Forse fu<br />
proprio lei che patrocinò l’ospitalità concessa dai Malaspina a Dante, proteggendolo e<br />
consolandolo in quel terribile momento di vita, quando dopo le guerre mugellane e l’infelice<br />
tentativo della Lastra, fuoriusciti fiorentini perdevano ogni speranza di ritornare in patria<br />
con la forza delle armi e più terribile risuonava da Firenze la conferma del bando per il<br />
poeta, che nei suoi versi citati cerca di ricompensare degnamente la sua generosa protettrice.<br />
Poiché Dante vi apprezzava la sua bontà e nello stesso tempo soggiunge un<br />
ammonimento contro i malvagi influssi della sua casa, sembra che egli abbia per donna<br />
Alagia provato un vivo sentimento.<br />
E quando può il poeta aver concepito una tale emozione se non in quel momento in<br />
cui godette dell’ospitalità dei Malaspina?<br />
L’opinione di molti studiosi è appunto quella che Alagia abbia procurato la<br />
conoscenza e la familiarità fra Dante e suo marito, ma purtroppo è soltanto un’ipotesi, ma di<br />
tale importanza che meriterebbe più attenzione, in quanto essa spiegherebbe, nel modo più<br />
semplice e più conveniente, l’omaggio esortivo che i poeta offre nei suoi versi alla nobile<br />
donna.<br />
Gli antichi commentatori di questo canto furono abbondanti di lodi per questa donna e<br />
uno di essi scrisse: .<br />
L’autore di questa nota fu ospite per molto tempo in Lunigiana nel castello di<br />
Giovagallo, presso Morello Malaspina e per questo conobbe Alagia e vide coi propri occhi<br />
che faceva dire messe ed orazioni per suo zio Ottobono.<br />
Dante conobbe Alagia giovanissima, nobile e cortese castellana e l’ammirò<br />
profondamente; secondo alcuni studiosi anzi, egli l’amò di un amore rispettoso e platonico.<br />
Più probabilmente fu l’ammirazione reverente di un uomo ormai maturo, per una<br />
giovane donna dai lineamenti delicati e dal carattere dolcissimo.<br />
Questa sua ammirazione traspare evidente nei versi messi in bocca allo zio, anche se<br />
al temo stesso questi gettano un’ombra scura sul casato dei Fieschi.<br />
Benvenuto da Imola avverte che Dante discorre con onestà e cautela, giacché afferma