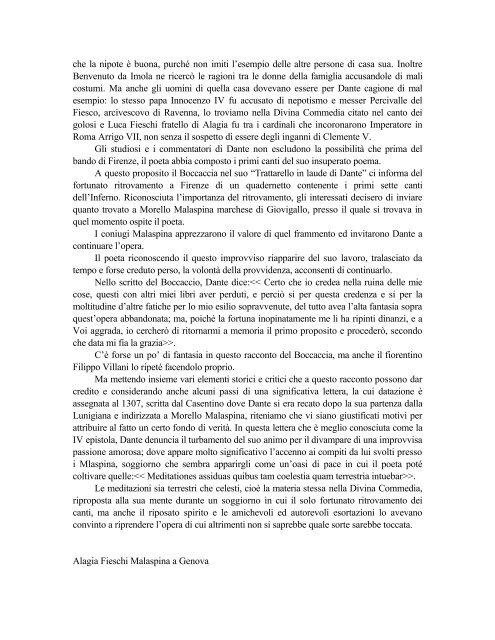You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
che la nipote è buona, purché non imiti l’esempio delle altre persone di casa sua. Inoltre<br />
Benvenuto da Imola ne ricercò le ragioni tra le donne della famiglia accusandole di mali<br />
costumi. Ma anche gli uomini di quella casa dovevano essere per Dante cagione di mal<br />
esempio: lo stesso papa Innocenzo IV fu accusato di nepotismo e messer Percivalle del<br />
Fiesco, arcivescovo di Ravenna, lo troviamo nella Divina Commedia citato nel canto dei<br />
golosi e Luca Fieschi fratello di Alagia fu tra i cardinali che incoronarono Imperatore in<br />
Roma Arrigo VII, non senza il sospetto di essere degli inganni di Clemente V.<br />
Gli studiosi e i commentatori di Dante non escludono la possibilità che prima del<br />
bando di Firenze, il poeta abbia composto i primi canti del suo insuperato poema.<br />
A questo proposito il Boccaccia nel suo “Trattarello in laude di Dante” ci informa del<br />
fortunato ritrovamento a Firenze di un quadernetto contenente i primi sette canti<br />
dell’Inferno. Riconosciuta l’importanza del ritrovamento, gli interessati decisero di inviare<br />
quanto trovato a Morello Malaspina marchese di Giovigallo, presso il quale si trovava in<br />
quel momento ospite il poeta.<br />
I coniugi Malaspina apprezzarono il valore di quel frammento ed invitarono Dante a<br />
continuare l’opera.<br />
Il poeta riconoscendo il questo improvviso riapparire del suo lavoro, tralasciato da<br />
tempo e forse creduto perso, la volontà della provvidenza, acconsentì di continuarlo.<br />
Nello scritto del Boccaccio, Dante dice:>.<br />
C’è forse un po’ di fantasia in questo racconto del Boccaccia, ma anche il fiorentino<br />
Filippo Villani lo ripeté facendolo proprio.<br />
Ma mettendo insieme vari elementi storici e critici che a questo racconto possono dar<br />
credito e considerando anche alcuni passi di una significativa lettera, la cui datazione è<br />
assegnata al 1307, scritta dal Casentino dove Dante si era recato dopo la sua partenza dalla<br />
Lunigiana e indirizzata a Morello Malaspina, riteniamo che vi siano giustificati motivi per<br />
attribuire al fatto un certo fondo di verità. In questa lettera che è meglio conosciuta come la<br />
IV epistola, Dante denuncia il turbamento del suo animo per il divampare di una improvvisa<br />
passione amorosa; dove appare molto significativo l’accenno ai compiti da lui svolti presso<br />
i Mlaspina, soggiorno che sembra apparirgli come un’oasi di pace in cui il poeta poté<br />
coltivare quelle:>.<br />
Le meditazioni sia terrestri che celesti, cioè la materia stessa nella Divina Commedia,<br />
riproposta alla sua mente durante un soggiorno in cui il solo fortunato ritrovamento dei<br />
canti, ma anche il riposato spirito e le amichevoli ed autorevoli esortazioni lo avevano<br />
convinto a riprendere l’opera di cui altrimenti non si saprebbe quale sorte sarebbe toccata.<br />
Alagia Fieschi Malaspina a Genova