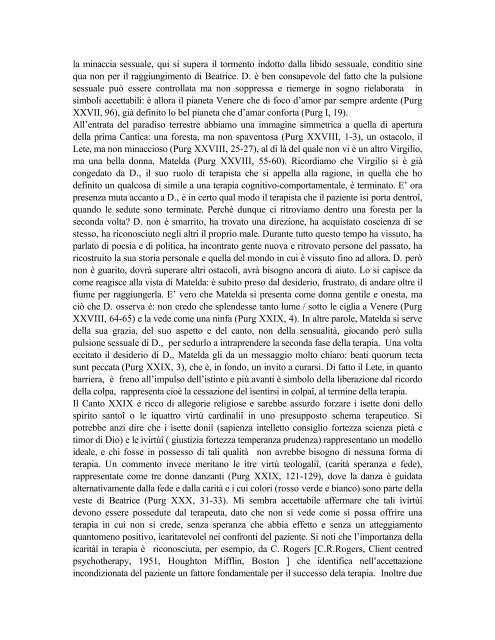You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
la minaccia sessuale, qui si supera il tormento indotto dalla libido sessuale, conditio sine<br />
qua non per il raggiungimento di Beatrice. D. è ben consapevole del fatto che la pulsione<br />
sessuale può essere controllata ma non soppressa e riemerge in sogno rielaborata in<br />
simboli accettabili: è allora il pianeta Venere che di foco d’amor par sempre ardente (Purg<br />
XXVII, 96), già definito lo bel pianeta che d’amar conforta (Purg I, 19).<br />
All’entrata del paradiso terrestre abbiamo una immagine simmetrica a quella di apertura<br />
della prima Cantica: una foresta, ma non spaventosa (Purg XXVIII, 1-3), un ostacolo, il<br />
Lete, ma non minaccioso (Purg XXVIII, 25-27), al di là del quale non vi è un altro Virgilio,<br />
ma una bella donna, Matelda (Purg XXVIII, 55-60). Ricordiamo che Virgilio si è già<br />
congedato da D., il suo ruolo di terapista che si appella alla ragione, in quella che ho<br />
definito un qualcosa di simile a una terapia cognitivo-comportamentale, è terminato. E’ ora<br />
presenza muta accanto a D., è in certo qual modo il terapista che il paziente ìsi porta dentroî,<br />
quando le sedute sono terminate. Perchè dunque ci ritroviamo dentro una foresta per la<br />
seconda volta? D. non è smarrito, ha trovato una direzione, ha acquistato coscienza di se<br />
stesso, ha riconosciuto negli altri il proprio male. Durante tutto questo tempo ha vissuto, ha<br />
parlato di poesia e di politica, ha incontrato gente nuova e ritrovato persone del passato, ha<br />
ricostruito la sua storia personale e quella del mondo in cui è vissuto fino ad allora. D. però<br />
non è guarito, dovrà superare altri ostacoli, avrà bisogno ancora di aiuto. Lo si capisce da<br />
come reagisce alla vista di Matelda: è subito preso dal desiderio, frustrato, di andare oltre il<br />
fiume per raggiungerla. E’ vero che Matelda si presenta come donna gentile e onesta, ma<br />
ciò che D. osserva è: non credo che splendesse tanto lume / sotto le ciglia a Venere (Purg<br />
XXVIII, 64-65) e la vede come una ninfa (Purg XXIX, 4). In altre parole, Matelda si serve<br />
della sua grazia, del suo aspetto e del canto, non della sensualità, giocando però sulla<br />
pulsione sessuale di D., per sedurlo a intraprendere la seconda fase della terapia. Una volta<br />
eccitato il desiderio di D., Matelda gli da un messaggio molto chiaro: beati quorum tecta<br />
sunt peccata (Purg XXIX, 3), che è, in fondo, un invito a cur<strong>ars</strong>i. Di fatto il Lete, in quanto<br />
barriera, è freno all’impulso dell’istinto e più avanti è simbolo della liberazione dal ricordo<br />
della colpa, rappresenta cioè la cessazione del ìsentirsi in colpaî, al termine della terapia.<br />
Il Canto XXIX è ricco di allegorie religiose e sarebbe assurdo forzare i ìsette doni dello<br />
spirito santoî o le ìquattro virtù cardinaliî in uno presupposto schema terapeutico. Si<br />
potrebbe anzi dire che i ìsette doniî (sapienza intelletto consiglio fortezza scienza pietà e<br />
timor di Dio) e le ìvirtùî ( giustizia fortezza temperanza prudenza) rappresentano un modello<br />
ideale, e chi fosse in possesso di tali qualità non avrebbe bisogno di nessuna forma di<br />
terapia. Un commento invece meritano le ìtre virtù teologaliî, (carità speranza e fede),<br />
rappresentate come tre donne danzanti (Purg XXIX, 121-129), dove la danza è guidata<br />
alternativamente dalla fede e dalla carità e i cui colori (rosso verde e bianco) sono parte della<br />
veste di Beatrice (Purg XXX, 31-33). Mi sembra accettabile affermare che tali ìvirtùî<br />
devono essere possedute dal terapeuta, dato che non si vede come si possa offrire una<br />
terapia in cui non si crede, senza speranza che abbia effetto e senza un atteggiamento<br />
quantomeno positivo, ìcaritatevoleî nei confronti del paziente. Si noti che l’importanza della<br />
ìcaritàî in terapia è riconosciuta, per esempio, da C. Rogers [C.R.Rogers, Client centred<br />
psychotherapy, 1951, Houghton Mifflin, Boston ] che identifica nell’accettazione<br />
incondizionata del paziente un fattore fondamentale per il successo dela terapia. Inoltre due