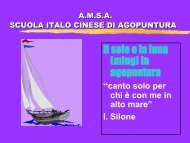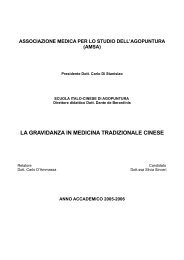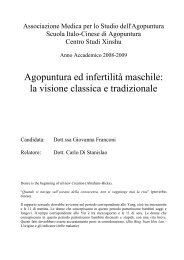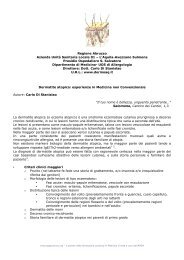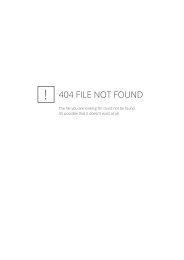ANNO XVI â N. 63 â Dicembre 2012 - Agopuntura.org
ANNO XVI â N. 63 â Dicembre 2012 - Agopuntura.org
ANNO XVI â N. 63 â Dicembre 2012 - Agopuntura.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
11 “Ettore e Andromaca”, Gi<strong>org</strong>io De Chirico. Nel 1917, anno della creazione del capolavoro, l’Italia è in guerra e Gi<strong>org</strong>io De Chirico si trovanell’Ospedale di Ferrara, dove, essendo considerato inabile all’attività, svolge un lavoro sedentario. In quell’ambiente l’artista conosce Carlo Carrà,fondatore nel 1910 assieme a Marinetti, Boccioni, Russolo, Balla e Severini del movimento futurista – e tra i due nasce un sodalizio, che sfocerànella creazione della cosiddetta “pittura metafisica“, teorizzata di lì a poco sulla rivista “Valori Plastici“. Tale corrente è ben sintetizzata da una frasepronunciata dallo stesso De Chirico: “Schopenhauer e Nietzsche per primi insegnarono il profondo significato del non senso della vita e come talenon senso potesse venire tramutato in arte”. Ettore sta andando a combattere con Achille. Andromaca chiede sue notizie e lo insegue fino alleporte Sce. Lo ferma e lo implora di non andare. Ettore e costretto, è il principe di Troia e le dice che per onore deve andare in contro a quella chesicuro è la morte. Ettore vive in quella che è definita la socetà "della vergogna" dove al di sopra di tutto c'è l'onore e se un uomo non conduce unavita onorevole è immerso nella "vergogna" Andromaca è disperata, sa che alla sua morte lei sarà fatta schiava dagli achei (greci) e il figlio ucciso. Perun momento si dedicano a speranza senza fondamento sognando il figlio un giorno un fortre uomo di cui tutti diranno "di sicuro è meglio di suopadre". Anche bellissima (e significativa) la scena in cui Ettore saluta il figlio per l'ultima volta ma questi piange spaventato dall'enorme elmo delpadre. Sorride Ettore guardando il bambino in silenzio. Andromaca gli viene vicino, bagnando il viso di lacrime, lo sfiora con la mano e dice:"Sventurato, il tuo ardore sarà la tua rovina, e tu non hai pietà di tuo figlio che non parla ancora, nè di me disgraziata, che sarò presto la tua vedova:presto ti uccideranno gli Achei tutti insieme saltandoti addosso; sarebbe meglio per me scendere sotto terra, se restassi senza di te, perchè nonavrò alcun altro conforto, quando tu abbia seguito il destino, ma solo dolori: io non ho nè padre nè madre”. Enrico Berti, riprendendo il pensiero diuno dei più grandi storici della cultura greca, Werner Jaeger, ma anche quello di altri filosofi, come Hegel, analizza i modelli ideali di umanità, chesono stai elaborati nell’antichità. L’Autore riconosce che il modello ideale di umanità che viene proposto dai filosofi greci del VI-V secolo a.C. ècostituito dal cittadino della polis che si caratterizza per virtù civiche e politiche, non per virtù militari o per forza e capacità di combattimento, virtùche, come è noto, sono peculiarità degli eroi omerici. Tornando al quadro di De Chirico, esso è, senza dubbio, prima di tutto, un devoto omaggioalla grecità, memoria dell’età infantile di de Chirico; in secondo luogo, un riconoscimento al valore del mito, che ci riporta all’alba dell’umanità (lapreistoria) e al mattino della vita (l’infanzia); infine, ma in special modo, un tributo al misterioso enigma rappresentato dal tempo, che si vuole incerta misura quasi esorcizzare. Ettore e Andromaca, ai quali è dedicata una parte consistente del libro VI dell’Iliade, nel quadro dechirichiano, puressendo manichini senza arti superiori, sembrano cercare, senza riuscirvi, di abbracciarsi, sprigionando così uno struggente sentimento dimalinconia: si osservi la disposizione delle gambe e soprattutto l’inclinazione del capo dell’eroe troiano. Riecheggiano i versi omerici (nella poeticatraduzione di Vincenzo Monti): “Ma di gran pianto Andromaca bagnata, / accostossi al marito, e per la mano / stringendolo, e per nome in dolcesuono / chiamandolo, proruppe: Oh, troppo ardito! / Il tuo valor ti perderà: nessuna / pietà del figlio né di me tu senti, / crudel, di me, che vedovainfelice / rimarrommi tra poco, perché tutti / di conserto gli Achei contro te solo / si scaglieranno, a trucidarti intesi! / […] Dolce consorte, le risposeEttorre, / ciò tutto che dicesti a me pur anco / ange il pensier; ma de’ Troiani io temo / fortemente lo spregio, e dell’altere / troiane donne, seguerrier codardo / mi tenessi in disparte, e della pugna / evitassi i cimenti. Ah! nol consente, / no, questo cor. Da lungo tempo appresi / ad esserforte, ed a volar tra’ primi / negli acerbi conflitti, alla tutela / della paterna gloria e della mia. / Giorno verrà, presàgo il cor mel dice, / verrà giornoche il sacro iliaco muro / e Priamo e tutta la sua gente cada. / […] Di secreta pietà l’alma percosso, / riguardolla il marito, e colla mano /accarezzando la dolente: Oh! disse, / diletta mia, ti prego; oltre misura non attristarti a mia cagion. Nessuno, / se il mio punto fatal non giunseancora, / spingerammi a Pluton: ma nullo al mondo, / sia vil, sia forte, si sottragge al fato”. Il problema, che si pone a questo punto, è comeinterpretare il concetto di tempo in questa scena drammatica d’amore, se si tengono presenti le concezioni filosofiche prima ricordate,specialmente quelle antitetiche di Nietzsche e di Weininger. ttore e la consorte sono consapevoli della inesorabilità del destino e, nonostante tutto,5