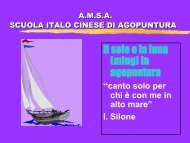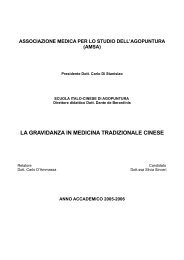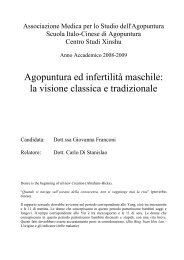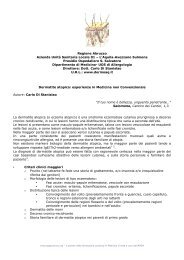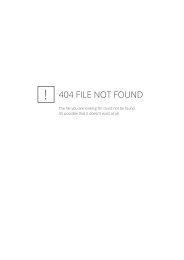ANNO XVI â N. 63 â Dicembre 2012 - Agopuntura.org
ANNO XVI â N. 63 â Dicembre 2012 - Agopuntura.org
ANNO XVI â N. 63 â Dicembre 2012 - Agopuntura.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
essi, venne fondata una Missione gesuita in Cina 4 , che, con Matteo Ricci, produsse unainteressante analisi di confronto fra confucianesimo e cristianesimo 5 iii . Ma la Cina hagrande poeta e pittore fu Wang Wei. Di quest'epoca è l'invenzione della stampa (VIII sec.) e l'introduzione dell'uso della carta moneta. Nel campodella ceramica la dinastia Tang è conosciuta soprattutto per le sue figurine di terracotta di stile realistico. Ma quest'arte produce anche pezzi rari; siottiene la porcellana, grazie ad una argilla speciale portata a più di 1.300 gradi; compaiono i "céladon" verde-azzurri. Nel campo delle istituzionigiuridiche troviamo il codice Tang, redatto nella sua prima forma nel 624, rivisto nel 627 e <strong>63</strong>7 e seguito da un commento nel 653. Questo è il primocodice cinese pervenutoci; si tratta di un'opera ammirevole per la sua logicità, conta 500 articoli divisi in 12 sezioni. Durante tale periodo moltoconsiderato fu anche il buddismo, mentre avversato fu il taoismo. Nel l 683 muore l'imperatore, all’età di ha sessant'anni e l’imperatrice Wu Zetianche pone sul trono suo figlio; ma dopo appena 54 giorni lo detronizza e nomina imperatore il suo secondogenito, che imprigiona nel palazzo.Scoppia una rivolta di 100.000 ribelli, ma riesce a soffocarla nel sangue. L’imperatrice, fervente buddista, vuole fondare una dinastia che porterà ilsuo nome. I principi della famiglia Tang si rivoltano e allora ne approfitta per far scomparire tutta la famiglia imperiale giustiziando o mandando inesilio uomini, donne e bambini; le purghe durano due anni. Come detto, Wu Zetian era una fervente buddhista e la sua scalata al potere fuappoggiata dai buddhisti, che finiscono per riconoscerla come reincarnazione del bodhisattva Maitreya. Per sfuggire al controllo delle grandifamiglie trasferì la capitale a Luoyang e si proclamò imperatrice di una nuova dinastia, la Zhou.3 Le vicende delle missioni francescane in Cina, possono essere raggruppate in 5 periodi. Nel primo periodo, dal 1245 fin verso il 1370, i Frati Minorivennero inviati in estremo Oriente come Ambasciatori di pace e Ambasciatori della fede. Di particolare rilievo in questo periodo fu l’opera educativadi fra Giovanni da Montecorvino e il suo sforzo di inculturare la liturgia traducendo il Salterio e il Nuovo Testamento nella lingua dei Tartari, cheerano i dominatori del momento. Secondo un calcolo da verificare ulteriormente, sarebbero andati in Cina in questo periodo circa 242 Frati Minori,tra i quali vi furono 3 Arcivescovi e 11 Vescovi. Con la presa del potere da parte della dinastia cinese dei Ming (1368-1644) la religione cristianavenne rifiutata soprattutto in quanto dottrina straniera.Nella seconda metà del <strong>XVI</strong>I secolo, con al potere la dinastia dei Qing (1644-1912), lecondizioni per le missioni divennero nuovamente favorevoli. Il secondo periodo delle missioni francescane in Cina fu caratterizzato dal problemadell’inculturazione e da diverse persecuzioni, ad ondate successive, dalla seconda metà del <strong>XVI</strong>II secolo fino ai primi decenni del secolo XIX. Il terzoperiodo è quello dell’epoca del neo-colonialismo ottocentesco. La seconda metà del secolo XIX vide una rinascita anche delle missioni francescanein Cina: numerosi Frati Minori partirono dall’Europa per diffondere il Vangelo in Cina, dove si dedicarono con grande generosità anche ad opereumanitarie come l’educazione dei giovani, gli istituti per le ragazze abbandonate e sfruttate, gli orfanotrofi, la cura dei malati. La protezionediplomatica dei missionari faceva però passare la Chiesa per uno strumento al servizio dell’espansionismo occidentale, così i fautori del movimentoanti-cristiano attizzarono l’odio contro gli stranieri e provocarono sommosse, omicidi, distruzioni in varie parti della Cina, che culminarono con larivolta dei Boxers nel 1900. Agli inizi del secolo XX i Frati Minori avevano la cura di 10 Vicariati apostolici, dal nord al sud della Cina, con moltissimecomunità cristiane e tante postazioni missionarie. La rivolta di Wuchang nel 1911 portò alla fine della dinastia Qing e alla proclamazione dellaRepubblica di Cina. Questo può essere considerato il quarto periodo delle missioni francescane con la massima fioritura e con la partecipazione diun gran numero di missionari. Anche in questo periodo non mancarono comunque le difficoltà, tra cui il coinvolgimento delle missioni cattolichenelle vicende della seconda guerra mondiale. Questo fu il periodo della nascita della Chiesa cattolica in Cina: Pio XII costituì la Gerarchia episcopalecinese nel 1946. Nel 1948 vi erano in Cina 706 frati minori, dei quali 150 indigeni, e 28 conventi. L’ultimo periodo è quello della Repubblica PopolareCinese (dal 1949 ad oggi). Con la presa del potere del regime marxista-maoista, le missioni cattoliche furono fatte oggetto dell’ira antistraniera edenunciate come strumenti dell’imperialismo occidentale, tutti i missionari stranieri vennero espulsi.Agli anni più difficili, dal 1966 al 1976, è seguitoun periodo di progressiva, anche se timida, apertura che ha permesso di ricostituire anche la presenza francescana in Cina. Secondo il Necrologiodei Frati cinesi, dal 1200 al 1977 si registrano 1.162 Frati Minori vissuti in Cina.4 I gesuiti giunsero in Cina nel 1582, dopo aver ottenuto dal papa il “diritto religioso” sui nuovi territori estremo orientali, che essi raggiunsero sullascia dei mercanti portoghesi, per opera di Francesco Saverio, gesuita e missionario spagnolo, proclamato santonel 1622, da papa Gregorio XV. Iprimi gesuiti ad ottenere il permesso di entrare nel territorio cinese furono, appunto nel 1582, Michele Ruggieri e Matteo Ricci, che dopo averfondato, dal 1583, diverse residenze in varie città della Cina, riuscì a stabilirsi nella capitale nel 1601, e cominciò il suo lavoro presso i letterati dellacorte.5 Dal 1595 cominciò a comporre libri di scienze e di religione: le sue opere, accolte con singolare favore e ammirazione, trattavano di cartografia,matematica, filosofia morale, teologia e apologetica. Tra i lavori scientifici emerge il grande Mappamondo cinese (misure: m 3,75 x 1,80); la primaedizione di Qujiang, di cui si è già accennato, venne perfezionata a Nanchino e a Pechino, dove fu fatta la sesta edizione nel 1607. L'imperatorestesso ne fu talmente entusiasta che nel 1608 ne fece fare una nuova ristampa e ne chiese 12 copie per sé. Copie di questo Mappamondo cinese nerimangono, presentemente, a Pechino, Londra e nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Il Ricci vi raffigurò i continenti e le isole fino allora scoperti.Così veniva portata a conoscenza dei cinesi l'esistenza di molti nuovi e lontani Paesi e, quindi, della stessa Europa. Vicino ai nomi delle principalilocalità il Ricci annotò notizie storiche; per esempio, vicino al nome "Giudea" si legge: "Il Signore del Cielo s'è incarnato in questo Paese, perciò sichiama Terra Santa". Vicino al nome "Italia": "Qui il Re della Civiltà (= Papa), nel celibato, si occupa unicamente di religione. Egli è venerato da tutti isudditi degli Stati d'Europa, che formano il romano impero". Questa breve notizia sul Papa diede ai cinesi un'alta idea del pontificato romano. Oltrea far conoscere la religione cattolica ai cinesi, il Mappamondo serviva anche a dissipare dalla loro mente il pregiudizio, secondo il quale tutti quelliche non erano cinesi venivano considerati "barbari". I "Dieci paradossi" (Qiren Shipian), opera di carattere morale, venne stampata nel 1607. Il titolocinese significa propriamente: "Dieci capitoli di un uomo strano". L'uomo strano è il Ricci, considerato singolare dai cinesi, oltre che per le suecaratteristiche somatiche europee e per la sua barba fluente, soprattutto per la sua prodigiosa memoria, per l'inesplicabile celibato, per la sua fedein Dio da lui professata apertamente. L'appellativo di "strano" assumeva un significato benevolo presso i cinesi, i quali vi vedevano un'allusione auna celebre frase di Confucio: "L'uomo è strano per gli uomini, ma è simile a Dio”. Nato in una famiglia protestante americana e sepolto nell’areaevangelica del cimitero di San Michele a Venezia, il grande poeta Ezra Pound mostrò tuttavia in più occasioni uno spiccato interesse per la tradizionecattolica e la dottrina sociale della Chiesa di Roma. Tra l’altro apprezzava proprio gli aspetti della religiosità mediterranea — il culto dei santi e diMaria, certi riti popolari legati ai ritmi delle stagioni— che solitamente calvinisti e luterani giudicano superstiziosi o paganeggianti. Si tratta di unodei tanti aspetti curiosi che emergono nel saggio di Andrea Colombo “Il Dio di Ezra Pound. Cattolicesimo e religioni del mistero” (Edizioni Ares). Quila complessa spiritualità del poeta americano viene analizzata nei dettagli, anche sulla base di alcuni documenti inediti forniti dalla figlia Mary deRachewiltz al direttore della casa editrice, Cesare Cavalleri. La stessa signora de Rachewiltz ha scritto l’introduzione del volume e concesso aColombo un’intervista sul rapporto tra suo padre e la dimensione del sacro. di certo a Pound non importa affatto l’ortodossia dogmatica edottrinale. Infatti nel cattolicesimo lo attrae molto la vicinanza agli antichi culti misterici. E più in generale tende a valorizzare le influenze di originepoliteista pagana. Guarda inoltre con estrema simpatia al missionario gesuita Matteo Ricci e al suo dialogo con la civiltà confuciana cinese, di cui eragrande cultore. Anche l’amore di Pound per una figura come San Francesco d’Assisi, di cui tradusse il Cantico delle creature, ha dei risvolti quasipanteistici nel richiamo all’armonia di fondo tra uomo e natura. Altrettanto francescano è poi il pacifismo del poeta, con l’ostilità alla guerra e almilitarismo che lo caratterizza sin dal primo conflitto mondiale e che può apparire in flagrante contraddizione con le sue simpatie fasciste. Eppure,sostiene Colombo nel libro, anche i radiodiscorsi bellici di Pound, “infarciti di retorica mussoliniana” , si potrebbero rileggere come “disperati appelli93