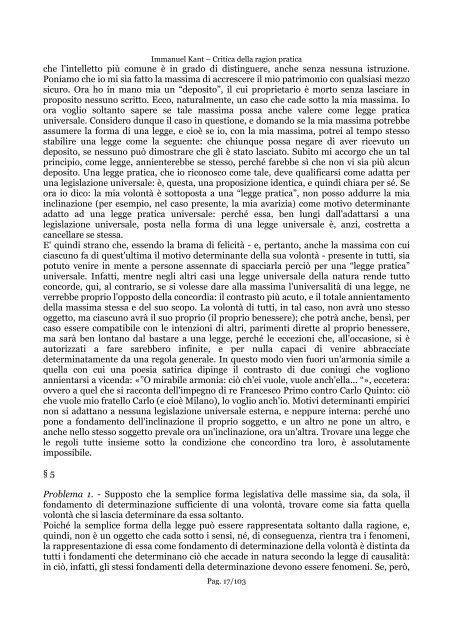CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
che l'intelletto più comune è in grado di distinguere, anche senza nessuna istruzione.<br />
Poniamo che io mi sia fatto la massima di accrescere il mio patrimonio con qualsiasi mezzo<br />
sicuro. Ora ho in mano mia un “deposito”, il cui proprietario è morto senza lasciare in<br />
proposito nessuno scritto. Ecco, natural<strong>mente</strong>, un caso che cade sotto la mia massima. Io<br />
ora voglio soltanto sapere se tale massima possa anche valere come legge pratica<br />
universale. Considero dunque il caso in questione, e domando se la mia massima potrebbe<br />
assumere la forma di una legge, e cioè se io, con la mia massima, potrei al tempo stesso<br />
stabilire una legge come la seguente: che chiunque possa negare di aver ricevuto un<br />
deposito, se nessuno può dimostrare che gli è stato lasciato. Subito mi accorgo che un tal<br />
principio, come legge, annienterebbe se stesso, perché farebbe sì che non vi sia più alcun<br />
deposito. Una legge pratica, che io riconosco come tale, deve qualificarsi come adatta per<br />
una legislazione universale: è, questa, una proposizione identica, e quindi chiara per sé. Se<br />
ora io dico: la mia volontà è sottoposta a una “legge pratica”, non posso addurre la mia<br />
inclinazione (per esempio, nel caso presente, la mia avarizia) come motivo determinante<br />
adatto ad una legge pratica universale: perché essa, ben lungi dall'adattarsi a una<br />
legislazione universale, posta nella forma di una legge universale è, anzi, costretta a<br />
cancellare se stessa.<br />
E' quindi strano che, essendo la brama di felicità - e, pertanto, anche la massima con cui<br />
ciascuno fa di quest'ultima il motivo determinante <strong>della</strong> sua volontà - presente in tutti, sia<br />
potuto venire in <strong>mente</strong> a persone assennate di spacciarla perciò per una “legge pratica”<br />
universale. Infatti, mentre negli altri casi una legge universale <strong>della</strong> natura rende tutto<br />
concorde, qui, al contrario, se si volesse dare alla massima l'universalità di una legge, ne<br />
verrebbe proprio l'opposto <strong>della</strong> concordia: il contrasto più acuto, e il totale annientamento<br />
<strong>della</strong> massima stessa e del suo scopo. La volontà di tutti, in tal caso, non avrà uno stesso<br />
oggetto, ma ciascuno avrà il suo proprio (il proprio benessere); che potrà anche, bensì, per<br />
caso essere compatibile con le intenzioni di altri, parimenti dirette al proprio benessere,<br />
ma sarà ben lontano dal bastare a una legge, perché le eccezioni che, all'occasione, si è<br />
autorizzati a fare sarebbero infinite, e per nulla capaci di venire abbracciate<br />
determinata<strong>mente</strong> da una regola generale. In questo modo vien fuori un'armonia simile a<br />
quella con cui una poesia satirica dipinge il contrasto di due coniugi che vogliono<br />
annientarsi a vicenda: «”O mirabile armonia: ciò ch'ei vuole, vuole anch'ella... “», eccetera:<br />
ovvero a quel che si racconta dell'impegno di re Francesco Primo contro Carlo Quinto: ciò<br />
che vuole mio fratello Carlo (e cioè Milano), lo voglio anch'io. Motivi determinanti empirici<br />
non si adattano a nessuna legislazione universale esterna, e neppure interna: perché uno<br />
pone a fondamento dell'inclinazione il proprio soggetto, e un altro ne pone un altro, e<br />
anche nello stesso soggetto prevale ora un'inclinazione, ora un'altra. Trovare una legge che<br />
le regoli tutte insieme sotto la condizione che concordino tra loro, è assoluta<strong>mente</strong><br />
impossibile.<br />
§ 5<br />
Problema 1. - Supposto che la semplice forma legislativa delle massime sia, da sola, il<br />
fondamento di determinazione sufficiente di una volontà, trovare come sia fatta quella<br />
volontà che si lascia determinare da essa soltanto.<br />
Poiché la semplice forma <strong>della</strong> legge può essere rappresentata soltanto dalla ragione, e,<br />
quindi, non è un oggetto che cada sotto i sensi, né, di conseguenza, rientra tra i fenomeni,<br />
la rappresentazione di essa come fondamento di determinazione <strong>della</strong> volontà è distinta da<br />
tutti i fondamenti che determinano ciò che accade in natura secondo la legge di causalità:<br />
in ciò, infatti, gli stessi fondamenti <strong>della</strong> determinazione devono essere fenomeni. Se, però,<br />
Pag. 17/103