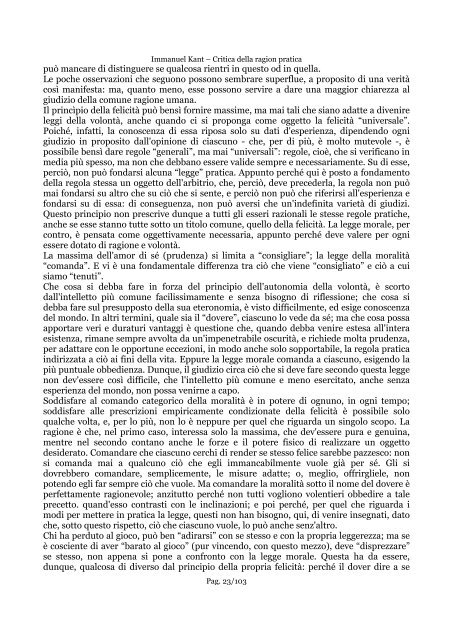CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
può mancare di distinguere se qualcosa rientri in questo od in quella.<br />
Le poche osservazioni che seguono possono sembrare superflue, a proposito di una verità<br />
così manifesta: ma, quanto meno, esse possono servire a dare una maggior chiarezza al<br />
giudizio <strong>della</strong> comune ragione umana.<br />
Il princìpio <strong>della</strong> felicità può bensì fornire massime, ma mai tali che siano adatte a divenire<br />
leggi <strong>della</strong> volontà, anche quando ci si proponga come oggetto la felicità “universale”.<br />
Poiché, infatti, la conoscenza di essa riposa solo su dati d'esperienza, dipendendo ogni<br />
giudizio in proposito dall'opinione di ciascuno - che, per di più, è molto mutevole -, è<br />
possibile bensì dare regole “generali”, ma mai “universali”: regole, cioè, che si verificano in<br />
media più spesso, ma non che debbano essere valide sempre e necessaria<strong>mente</strong>. Su di esse,<br />
perciò, non può fondarsi alcuna “legge” pratica. Appunto perché qui è posto a fondamento<br />
<strong>della</strong> regola stessa un oggetto dell'arbitrio, che, perciò, deve precederla, la regola non può<br />
mai fondarsi su altro che su ciò che si sente, e perciò non può che riferirsi all'esperienza e<br />
fondarsi su di essa: di conseguenza, non può aversi che un'indefinita varietà di giudizi.<br />
Questo principio non prescrive dunque a tutti gli esseri razionali le stesse regole pratiche,<br />
anche se esse stanno tutte sotto un titolo comune, quello <strong>della</strong> felicità. La legge morale, per<br />
contro, è pensata come oggettiva<strong>mente</strong> necessaria, appunto perché deve valere per ogni<br />
essere dotato di ragione e volontà.<br />
La massima dell'amor di sé (prudenza) si limita a “consigliare”; la legge <strong>della</strong> moralità<br />
“comanda”. E vi è una fondamentale differenza tra ciò che viene “consigliato” e ciò a cui<br />
siamo “tenuti”.<br />
Che cosa si debba fare in forza del principio dell'autonomia <strong>della</strong> volontà, è scorto<br />
dall'intelletto più comune facilissima<strong>mente</strong> e senza bisogno di riflessione; che cosa si<br />
debba fare sul presupposto <strong>della</strong> sua eteronomia, è visto difficil<strong>mente</strong>, ed esige conoscenza<br />
del mondo. In altri termini, quale sia il “dovere”, ciascuno lo vede da sé; ma che cosa possa<br />
apportare veri e duraturi vantaggi è questione che, quando debba venire estesa all'intera<br />
esistenza, rimane sempre avvolta da un'impenetrabile oscurità, e richiede molta prudenza,<br />
per adattare con le opportune eccezioni, in modo anche solo sopportabile, la regola pratica<br />
indirizzata a ciò ai fini <strong>della</strong> vita. Eppure la legge morale comanda a ciascuno, esigendo la<br />
più puntuale obbedienza. Dunque, il giudizio circa ciò che si deve fare secondo questa legge<br />
non dev'essere così difficile, che l'intelletto più comune e meno esercitato, anche senza<br />
esperienza del mondo, non possa venirne a capo.<br />
Soddisfare al comando categorico <strong>della</strong> moralità è in potere di ognuno, in ogni tempo;<br />
soddisfare alle prescrizioni empirica<strong>mente</strong> condizionate <strong>della</strong> felicità è possibile solo<br />
qualche volta, e, per lo più, non lo è neppure per quel che riguarda un singolo scopo. La<br />
ragione è che, nel primo caso, interessa solo la massima, che dev'essere pura e genuina,<br />
mentre nel secondo contano anche le forze e il potere fisico di realizzare un oggetto<br />
desiderato. Comandare che ciascuno cerchi di render se stesso felice sarebbe pazzesco: non<br />
si comanda mai a qualcuno ciò che egli immancabil<strong>mente</strong> vuole già per sé. Gli si<br />
dovrebbero comandare, semplice<strong>mente</strong>, le misure adatte; o, meglio, offrirgliele, non<br />
potendo egli far sempre ciò che vuole. Ma comandare la moralità sotto il nome del dovere è<br />
perfetta<strong>mente</strong> ragionevole; anzitutto perché non tutti vogliono volentieri obbedire a tale<br />
precetto. quand'esso contrasti con le inclinazioni; e poi perché, per quel che riguarda i<br />
modi per mettere in pratica la legge, questi non han bisogno, qui, di venire insegnati, dato<br />
che, sotto questo rispetto, ciò che ciascuno vuole, lo può anche senz'altro.<br />
Chi ha perduto al gioco, può ben “adirarsi” con se stesso e con la propria leggerezza; ma se<br />
è cosciente di aver “barato al gioco” (pur vincendo, con questo mezzo), deve “disprezzare”<br />
se stesso, non appena si pone a confronto con la legge morale. Questa ha da essere,<br />
dunque, qualcosa di diverso dal principio <strong>della</strong> propria felicità: perché il dover dire a se<br />
Pag. 23/103