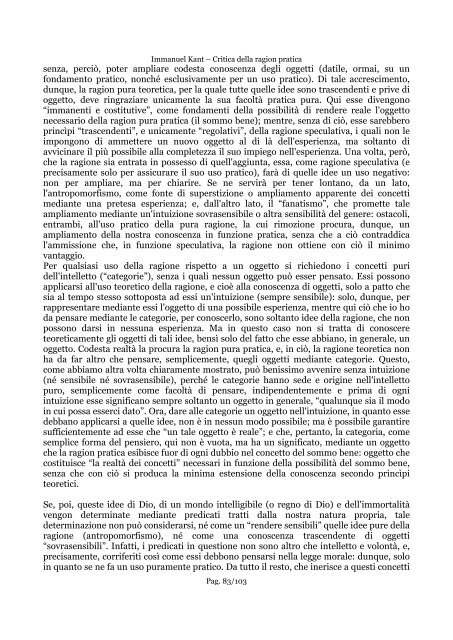CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
senza, perciò, poter ampliare codesta conoscenza degli oggetti (datile, ormai, su un<br />
fondamento pratico, nonché esclusiva<strong>mente</strong> per un uso pratico). Di tale accrescimento,<br />
dunque, la ragion pura teoretica, per la quale tutte quelle idee sono trascendenti e prive di<br />
oggetto, deve ringraziare unica<strong>mente</strong> la sua facoltà pratica pura. Qui esse divengono<br />
“immanenti e costitutive”, come fondamenti <strong>della</strong> possibilità di rendere reale l'oggetto<br />
necessario <strong>della</strong> ragion pura pratica (il sommo bene); mentre, senza di ciò, esse sarebbero<br />
princìpi “trascendenti”, e unica<strong>mente</strong> “regolativi”, <strong>della</strong> ragione speculativa, i quali non le<br />
impongono di ammettere un nuovo oggetto al di là dell'esperienza, ma soltanto di<br />
avvicinare il più possibile alla completezza il suo impiego nell'esperienza. Una volta, però,<br />
che la ragione sia entrata in possesso di quell'aggiunta, essa, come ragione speculativa (e<br />
precisa<strong>mente</strong> solo per assicurare il suo uso pratico), farà di quelle idee un uso negativo:<br />
non per ampliare, ma per chiarire. Se ne servirà per tener lontano, da un lato,<br />
l'antropomorfismo, come fonte di superstizione o ampliamento apparente dei concetti<br />
mediante una pretesa esperienza; e, dall'altro lato, il “fanatismo”, che promette tale<br />
ampliamento mediante un'intuizione sovrasensibile o altra sensibilità del genere: ostacoli,<br />
entrambi, all'uso pratico <strong>della</strong> pura ragione, la cui rimozione procura, dunque, un<br />
ampliamento <strong>della</strong> nostra conoscenza in funzione pratica, senza che a ciò contraddica<br />
l'ammissione che, in funzione speculativa, la ragione non ottiene con ciò il minimo<br />
vantaggio.<br />
Per qualsiasi uso <strong>della</strong> ragione rispetto a un oggetto si richiedono i concetti puri<br />
dell'intelletto (“categorie”), senza i quali nessun oggetto può esser pensato. Essi possono<br />
applicarsi all'uso teoretico <strong>della</strong> ragione, e cioè alla conoscenza di oggetti, solo a patto che<br />
sia al tempo stesso sottoposta ad essi un'intuizione (sempre sensibile): solo, dunque, per<br />
rappresentare mediante essi l'oggetto di una possibile esperienza, mentre qui ciò che io ho<br />
da pensare mediante le categorie, per conoscerlo, sono soltanto idee <strong>della</strong> ragione, che non<br />
possono darsi in nessuna esperienza. Ma in questo caso non si tratta di conoscere<br />
teoretica<strong>mente</strong> gli oggetti di tali idee, bensì solo del fatto che esse abbiano, in generale, un<br />
oggetto. Codesta realtà la procura la ragion pura pratica, e, in ciò, la ragione teoretica non<br />
ha da far altro che pensare, semplice<strong>mente</strong>, quegli oggetti mediante categorie. Questo,<br />
come abbiamo altra volta chiara<strong>mente</strong> mostrato, può benissimo avvenire senza intuizione<br />
(né sensibile né sovrasensibile), perché le categorie hanno sede e origine nell'intelletto<br />
puro, semplice<strong>mente</strong> come facoltà di pensare, indipendente<strong>mente</strong> e prima di ogni<br />
intuizione esse significano sempre soltanto un oggetto in generale, “qualunque sia il modo<br />
in cui possa esserci dato”. Ora, dare alle categorie un oggetto nell'intuizione, in quanto esse<br />
debbano applicarsi a quelle idee, non è in nessun modo possibile; ma è possibile garantire<br />
sufficiente<strong>mente</strong> ad esse che “un tale oggetto è reale”; e che, pertanto, la categoria, come<br />
semplice forma del pensiero, qui non è vuota, ma ha un significato, mediante un oggetto<br />
che la ragion pratica esibisce fuor di ogni dubbio nel concetto del sommo bene: oggetto che<br />
costituisce “la realtà dei concetti” necessari in funzione <strong>della</strong> possibilità del sommo bene,<br />
senza che con ciò si produca la minima estensione <strong>della</strong> conoscenza secondo princìpi<br />
teoretici.<br />
Se, poi, queste idee di Dio, di un mondo intelligibile (o regno di Dio) e dell'immortalità<br />
vengon determinate mediante predicati tratti dalla nostra natura propria, tale<br />
determinazione non può considerarsi, né come un “rendere sensibili” quelle idee pure <strong>della</strong><br />
ragione (antropomorfismo), né come una conoscenza trascendente di oggetti<br />
“sovrasensibili”. Infatti, i predicati in questione non sono altro che intelletto e volontà, e,<br />
precisa<strong>mente</strong>, corriferiti così come essi debbono pensarsi nella legge morale: dunque, solo<br />
in quanto se ne fa un uso pura<strong>mente</strong> pratico. Da tutto il resto, che inerisce a questi concetti<br />
Pag. 83/103