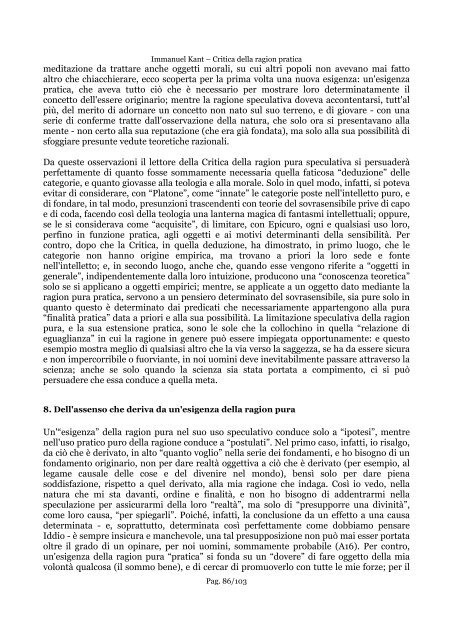CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
meditazione da trattare anche oggetti morali, su cui altri popoli non avevano mai fatto<br />
altro che chiacchierare, ecco scoperta per la prima volta una nuova esigenza: un'esigenza<br />
pratica, che aveva tutto ciò che è necessario per mostrare loro determinata<strong>mente</strong> il<br />
concetto dell'essere originario; mentre la ragione speculativa doveva accontentarsi, tutt'al<br />
più, del merito di adornare un concetto non nato sul suo terreno, e di giovare - con una<br />
serie di conferme tratte dall'osservazione <strong>della</strong> natura, che solo ora si presentavano alla<br />
<strong>mente</strong> - non certo alla sua reputazione (che era già fondata), ma solo alla sua possibilità di<br />
sfoggiare presunte vedute teoretiche razionali.<br />
Da queste osservazioni il lettore <strong>della</strong> Critica <strong>della</strong> ragion pura speculativa si persuaderà<br />
perfetta<strong>mente</strong> di quanto fosse somma<strong>mente</strong> necessaria quella faticosa “deduzione” delle<br />
categorie, e quanto giovasse alla teologia e alla morale. Solo in quel modo, infatti, si poteva<br />
evitar di considerare, con “Platone”, come “innate” le categorie poste nell'intelletto puro, e<br />
di fondare, in tal modo, presunzioni trascendenti con teorie del sovrasensibile prive di capo<br />
e di coda, facendo così <strong>della</strong> teologia una lanterna magica di fantasmi intellettuali; oppure,<br />
se le si considerava come “acquisite”, di limitare, con Epicuro, ogni e qualsiasi uso loro,<br />
perfino in funzione pratica, agli oggetti e ai motivi determinanti <strong>della</strong> sensibilità. Per<br />
contro, dopo che la Critica, in quella deduzione, ha dimostrato, in primo luogo, che le<br />
categorie non hanno origine empirica, ma trovano a priori la loro sede e fonte<br />
nell'intelletto; e, in secondo luogo, anche che, quando esse vengono riferite a “oggetti in<br />
generale”, indipendente<strong>mente</strong> dalla loro intuizione, producono una “conoscenza teoretica”<br />
solo se si applicano a oggetti empirici; mentre, se applicate a un oggetto dato mediante la<br />
ragion pura pratica, servono a un pensiero determinato del sovrasensibile, sia pure solo in<br />
quanto questo è determinato dai predicati che necessaria<strong>mente</strong> appartengono alla pura<br />
“finalità pratica” data a priori e alla sua possibilità. La limitazione speculativa <strong>della</strong> ragion<br />
pura, e la sua estensione pratica, sono le sole che la collochino in quella “relazione di<br />
eguaglianza” in cui la ragione in genere può essere impiegata opportuna<strong>mente</strong>: e questo<br />
esempio mostra meglio di qualsiasi altro che la via verso la saggezza, se ha da essere sicura<br />
e non impercorribile o fuorviante, in noi uomini deve inevitabil<strong>mente</strong> passare attraverso la<br />
scienza; anche se solo quando la scienza sia stata portata a compimento, ci si può<br />
persuadere che essa conduce a quella meta.<br />
8. Dell'assenso che deriva da un'esigenza <strong>della</strong> ragion pura<br />
Un'“esigenza” <strong>della</strong> ragion pura nel suo uso speculativo conduce solo a “ipotesi”, mentre<br />
nell'uso pratico puro <strong>della</strong> ragione conduce a “postulati”. Nel primo caso, infatti, io risalgo,<br />
da ciò che è derivato, in alto “quanto voglio” nella serie dei fondamenti, e ho bisogno di un<br />
fondamento originario, non per dare realtà oggettiva a ciò che è derivato (per esempio, al<br />
legame causale delle cose e del divenire nel mondo), bensì solo per dare piena<br />
soddisfazione, rispetto a quel derivato, alla mia ragione che indaga. Così io vedo, nella<br />
natura che mi sta davanti, ordine e finalità, e non ho bisogno di addentrarmi nella<br />
speculazione per assicurarmi <strong>della</strong> loro “realtà”, ma solo di “presupporre una divinità”,<br />
come loro causa, “per spiegarli”. Poiché, infatti, la conclusione da un effetto a una causa<br />
determinata - e, soprattutto, determinata così perfetta<strong>mente</strong> come dobbiamo pensare<br />
Iddio - è sempre insicura e manchevole, una tal presupposizione non può mai esser portata<br />
oltre il grado di un opinare, per noi uomini, somma<strong>mente</strong> probabile (A16). Per contro,<br />
un'esigenza <strong>della</strong> ragion pura “pratica” si fonda su un “dovere” di fare oggetto <strong>della</strong> mia<br />
volontà qualcosa (il sommo bene), e di cercar di promuoverlo con tutte le mie forze; per il<br />
Pag. 86/103