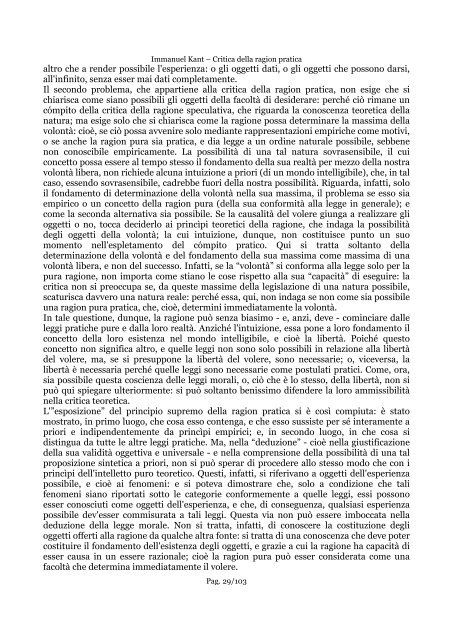CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
altro che a render possibile l'esperienza: o gli oggetti dati, o gli oggetti che possono darsi,<br />
all'infinito, senza esser mai dati completa<strong>mente</strong>.<br />
Il secondo problema, che appartiene alla critica <strong>della</strong> ragion pratica, non esige che si<br />
chiarisca come siano possibili gli oggetti <strong>della</strong> facoltà di desiderare: perché ciò rimane un<br />
cómpito <strong>della</strong> critica <strong>della</strong> ragione speculativa, che riguarda la conoscenza teoretica <strong>della</strong><br />
natura; ma esige solo che si chiarisca come la ragione possa determinare la massima <strong>della</strong><br />
volontà: cioè, se ciò possa avvenire solo mediante rappresentazioni empiriche come motivi,<br />
o se anche la ragion pura sia pratica, e dia legge a un ordine naturale possibile, sebbene<br />
non conoscibile empirica<strong>mente</strong>. La possibilità di una tal natura sovrasensibile, il cui<br />
concetto possa essere al tempo stesso il fondamento <strong>della</strong> sua realtà per mezzo <strong>della</strong> nostra<br />
volontà libera, non richiede alcuna intuizione a priori (di un mondo intelligibile), che, in tal<br />
caso, essendo sovrasensibile, cadrebbe fuori <strong>della</strong> nostra possibilità. Riguarda, infatti, solo<br />
il fondamento di determinazione <strong>della</strong> volontà nella sua massima, il problema se esso sia<br />
empirico o un concetto <strong>della</strong> ragion pura (<strong>della</strong> sua conformità alla legge in generale); e<br />
come la seconda alternativa sia possibile. Se la causalità del volere giunga a realizzare gli<br />
oggetti o no, tocca deciderlo ai princìpi teoretici <strong>della</strong> ragione, che indaga la possibilità<br />
degli oggetti <strong>della</strong> volontà; la cui intuizione, dunque, non costituisce punto un suo<br />
momento nell'espletamento del cómpito pratico. Qui si tratta soltanto <strong>della</strong><br />
determinazione <strong>della</strong> volontà e del fondamento <strong>della</strong> sua massima come massima di una<br />
volontà libera, e non del successo. Infatti, se la “volontà” si conforma alla legge solo per la<br />
pura ragione, non importa come stiano le cose rispetto alla sua “capacità” di eseguire: la<br />
critica non si preoccupa se, da queste massime <strong>della</strong> legislazione di una natura possibile,<br />
scaturisca davvero una natura reale: perché essa, qui, non indaga se non come sia possibile<br />
una ragion pura pratica, che, cioè, determini immediata<strong>mente</strong> la volontà.<br />
In tale questione, dunque, la ragione può senza biasimo - e, anzi, deve - cominciare dalle<br />
leggi pratiche pure e dalla loro realtà. Anziché l'intuizione, essa pone a loro fondamento il<br />
concetto <strong>della</strong> loro esistenza nel mondo intelligibile, e cioè la libertà. Poiché questo<br />
concetto non significa altro, e quelle leggi non sono solo possibili in relazione alla libertà<br />
del volere, ma, se si presuppone la libertà del volere, sono necessarie; o, viceversa, la<br />
libertà è necessaria perché quelle leggi sono necessarie come postulati pratici. Come, ora,<br />
sia possibile questa coscienza delle leggi morali, o, ciò che è lo stesso, <strong>della</strong> libertà, non si<br />
può qui spiegare ulterior<strong>mente</strong>: si può soltanto benissimo difendere la loro ammissibilità<br />
nella critica teoretica.<br />
L'”esposizione” del principio supremo <strong>della</strong> ragion pratica si è così compiuta: è stato<br />
mostrato, in primo luogo, che cosa esso contenga, e che esso sussiste per sé intera<strong>mente</strong> a<br />
priori e indipendente<strong>mente</strong> da princìpi empirici; e, in secondo luogo, in che cosa si<br />
distingua da tutte le altre leggi pratiche. Ma, nella “deduzione” - cioè nella giustificazione<br />
<strong>della</strong> sua validità oggettiva e universale - e nella comprensione <strong>della</strong> possibilità di una tal<br />
proposizione sintetica a priori, non si può sperar di procedere allo stesso modo che con i<br />
princìpi dell'intelletto puro teoretico. Questi, infatti, si riferivano a oggetti dell'esperienza<br />
possibile, e cioè ai fenomeni: e si poteva dimostrare che, solo a condizione che tali<br />
fenomeni siano riportati sotto le categorie conforme<strong>mente</strong> a quelle leggi, essi possono<br />
esser conosciuti come oggetti dell'esperienza, e che, di conseguenza, qualsiasi esperienza<br />
possibile dev'esser commisurata a tali leggi. Questa via non può essere imboccata nella<br />
deduzione <strong>della</strong> legge morale. Non si tratta, infatti, di conoscere la costituzione degli<br />
oggetti offerti alla ragione da qualche altra fonte: si tratta di una conoscenza che deve poter<br />
costituire il fondamento dell'esistenza degli oggetti, e grazie a cui la ragione ha capacità di<br />
esser causa in un essere razionale; cioè la ragion pura può esser considerata come una<br />
facoltà che determina immediata<strong>mente</strong> il volere.<br />
Pag. 29/103