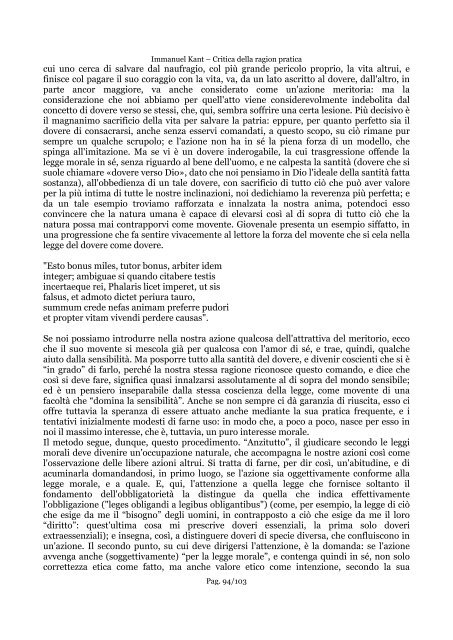CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
cui uno cerca di salvare dal naufragio, col più grande pericolo proprio, la vita altrui, e<br />
finisce col pagare il suo coraggio con la vita, va, da un lato ascritto al dovere, dall'altro, in<br />
parte ancor maggiore, va anche considerato come un'azione meritoria: ma la<br />
considerazione che noi abbiamo per quell'atto viene considerevol<strong>mente</strong> indebolita dal<br />
concetto di dovere verso se stessi, che, qui, sembra soffrire una certa lesione. Più decisivo è<br />
il magnanimo sacrificio <strong>della</strong> vita per salvare la patria: eppure, per quanto perfetto sia il<br />
dovere di consacrarsi, anche senza esservi comandati, a questo scopo, su ciò rimane pur<br />
sempre un qualche scrupolo; e l'azione non ha in sé la piena forza di un modello, che<br />
spinga all'imitazione. Ma se vi è un dovere inderogabile, la cui trasgressione offende la<br />
legge morale in sé, senza riguardo al bene dell'uomo, e ne calpesta la santità (dovere che si<br />
suole chiamare «dovere verso Dio», dato che noi pensiamo in Dio l'ideale <strong>della</strong> santità fatta<br />
sostanza), all'obbedienza di un tale dovere, con sacrificio di tutto ciò che può aver valore<br />
per la più intima di tutte le nostre inclinazioni, noi dedichiamo la reverenza più perfetta; e<br />
da un tale esempio troviamo rafforzata e innalzata la nostra anima, potendoci esso<br />
convincere che la natura umana è capace di elevarsi così al di sopra di tutto ciò che la<br />
natura possa mai contrapporvi come movente. Giovenale presenta un esempio siffatto, in<br />
una progressione che fa sentire vivace<strong>mente</strong> al lettore la forza del movente che si cela nella<br />
legge del dovere come dovere.<br />
"Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem<br />
integer; ambiguae si quando citabere testis<br />
incertaeque rei, Phalaris licet imperet, ut sis<br />
falsus, et admoto dictet periura tauro,<br />
summum crede nefas animam preferre pudori<br />
et propter vitam vivendi perdere causas".<br />
Se noi possiamo introdurre nella nostra azione qualcosa dell'attrattiva del meritorio, ecco<br />
che il suo movente si mescola già per qualcosa con l'amor di sé, e trae, quindi, qualche<br />
aiuto dalla sensibilità. Ma posporre tutto alla santità del dovere, e divenir coscienti che si è<br />
“in grado” di farlo, perché la nostra stessa ragione riconosce questo comando, e dice che<br />
così si deve fare, significa quasi innalzarsi assoluta<strong>mente</strong> al di sopra del mondo sensibile;<br />
ed è un pensiero inseparabile dalla stessa coscienza <strong>della</strong> legge, come movente di una<br />
facoltà che “domina la sensibilità”. Anche se non sempre ci dà garanzia di riuscita, esso ci<br />
offre tuttavia la speranza di essere attuato anche mediante la sua pratica frequente, e i<br />
tentativi inizial<strong>mente</strong> modesti di farne uso: in modo che, a poco a poco, nasce per esso in<br />
noi il massimo interesse, che è, tuttavia, un puro interesse morale.<br />
Il metodo segue, dunque, questo procedimento. “Anzitutto”, il giudicare secondo le leggi<br />
morali deve divenire un'occupazione naturale, che accompagna le nostre azioni così come<br />
l'osservazione delle libere azioni altrui. Si tratta di farne, per dir così, un'abitudine, e di<br />
acuminarla domandandosi, in primo luogo, se l'azione sia oggettiva<strong>mente</strong> conforme alla<br />
legge morale, e a quale. E, qui, l'attenzione a quella legge che fornisce soltanto il<br />
fondamento dell'obbligatorietà la distingue da quella che indica effettiva<strong>mente</strong><br />
l'obbligazione ("leges obligandi a legibus obligantibus") (come, per esempio, la legge di ciò<br />
che esige da me il “bisogno” degli uomini, in contrapposto a ciò che esige da me il loro<br />
“diritto”: quest'ultima cosa mi prescrive doveri essenziali, la prima solo doveri<br />
extraessenziali); e insegna, così, a distinguere doveri di specie diversa, che confluiscono in<br />
un'azione. Il secondo punto, su cui deve dirigersi l'attenzione, è la domanda: se l'azione<br />
avvenga anche (soggettiva<strong>mente</strong>) “per la legge morale”, e contenga quindi in sé, non solo<br />
correttezza etica come fatto, ma anche valore etico come intenzione, secondo la sua<br />
Pag. 94/103