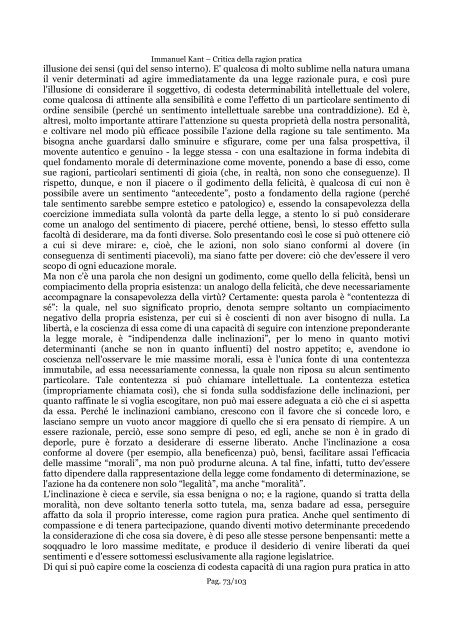CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
illusione dei sensi (qui del senso interno). E' qualcosa di molto sublime nella natura umana<br />
il venir determinati ad agire immediata<strong>mente</strong> da una legge razionale pura, e così pure<br />
l'illusione di considerare il soggettivo, di codesta determinabilità intellettuale del volere,<br />
come qualcosa di attinente alla sensibilità e come l'effetto di un particolare sentimento di<br />
ordine sensibile (perché un sentimento intellettuale sarebbe una contraddizione). Ed è,<br />
altresì, molto importante attirare l'attenzione su questa proprietà <strong>della</strong> nostra personalità,<br />
e coltivare nel modo più efficace possibile l'azione <strong>della</strong> ragione su tale sentimento. Ma<br />
bisogna anche guardarsi dallo sminuire e sfigurare, come per una falsa prospettiva, il<br />
movente autentico e genuino - la legge stessa - con una esaltazione in forma indebita di<br />
quel fondamento morale di determinazione come movente, ponendo a base di esso, come<br />
sue ragioni, particolari sentimenti di gioia (che, in realtà, non sono che conseguenze). Il<br />
rispetto, dunque, e non il piacere o il godimento <strong>della</strong> felicità, è qualcosa di cui non è<br />
possibile avere un sentimento “antecedente”, posto a fondamento <strong>della</strong> ragione (perché<br />
tale sentimento sarebbe sempre estetico e patologico) e, essendo la consapevolezza <strong>della</strong><br />
coercizione immediata sulla volontà da parte <strong>della</strong> legge, a stento lo si può considerare<br />
come un analogo del sentimento di piacere, perché ottiene, bensì, lo stesso effetto sulla<br />
facoltà di desiderare, ma da fonti diverse. Solo presentando così le cose si può ottenere ciò<br />
a cui si deve mirare: e, cioè, che le azioni, non solo siano conformi al dovere (in<br />
conseguenza di sentimenti piacevoli), ma siano fatte per dovere: ciò che dev'essere il vero<br />
scopo di ogni educazione morale.<br />
Ma non c'è una parola che non designi un godimento, come quello <strong>della</strong> felicità, bensì un<br />
compiacimento <strong>della</strong> propria esistenza: un analogo <strong>della</strong> felicità, che deve necessaria<strong>mente</strong><br />
accompagnare la consapevolezza <strong>della</strong> virtù? Certa<strong>mente</strong>: questa parola è “contentezza di<br />
sé”: la quale, nel suo significato proprio, denota sempre soltanto un compiacimento<br />
negativo <strong>della</strong> propria esistenza, per cui si è coscienti di non aver bisogno di nulla. La<br />
libertà, e la coscienza di essa come di una capacità di seguire con intenzione preponderante<br />
la legge morale, è “indipendenza dalle inclinazioni”, per lo meno in quanto motivi<br />
determinanti (anche se non in quanto influenti) del nostro appetito; e, avendone io<br />
coscienza nell'osservare le mie massime morali, essa è l'unica fonte di una contentezza<br />
immutabile, ad essa necessaria<strong>mente</strong> connessa, la quale non riposa su alcun sentimento<br />
particolare. Tale contentezza si può chiamare intellettuale. La contentezza estetica<br />
(impropria<strong>mente</strong> chiamata così), che si fonda sulla soddisfazione delle inclinazioni, per<br />
quanto raffinate le si voglia escogitare, non può mai essere adeguata a ciò che ci si aspetta<br />
da essa. Perché le inclinazioni cambiano, crescono con il favore che si concede loro, e<br />
lasciano sempre un vuoto ancor maggiore di quello che si era pensato di riempire. A un<br />
essere razionale, perciò, esse sono sempre di peso, ed egli, anche se non è in grado di<br />
deporle, pure è forzato a desiderare di esserne liberato. Anche l'inclinazione a cosa<br />
conforme al dovere (per esempio, alla beneficenza) può, bensì, facilitare assai l'efficacia<br />
delle massime “morali”, ma non può produrne alcuna. A tal fine, infatti, tutto dev'essere<br />
fatto dipendere dalla rappresentazione <strong>della</strong> legge come fondamento di determinazione, se<br />
l'azione ha da contenere non solo “legalità”, ma anche “moralità”.<br />
L'inclinazione è cieca e servile, sia essa benigna o no; e la ragione, quando si tratta <strong>della</strong><br />
moralità, non deve soltanto tenerla sotto tutela, ma, senza badare ad essa, perseguire<br />
affatto da sola il proprio interesse, come ragion pura pratica. Anche quel sentimento di<br />
compassione e di tenera partecipazione, quando diventi motivo determinante precedendo<br />
la considerazione di che cosa sia dovere, è di peso alle stesse persone benpensanti: mette a<br />
soqquadro le loro massime meditate, e produce il desiderio di venire liberati da quei<br />
sentimenti e d'essere sottomessi esclusiva<strong>mente</strong> alla ragione legislatrice.<br />
Di qui si può capire come la coscienza di codesta capacità di una ragion pura pratica in atto<br />
Pag. 73/103