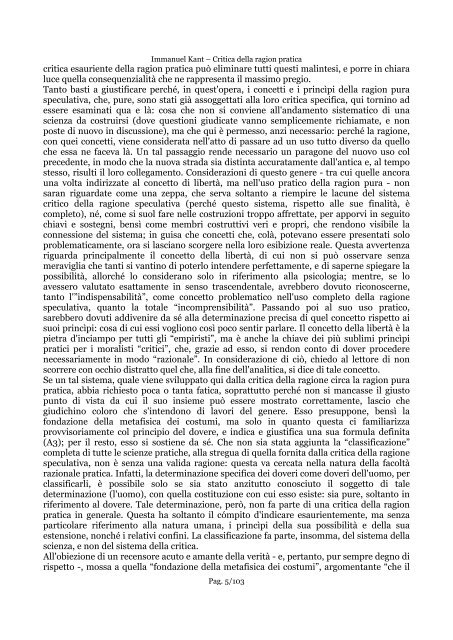CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
critica esauriente <strong>della</strong> ragion pratica può eliminare tutti questi malintesi, e porre in chiara<br />
luce quella consequenzialità che ne rappresenta il massimo pregio.<br />
Tanto basti a giustificare perché, in quest'opera, i concetti e i princìpi <strong>della</strong> ragion pura<br />
speculativa, che, pure, sono stati già assoggettati alla loro critica specifica, qui tornino ad<br />
essere esaminati qua e là: cosa che non si conviene all'andamento sistematico di una<br />
scienza da costruirsi (dove questioni giudicate vanno semplice<strong>mente</strong> richiamate, e non<br />
poste di nuovo in discussione), ma che qui è permesso, anzi necessario: perché la ragione,<br />
con quei concetti, viene considerata nell'atto di passare ad un uso tutto diverso da quello<br />
che essa ne faceva là. Un tal passaggio rende necessario un paragone del nuovo uso col<br />
precedente, in modo che la nuova strada sia distinta accurata<strong>mente</strong> dall'antica e, al tempo<br />
stesso, risulti il loro collegamento. Considerazioni di questo genere - tra cui quelle ancora<br />
una volta indirizzate al concetto di libertà, ma nell'uso pratico <strong>della</strong> ragion pura - non<br />
saran riguardate come una zeppa, che serva soltanto a riempire le lacune del sistema<br />
critico <strong>della</strong> ragione speculativa (perché questo sistema, rispetto alle sue finalità, è<br />
completo), né, come si suol fare nelle costruzioni troppo affrettate, per apporvi in seguito<br />
chiavi e sostegni, bensì come membri costruttivi veri e propri, che rendono visibile la<br />
connessione del sistema; in guisa che concetti che, colà, potevano essere presentati solo<br />
problematica<strong>mente</strong>, ora si lasciano scorgere nella loro esibizione reale. Questa avvertenza<br />
riguarda principal<strong>mente</strong> il concetto <strong>della</strong> libertà, di cui non si può osservare senza<br />
meraviglia che tanti si vantino di poterlo intendere perfetta<strong>mente</strong>, e di saperne spiegare la<br />
possibilità, allorché lo considerano solo in riferimento alla psicologia; mentre, se lo<br />
avessero valutato esatta<strong>mente</strong> in senso trascendentale, avrebbero dovuto riconoscerne,<br />
tanto l'”indispensabilità”, come concetto problematico nell'uso completo <strong>della</strong> ragione<br />
speculativa, quanto la totale “incomprensibilità”. Passando poi al suo uso pratico,<br />
sarebbero dovuti addivenire da sé alla determinazione precisa di quel concetto rispetto ai<br />
suoi princìpi: cosa di cui essi vogliono così poco sentir parlare. Il concetto <strong>della</strong> libertà è la<br />
pietra d'inciampo per tutti gli “empiristi”, ma è anche la chiave dei più sublimi princìpi<br />
pratici per i moralisti “critici”, che, grazie ad esso, si rendon conto di dover procedere<br />
necessaria<strong>mente</strong> in modo “razionale”. In considerazione di ciò, chiedo al lettore di non<br />
scorrere con occhio distratto quel che, alla fine dell'analitica, si dice di tale concetto.<br />
Se un tal sistema, quale viene sviluppato qui dalla critica <strong>della</strong> ragione circa la ragion pura<br />
pratica, abbia richiesto poca o tanta fatica, soprattutto perché non si mancasse il giusto<br />
punto di vista da cui il suo insieme può essere mostrato corretta<strong>mente</strong>, lascio che<br />
giudichino coloro che s'intendono di lavori del genere. Esso presuppone, bensì la<br />
fondazione <strong>della</strong> metafisica dei costumi, ma solo in quanto questa ci familiarizza<br />
provvisoria<strong>mente</strong> col principio del dovere, e indica e giustifica una sua formula definita<br />
(A3); per il resto, esso si sostiene da sé. Che non sia stata aggiunta la “classificazione”<br />
completa di tutte le scienze pratiche, alla stregua di quella fornita dalla critica <strong>della</strong> ragione<br />
speculativa, non è senza una valida ragione: questa va cercata nella natura <strong>della</strong> facoltà<br />
razionale pratica. Infatti, la determinazione specifica dei doveri come doveri dell'uomo, per<br />
classificarli, è possibile solo se sia stato anzitutto conosciuto il soggetto di tale<br />
determinazione (l'uomo), con quella costituzione con cui esso esiste: sia pure, soltanto in<br />
riferimento al dovere. Tale determinazione, però, non fa parte di una critica <strong>della</strong> ragion<br />
pratica in generale. Questa ha soltanto il cómpito d'indicare esauriente<strong>mente</strong>, ma senza<br />
particolare riferimento alla natura umana, i princìpi <strong>della</strong> sua possibilità e <strong>della</strong> sua<br />
estensione, nonché i relativi confini. La classificazione fa parte, insomma, del sistema <strong>della</strong><br />
scienza, e non del sistema <strong>della</strong> critica.<br />
All'obiezione di un recensore acuto e amante <strong>della</strong> verità - e, pertanto, pur sempre degno di<br />
rispetto -, mossa a quella “fondazione <strong>della</strong> metafisica dei costumi”, argomentante “che il<br />
Pag. 5/103