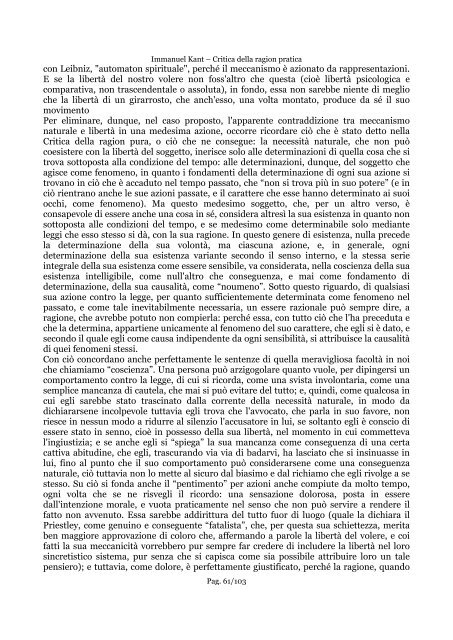CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
CRITICA DELLA RAGION PRATICA - Sentieri della mente
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Immanuel Kant – Critica <strong>della</strong> ragion pratica<br />
con Leibniz, "automaton spirituale", perché il meccanismo è azionato da rappresentazioni.<br />
E se la libertà del nostro volere non foss'altro che questa (cioè libertà psicologica e<br />
comparativa, non trascendentale o assoluta), in fondo, essa non sarebbe niente di meglio<br />
che la libertà di un girarrosto, che anch'esso, una volta montato, produce da sé il suo<br />
movimento<br />
Per eliminare, dunque, nel caso proposto, l'apparente contraddizione tra meccanismo<br />
naturale e libertà in una medesima azione, occorre ricordare ciò che è stato detto nella<br />
Critica <strong>della</strong> ragion pura, o ciò che ne consegue: la necessità naturale, che non può<br />
coesistere con la libertà del soggetto, inerisce solo alle determinazioni di quella cosa che si<br />
trova sottoposta alla condizione del tempo: alle determinazioni, dunque, del soggetto che<br />
agisce come fenomeno, in quanto i fondamenti <strong>della</strong> determinazione di ogni sua azione si<br />
trovano in ciò che è accaduto nel tempo passato, che “non si trova più in suo potere” (e in<br />
ciò rientrano anche le sue azioni passate, e il carattere che esse hanno determinato ai suoi<br />
occhi, come fenomeno). Ma questo medesimo soggetto, che, per un altro verso, è<br />
consapevole di essere anche una cosa in sé, considera altresì la sua esistenza in quanto non<br />
sottoposta alle condizioni del tempo, e se medesimo come determinabile solo mediante<br />
leggi che esso stesso si dà, con la sua ragione. In questo genere di esistenza, nulla precede<br />
la determinazione <strong>della</strong> sua volontà, ma ciascuna azione, e, in generale, ogni<br />
determinazione <strong>della</strong> sua esistenza variante secondo il senso interno, e la stessa serie<br />
integrale <strong>della</strong> sua esistenza come essere sensibile, va considerata, nella coscienza <strong>della</strong> sua<br />
esistenza intelligibile, come null'altro che conseguenza, e mai come fondamento di<br />
determinazione, <strong>della</strong> sua causalità, come “noumeno”. Sotto questo riguardo, di qualsiasi<br />
sua azione contro la legge, per quanto sufficiente<strong>mente</strong> determinata come fenomeno nel<br />
passato, e come tale inevitabil<strong>mente</strong> necessaria, un essere razionale può sempre dire, a<br />
ragione, che avrebbe potuto non compierla: perché essa, con tutto ciò che l'ha preceduta e<br />
che la determina, appartiene unica<strong>mente</strong> al fenomeno del suo carattere, che egli si è dato, e<br />
secondo il quale egli come causa indipendente da ogni sensibilità, si attribuisce la causalità<br />
di quei fenomeni stessi.<br />
Con ciò concordano anche perfetta<strong>mente</strong> le sentenze di quella meravigliosa facoltà in noi<br />
che chiamiamo “coscienza”. Una persona può arzigogolare quanto vuole, per dipingersi un<br />
comportamento contro la legge, di cui si ricorda, come una svista involontaria, come una<br />
semplice mancanza di cautela, che mai si può evitare del tutto; e, quindi, come qualcosa in<br />
cui egli sarebbe stato trascinato dalla corrente <strong>della</strong> necessità naturale, in modo da<br />
dichiararsene incolpevole tuttavia egli trova che l'avvocato, che parla in suo favore, non<br />
riesce in nessun modo a ridurre al silenzio l'accusatore in lui, se soltanto egli è conscio di<br />
essere stato in senno, cioè in possesso <strong>della</strong> sua libertà, nel momento in cui commetteva<br />
l'ingiustizia; e se anche egli si “spiega” la sua mancanza come conseguenza di una certa<br />
cattiva abitudine, che egli, trascurando via via di badarvi, ha lasciato che si insinuasse in<br />
lui, fino al punto che il suo comportamento può considerarsene come una conseguenza<br />
naturale, ciò tuttavia non lo mette al sicuro dal biasimo e dal richiamo che egli rivolge a se<br />
stesso. Su ciò si fonda anche il “pentimento” per azioni anche compiute da molto tempo,<br />
ogni volta che se ne risvegli il ricordo: una sensazione dolorosa, posta in essere<br />
dall'intenzione morale, e vuota pratica<strong>mente</strong> nel senso che non può servire a rendere il<br />
fatto non avvenuto. Essa sarebbe addirittura del tutto fuor di luogo (quale la dichiara il<br />
Priestley, come genuino e conseguente “fatalista”, che, per questa sua schiettezza, merita<br />
ben maggiore approvazione di coloro che, affermando a parole la libertà del volere, e coi<br />
fatti la sua meccanicità vorrebbero pur sempre far credere di includere la libertà nel loro<br />
sincretistico sistema, pur senza che si capisca come sia possibile attribuire loro un tale<br />
pensiero); e tuttavia, come dolore, è perfetta<strong>mente</strong> giustificato, perché la ragione, quando<br />
Pag. 61/103