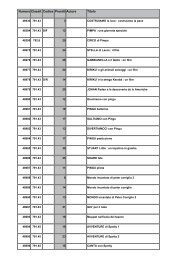Villa, I signori de Aquaneis.. - Sistema bibliotecario Milano Est
Villa, I signori de Aquaneis.. - Sistema bibliotecario Milano Est
Villa, I signori de Aquaneis.. - Sistema bibliotecario Milano Est
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Storia in Martesana - N° 4 - 2010<br />
________________________________________________________________________________<br />
La ripresa <strong>de</strong>gli scambi commerciali e la crescita <strong>de</strong>lla popolazione avevano creato fin dal basso<br />
medioevo le condizioni per una ripresa <strong>de</strong>ll’economia casearia. Per merito <strong>de</strong>i Cistercensi e <strong>de</strong>gli<br />
Umiliati, nella pianura si moltiplicavano le sistemazioni <strong>de</strong>i terreni a marcita che consentivano di<br />
disporre di foraggio fresco anche durante l’inverno. Le Grangie, grandi proprietà prima monastiche<br />
e poi <strong>de</strong>i <strong>signori</strong> laici, si arricchivano ovunque di stalle, e in montagna si creavano alpeggi, ottenuti<br />
attraverso i disboscamenti e la costruzione di rudimentali strutture per il ricovero <strong>de</strong>l bestiame e per<br />
la lavorazione <strong>de</strong>l latte. Gli alpeggi, chiamati alpi o malghe, erano talvolta di proprietà collettiva,<br />
altre volte privata. Ricordo questi essenziali aspetti <strong>de</strong>lla transumanza, molto noti a chiunque si<br />
occupi <strong>de</strong>lla storia lombarda, per rammentare al lettore che fin dal dodicesimo secolo i rapporti tra<br />
l’area prealpina <strong>de</strong>l lecchese e la nostra pianura erano già molto frequenti ed interessavano quasi<br />
tutti i paesi <strong>de</strong>l nostro territorio.<br />
L’altro aspetto <strong>de</strong>lla transumanza, essenziale perchè riguarda direttamente questa ricerca, è<br />
rappresentato dalla progressiva modificazione <strong>de</strong>i continui flussi verso la pianura di questi<br />
lavoratori stagionali, che un poco alla volta diventavano stanziali 186 mantenendo però uno stretto<br />
legame con i paesi d’origine e con la montagna, attraverso i legami parentali ed economici. Non so<br />
quale circostanza particolare possa avere favorito, verso la seconda parte <strong>de</strong>l dodicesimo secolo, la<br />
migrazione di parecchi abitanti di Ello verso Melzo più che verso altri paesi vicini. L’impulso<br />
iniziale può essere stato indotto, indifferentemente, dalla necessità di un proprietario di spostare<br />
manodopera contadina fra terre piuttosto lontane ma accomunate dal suo controllo, oppure<br />
dall’iniziativa, per motivi simili, da parte di un ente religioso. Se così fosse, la maggiore indiziata<br />
sarebbe la Chiesa milanese <strong>de</strong>i Decumani <strong>de</strong>l Duomo, che già nel dodicesimo secolo, ma in misura<br />
maggiore nel corso <strong>de</strong>l Duecento, posse<strong>de</strong>va molti beni melzesi, ma le cui proprietà fin dai tempi<br />
risalgono al tredicesimo secolo. La <strong>de</strong>nominazione di “stracchino”, con cui anticamente veniva chiamato il Gorgonzola,<br />
infatti <strong>de</strong>riva da “stracco”, stanco, a indicare le condizioni <strong>de</strong>lle mandrie di vacche in transumanza dalle Alpi <strong>de</strong>lla<br />
Valsassina e dalle Prealpi Bergamasche alle praterie ricche d´acqua e di foraggio <strong>de</strong>lla pianura. Ed era nella zona di<br />
Gorgonzola che le mandrie trovavano il luogo migliore per la sosta. Gorgonzola fu sicuramente il centro che sancì la<br />
notorietà <strong>de</strong>l formaggio con un’intensa produzione e gli die<strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominazione che ancora oggi porta.<br />
“Quando abbia avuto origine questo latticino” conferma il Massara “nol sapremmo precisamente indicare”. Il<br />
Manzoni lo fa mangiare a Renzo nel 1620, ma le prime notizie che riguardano lo stracchino sono molto più antiche. Si<br />
può ritenere che si tratti <strong>de</strong>l perfezionamento di quel “cacio” già ricordato in un testamento <strong>de</strong>l nono secolo di<br />
Anaperto, Arcivescovo di <strong>Milano</strong>, <strong>de</strong>l 13 settembre 879 e in un documento di poco successivo, la Donazione fatta alla<br />
scuola di S. Ambrogio nell’anno 1007. Una leggenda, dovuta allo scrivano Eginardo, racconta che nel nono secolo fu<br />
servito a tavola a Carlo Magno, in visita a un Vescovo, un formaggio dalle venature verdi e che il Re venne ripreso dal<br />
prelato perché, scartando le muffe, eliminava la parte migliore. Carlo Magno allora, assaggiandolo completamente, si<br />
innamorò di quel formaggio e volle che ogni anno fosse portato alla sua reggia. Gli stracchini “rappresentavano il polo<br />
<strong>de</strong>lla semplicità arcaica, legati alla tradizione di caseificio noma<strong>de</strong> <strong>de</strong>i bergamini, i proprietari di mandrie di vacche da<br />
latte e casari che, tra il X e il XX secolo praticarono la transumanza bovina fra le vallate orobiche e la Bassa. I “quadri”<br />
(stracchini) erano prodotti durante le soste <strong>de</strong>lle mandrie, quando, dopo un breve spurgo, venivano messi in forma<br />
nell’apposito stampo di legno a scomparti quadrati collocato nella zimbarda, una specie di cassettone posto al di sotto<br />
<strong>de</strong>l pianale <strong>de</strong>l carretto”. Gli “stracchini” perciò richiamavano sia il gorgonzola, sia il taleggio e sia il quartirolo, ma per<br />
i bergamini ed anche per gli allevatori-agricoltori <strong>de</strong>lle valli orobiche, questi formaggi continuavano a chiamarsi solo<br />
tondi e quadri.<br />
186 Con il tempo, approfittando <strong>de</strong>lla dissoluzione <strong>de</strong>lle grandi proprietà <strong>signori</strong>li ed ecclesiastiche e <strong>de</strong>lla diffusione <strong>de</strong>l<br />
contratto di affitto (fenomeni accelerati prima dalle riforme austriache e poi dai rivolgimenti politici ottocenteschi), i<br />
malghesi modificarono radicalmente il loro rapporto con i fondi <strong>de</strong>lla bassa. Se nelle epoche prece<strong>de</strong>nti erano “ospitati”<br />
con il proprio bestiame durante il periodo invernale nelle stalle <strong>de</strong>lle grandi proprietà <strong>de</strong>lla pianura, in cambio <strong>de</strong>lla<br />
fertilizzazione organica assicurata ai campi dal loro bestiame e di una parte <strong>de</strong>i prodotti caseari o <strong>de</strong>l loro ricavo, ora<br />
<strong>de</strong>ci<strong>de</strong>vano di subentrare in prima persona, come “fittavoli”, nella gestione imprenditoriale <strong>de</strong>lle azien<strong>de</strong>. Da nomadi<br />
stagionali, i bergamini diventavano agricoltori ed allevatori stanziali, affidando da quel momento ai propri salariati,<br />
<strong>de</strong>tti “caricatori d’alpe”, l’alpeggio <strong>de</strong>lle proprie mandrie. Nemmeno il passaggio progressivo all’agricoltura stanziale<br />
da parte di questi allevatori prealpini, iniziato probabilmente già in epoche prece<strong>de</strong>nti ma cresciuto in modo<br />
significativo solo nel XVIII secolo, attenuava però lo stretto legame che le famiglie <strong>de</strong>i nuovi fittavoli “stanziali”<br />
mantenevano con i paesi d’origine e con la montagna, attraverso i propri antichi legami parentali ed economici. Per<br />
diverse generazioni, anzi, i fittavoli discen<strong>de</strong>nti dai malghesi hanno praticato una sorta di endogamia e, ancor oggi, in<br />
occasione di certi eventi famigliari, matrimoni e funerali, sono mantenute vive le occasione di incontro fra i membri<br />
<strong>de</strong>gli antichi nuclei parentali.<br />
________________________________________________________________________________<br />
71



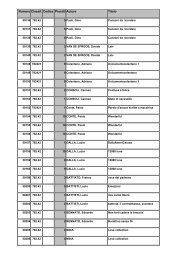

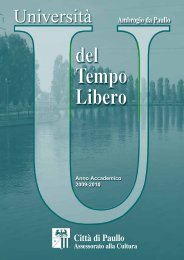

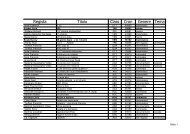
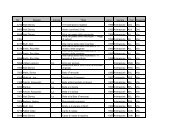
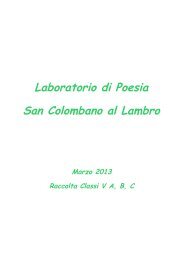

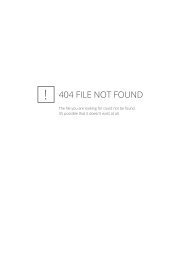
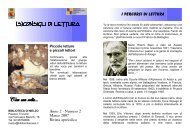
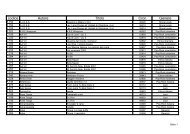
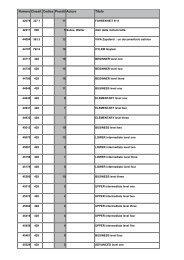
![Pirotta, Silvano [La Spada di Bronzo di Cassano d'Adda ...]](https://img.yumpu.com/31533405/1/184x260/pirotta-silvano-la-spada-di-bronzo-di-cassano-dadda-.jpg?quality=85)