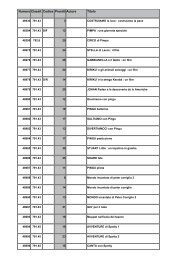Villa, I signori de Aquaneis.. - Sistema bibliotecario Milano Est
Villa, I signori de Aquaneis.. - Sistema bibliotecario Milano Est
Villa, I signori de Aquaneis.. - Sistema bibliotecario Milano Est
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Storia in Martesana - N° 4 - 2010<br />
________________________________________________________________________________<br />
cognomi con una particella, come aut, seu, sive, che significano ovvero, ossia, oppure. La<br />
questione, così, sembrava chiusa, tanto più che nel 1605 anche il Cardinale Fe<strong>de</strong>rico, quasi tre<br />
secoli dopo il transumptus, con tutta la maestosa autorità <strong>de</strong>lla sua cultura indicava i discen<strong>de</strong>nti<br />
<strong>de</strong>lla stessa famiglia come “De Nigris, sive Rubeis”, che vuol dire “De Negri, o Rossi”. Il<br />
problema, nella riga <strong>de</strong>l Cardinale, non stava nelle minime varianti con le quali scriveva il<br />
cognome, ma nella data: perché a partire dai giorni <strong>de</strong>lla fondazione <strong>de</strong>lla cappellania al rapporto di<br />
Fe<strong>de</strong>rico Borromeo passano quattro secoli, un lunghissimo tempo, nel corso <strong>de</strong>l quale nella<br />
documentazione melzese non c’è un solo atto, una sola carta di qualunque genere, nella quale sia<br />
possibile leggere un cognome i<strong>de</strong>ntico, o simile. Qui, perciò, non c’è attenzione per i <strong>de</strong>ttagli che<br />
tenga: non esiste risposta possibile, e non resta che pren<strong>de</strong>rne atto.<br />
Infine, <strong>de</strong>vo fare l’elenco di tutte le altre risposte mancate rispetto alle doman<strong>de</strong> che l’indagine<br />
aveva suggerito. Non so dirvi perché, sempre secondo Fe<strong>de</strong>rico Borromeo, al principio <strong>de</strong>l Seicento<br />
il privilegio di proporre i rettori di Sant’Andrea “secondo i patti che erano stati convenuti” fosse<br />
ancora riservato proprio alla sconosciuta famiglia <strong>de</strong>i “<strong>de</strong> Negri <strong>de</strong> Rossi” insieme a quella <strong>de</strong>i <strong>de</strong><br />
Albignano e in aggiunta ai Lampergo e ai da Ello, che come sappiamo <strong>de</strong>tenevano formalmente<br />
anche i diritti di patronato. E non ho mai capito perché mai questo diritto di presentare i rettori non<br />
sia mai formalmente appartenuto anche agli Aquania, che secondo il transumptus avevano<br />
<strong>de</strong>signato il primo. Non sono riuscito a compren<strong>de</strong>re come mai proprio gli Aquania, al principio <strong>de</strong>l<br />
Duecento, avessero <strong>de</strong>ciso di costruire una piccola chiesa privata a Melzo su un terreno di loro<br />
proprietà, e più tardi di a<strong>de</strong>rire alla fondazione <strong>de</strong>lla sua cappellania, vista e constatata più volte, nei<br />
secoli successivi, la costante strategia <strong>de</strong>ll’attenzione da parte di quella numerosa famiglia verso le<br />
istituzioni ecclesiali <strong>de</strong>l loro tempo: entrambe le scelte sembrano, a prima vista, incoerenti, visto<br />
che a Melzo, solo pochissimi anni prima di Sant’Andrea, era stata costruita la chiesa parrocchiale,<br />
certo con l’approvazione e la benedizione <strong>de</strong>l vescovo. Una spiegazione esisteva di certo, ma non<br />
sono riuscito ad immaginarla. Non so dire, inoltre, sempre a proposito <strong>de</strong>gli Aquania, come mai il<br />
ricco notaio Anselmo, che nel suo testamento aveva disposto importanti legati a favore<br />
<strong>de</strong>ll’ospedale di Gorgonzola, <strong>de</strong>lla chiesa di Pozzuolo Martesana e di molte altre istituzioni<br />
religiose, non abbia lasciato nulla alla chiesa melzese costruita dai suoi antenati, e che per molte<br />
generazioni, con la consueta accortezza, la sua famiglia aveva utilizzato per pagare meno tasse.<br />
Non potrei terminare questo elenco di “ciò che non sappiamo” senza ricordare al lettore che nella<br />
nostra conoscenza <strong>de</strong>lle chiese melzesi <strong>de</strong>i primi secoli esiste un gran<strong>de</strong> vuoto, fino ad ora non<br />
colmato. Anche in questo studio ho sottolineato più volte la singolarità <strong>de</strong>lla costruzione di<br />
Sant’Andrea, chiesa privata, a breve distanza di anni dall’edificazione <strong>de</strong>ll’altro edificio sacro, la<br />
parrocchiale intitolata ai santi Alessandro e Margherita sorta dalla parte opposta rispetto alla piazza<br />
centrale. Se le motivazioni che die<strong>de</strong>ro origine al transumptus <strong>de</strong>l 1345 sembrano facili da<br />
compren<strong>de</strong>re, perché consistevano nella volontà di aggirare il fisco, nessuno ha mai chiarito quelle,<br />
molto più interessanti, che avevano indotto le stesse famiglie a far costruire la chiesa. Nella diocesi<br />
milanese, come è largamente noto, fin dall’undicesimo secolo, lungo l’intero secolo dodicesimo e<br />
fino all’epoca di costruzione di entrambe le chiese melzesi al principio <strong>de</strong>l secolo XIII, si andò<br />
radicalizzando un durissimo conflitto religioso che coinvolse vescovi e comuni, gerarchie<br />
ecclesiastiche, grandi monasteri e ordini minoritici, famiglie nobili e nuovi ceti, in un fitto<br />
intrecciarsi di interessi e passioni, di rivolte, condanne e scomuniche, che investì le città ed i contadi<br />
e che qui è impossibile raccontare: se <strong>Milano</strong> veniva <strong>de</strong>scritta come una “fossa piena di eretici” 209 e<br />
Brescia come se<strong>de</strong> stessa <strong>de</strong>ll’eresia 210 , il clero <strong>de</strong>lle campagne era ovunque subordinato ai padroni<br />
laici, mentre i principali ordini religiosi erano impegnati nella gestione di grandi patrimoni fondiari.<br />
<strong>Milano</strong> era, naturalmente, fin dal secolo prece<strong>de</strong>nte, una <strong>de</strong>lle città dove la rivendicazione di una<br />
nuova visione <strong>de</strong>l lavoro, la “vita activa et negociosa” era ancora vista come peccato, e dove i suoi<br />
209 Frase celebre pronunciata dal predicatore Jacques <strong>de</strong> Vitry nel 1215.<br />
210 La <strong>de</strong>finizione fu coniata da Papa Onorio III.<br />
________________________________________________________________________________<br />
90



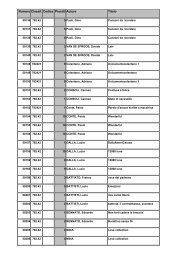

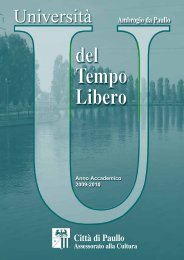

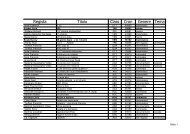
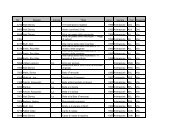
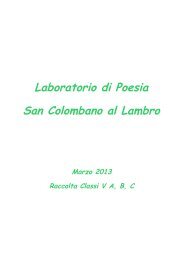

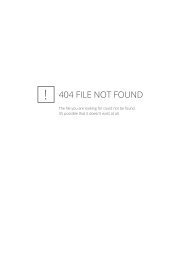
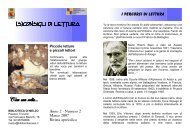
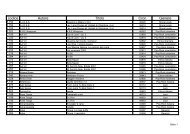
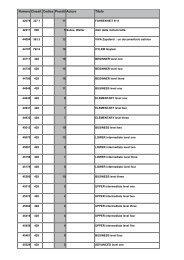
![Pirotta, Silvano [La Spada di Bronzo di Cassano d'Adda ...]](https://img.yumpu.com/31533405/1/184x260/pirotta-silvano-la-spada-di-bronzo-di-cassano-dadda-.jpg?quality=85)