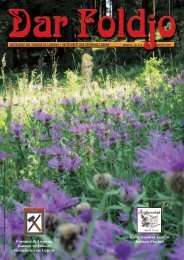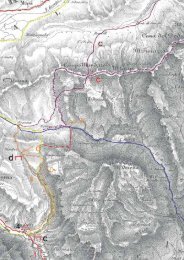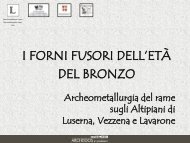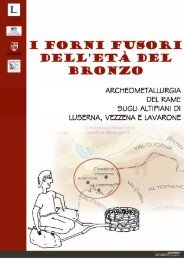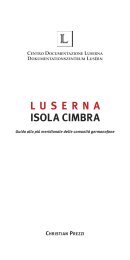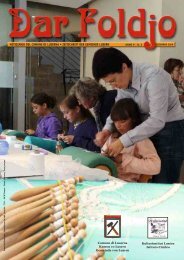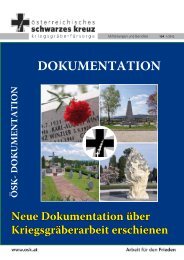volume - Centro Documentazione Luserna
volume - Centro Documentazione Luserna
volume - Centro Documentazione Luserna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
78<br />
Paolo Zammatteo<br />
Se la realizzazione di murature a secco appartiene a tutta la tradizione non<br />
romana, dai Greci ai Celti, non di meno è chiaro che qui alcune strutture litiche<br />
di grandi dimensioni erano utilizzate per segnalare percorsi e opere di interesse<br />
pubblico, le strade.<br />
La frequenza di queste opere e la loro varietà sono molto maggiori rispetto<br />
alle altre consuetudini masali alpine.<br />
All’interno di questa categoria si riconoscono vari tipi di paramento murario,<br />
che a seconda della apparente semplicità o per la maestria nell’esecuzione<br />
possono essere più o meno antichi e il prodotto di maestranze locali come di<br />
importazione.<br />
Occorre però trovare un riferimento storico per quanto è avvenuto in modo<br />
tanto estensivo fra la Lessinia e la Cymbria. E la chiarificazione sta tutta nel valore<br />
assegnato alle Viezene. Non come terreno di pascolo, in quanto il prativo<br />
dei terreni prevalentemente calcarei rende molto meno che sulle altre alpi: piuttosto<br />
erano essenziali come snodi per la monticazione, risorsa irrinunciabile<br />
degli armenti, che qui giungevano dalla pianura veneta.<br />
Perciò l’occupazione stagionale dovette essere prevalente a lungo. Tutto orbitava<br />
intorno ai pascoli, anche i ricoveri per gli uomini, con la realizzazione di<br />
semplici sovrastrutture temporanee in pali di legno, come quelle che Aristide<br />
Baragiola documentava ancora alla fine dell’Ottocento per protezione di pastori<br />
e carbonai.<br />
Successivamente, ma ormai con una tecnica mista (basamento in pietrame,<br />
elevato in legno), sorsero le prime malghe ed i masi per la fienagione. A questo<br />
punto poco conta se si usavano il Blockbau o strutture a pali verticali e incrociati<br />
e a tavolato; è anzi probabile che fossero presenti indifferentemente, magari<br />
giustapposti nella combinazione di unità edilizie sotto lo stesso tetto.<br />
Certo è che la presenza del pietrame in loco e l’assenza di fondazione (o anche<br />
di piani totalmente interrati) e calce indicano l’esistenza di edifici - impostati<br />
sul terreno o seminterrati - con larga prevalenza degli elevati in legno, ma soprattutto<br />
un convincimento radicato verso un tipo di capanna rettangolare,<br />
che originariamente nulla aveva a che vedere con una eredità romana: ad oggi<br />
non risulta nessun elemento costruttivo, magari riutilizzato, che si colleghi a<br />
tanta antichità o all’ipotesi minima di un riuso su strutture complesse e definite<br />
in una tecnica muraria vera e propria.<br />
Piuttosto ad una precisa cognizione sia territoriale, sia delle tecniche murarie<br />
rimandano per primi gli impianti di matrice romanico romanza della Valsugana,<br />
forti, militari, emblematici: la Bastia di Calceranica, il vallo di Carbonare, il castello<br />
di Vignola e Castelnuovo sul Dosso Castellare, a monte del paese omonimo<br />
in Valsugana Inferiore. In tutti questi siti un esteso lavoro di bonifica ed<br />
un audace sistema di riempimenti e murature di contenimento hanno consentito<br />
la realizzazione di un esteso impianto di murature defilate e l’utilizzo di