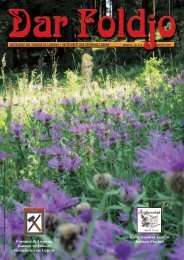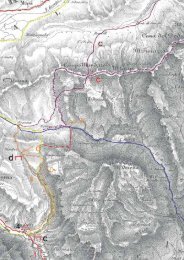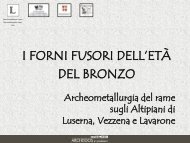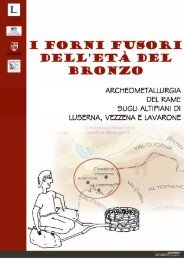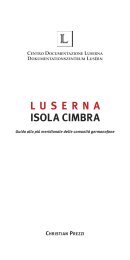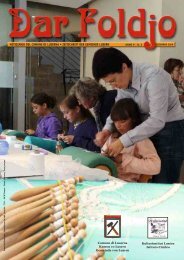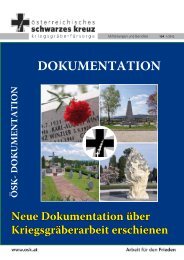volume - Centro Documentazione Luserna
volume - Centro Documentazione Luserna
volume - Centro Documentazione Luserna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
82<br />
Paolo Zammatteo<br />
I masi erano nati a servizio di tutto questo ed erano fondamentali soprattutto<br />
perché incettavano le scorte di foraggio: ovvio quindi che si trovassero ai<br />
margini dell’alpe, più vicini alle “ville”, che dovevano fruirne anche nelle condizioni<br />
più critiche per l’accessibilità, quelle invernali.<br />
A <strong>Luserna</strong> tutto questo avveniva in sostanziale equilibrio con il territorio già<br />
quando era ancora esclusivamente pascolo di Brancafora. La ragione prevalente<br />
della sopravvivenza in un ambiente non facile aveva fatto emergere la dimensione<br />
radicale dell’abitazione e del ricovero, per il foraggio come per gli animali.<br />
I caratteri delle costruzioni erano vincolati solo all’esperienza e alla funzionalità.<br />
Osservando le tracce residue negli edifici attuali, emerge che la forma della<br />
casa tradizionale rispecchia le malghe e i masi. Essi erano recinti esclusivamente<br />
a “Blockbau” (le mandre e i capanni dei pastori), oppure a tecnica mista con<br />
la fondazione e parte dell’elevato in muratura per una collocazione stabile (gli<br />
stabi, i Tablat), e infine, molto più recentemente, in pietra, appoggiati praticamente<br />
sul prato o su un terrapieno che rimediasse alla pendenza del terreno. La<br />
copertura era a due falde o a capanna, in tronchi scortecciati e incrociati. Il<br />
manto del tetto era di paglia, poiché il legno entrò in uso successivamente.<br />
Una variante sfruttava lo scavo del pendio, essendo interrata per la maggior<br />
parte. Sopra l’avvolto c’era la “tézza”, una soffitta a cui si accedeva da monte, e<br />
vi si ricettava lo strame. La scelta della tezza rispetto al tipo in linea dipendeva<br />
essenzialmente dai luoghi: ma “tézza”, o tiézo, era anche il nome dato a un’erba<br />
che cresce su terreni instabili e paludosi, e non c’è dubbio che in origine quel<br />
particolare tipo di edificio avesse funzione di fienile, in quanto meglio praticabile.<br />
Altrove ben documentato divenne modello intuitivo per la successiva evoluzione<br />
delle case. Inoltre del monte di <strong>Luserna</strong> Tezze è la frazione più vicina a<br />
Pedemonte e la prima raggiunta dal sentiero; il luogo ideale per una stallafienile,<br />
appunto.<br />
L’uso della pietra come materiale di costruzione comportò dapprima<br />
l’opportunità di affiancare le funzioni di stalla e fienile (tezza, tiezo, Tetch) intorno<br />
a una sorgente, permettendo l’evoluzione di quei nuclei aggregati, chiamati<br />
masi, che sono documentati dalla metà del Quattrocento.<br />
In seguito l’uso prevalente della pietra e degli avvolti, dove il legname scortecciato<br />
si limita al tetto, dimostra una indubbia eredità delle tecniche murarie<br />
romaniche, come è ben evidente negli esempi di malga che ancora esistono nel<br />
Ticinese e nei Grigioni, sorprendentemente simili a quelli residui delle stalle e<br />
delle case di <strong>Luserna</strong>.<br />
A un certo punto nell’aggregato d’alpeggio compaiono sempre l’abitazione<br />
(il fuoco), il fienile, la lavorazione casearia: la posizione centrale della pozza o<br />
della fontana focalizza la corte, lo spazio aperto delimitato dagli edifici.<br />
Fra XVI e XVII secolo la corte, la Hof, rappresentava il genius loci dei nuovi<br />
paleo-villaggi. Al posto delle Hofen “Niclussi” e “Trogher” entrarono in uso i