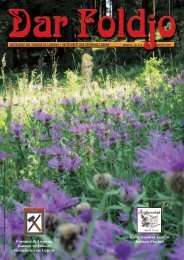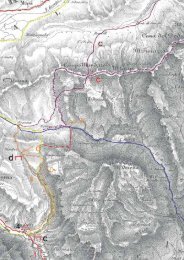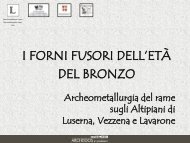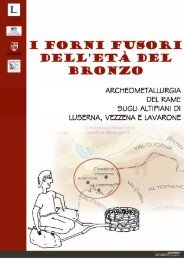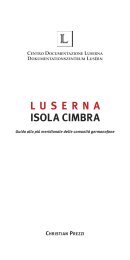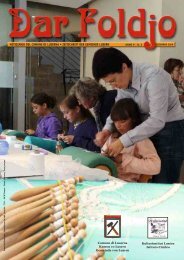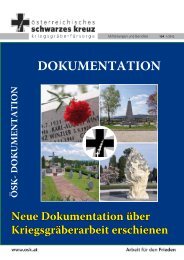volume - Centro Documentazione Luserna
volume - Centro Documentazione Luserna
volume - Centro Documentazione Luserna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’architettura di <strong>Luserna</strong> dalle origini al 1800 85<br />
Al Bivio. <strong>Luserna</strong> fra il 1866 e il 1912<br />
In un ambiente ostile per condizionamenti naturali come la montagna alpina la formazione<br />
di un primordiale habitat permanente non poteva che essere opera collettiva di gruppo.<br />
Mai per iniziativa di un singolo, ma solamente nella unione delle forze di più individui era<br />
possibile vincere le avversità e perdurare attraverso lunghi inverni spesso in completo isolamento.<br />
Del resto le strutture insediative di popolazioni primitive sono sempre e dappertutto<br />
di forma aggregata. Le organizzazioni comunitarie agro-pastorali, legate a sedi annucleate,<br />
presenti quasi ovunque nella nostra montagna, non dovrebbero avere altra origine (GEL-<br />
LNER 1988, pp. 73-75).<br />
<strong>Luserna</strong>, per le sue particolari condizioni, poté recepire questi precetti solo<br />
molto tardi, dopo lunghe trattative per l’autonomia della comunità, che si risolsero<br />
nel 1780. Malgrado ciò la realtà insediativa di <strong>Luserna</strong> è un caso emblematico<br />
della relazione stretta tra gruppo e ambiente orografico alpino e di quanto<br />
poi le culture nazionali ottocentesche abbiano modificato la concezione e la<br />
struttura stessa del territorio. Su tutta la montagna l’effetto di queste posizioni<br />
si legge nella qualità architettonica delle costruzioni, nelle strade, ma anche nelle<br />
interpretazioni storiche dell’insediamento.<br />
Ma la particolarità del dialetto in uso e la collocazione puntuale in un contesto<br />
ormai italianizzato si sovrappongono ad uno stato di marginalità originaria,<br />
con motivi ulteriori rispetto a quello già forte del confine. Vi si legge<br />
l’accettazione, probabilmente volontaria, del “confine come spazio del malinteso”.<br />
Il malinteso è, nella definizione che ne dà V. Jankélévitch, quel che permette<br />
agli uomini di continuare a non capirsi. È quel che ci permette di dire<br />
che “noi” non siamo proprio uguali “agli altri”. ... Più il tempo passa e più il malinteso si<br />
consolida, si radica nell’uso e diventa difficile se non pericoloso cercare di risolverlo e di<br />
chiarirlo (ZANINI 1997).<br />
Se si guarda alla storia del Monte di <strong>Luserna</strong> e dei suoi abitanti - e non basta<br />
riferirsi alla sopravvivenza del dialetto originario – si ha una prova formidabile<br />
della solidità di quella affermazione.<br />
Per tutto quanto attiene la progettazione, nella seconda metà dell’Ottocento<br />
si diffuse una concezione propriamente occidentale, che in architettura è vincolata<br />
alle geometrie e ai modelli teorici: a <strong>Luserna</strong> apparve assieme a nuove funzioni,<br />
come le scuole e gli alberghi, quando giunsero le ideologie risorgimentali<br />
e pangermaniste, un’ultima guerra di indipendenza, la prima di dimensioni<br />
mondiali e l’emigrazione coatta degli optanti: ma l’imprinting dell’alpe rimane<br />
ed è impresso nel palinsesto dei muri, delle scale esterne e delle case in pietra.