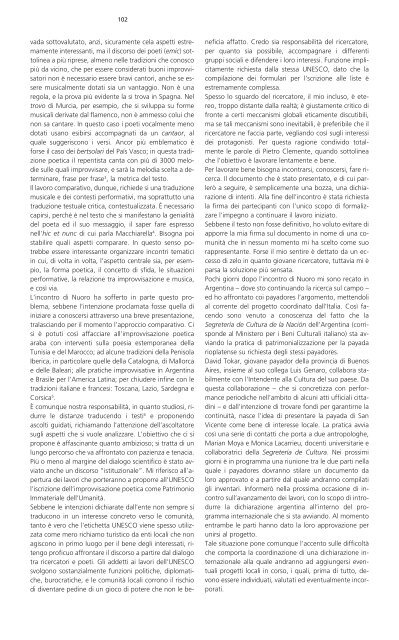Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
102<br />
vada sottovalutato, anzi, sicuramente cela aspetti estremamente<br />
interessanti, ma il discorso dei poeti (emic) sottolinea<br />
a più riprese, almeno nelle tradizioni che conosco<br />
più da vicino, che per essere considerati buoni improvvisatori<br />
non è necessario essere bravi cantori, anche se essere<br />
musicalmente dotati sia un vantaggio. Non è una<br />
regola, e la prova più evidente la si trova in Spagna. Nel<br />
trovo di Murcia, per esempio, che si sviluppa su forme<br />
musicali derivate dal flamenco, non è ammesso colui che<br />
non sa cantare. In questo caso i poeti vocalmente meno<br />
dotati usano esibirsi accompagnati da un cantaor, al<br />
quale suggeriscono i versi. Ancor più emblematico è<br />
forse il caso dei bertsolari del País Vasco; in questa tradizione<br />
poetica il repentista canta con più di 3000 melodie<br />
sulle quali improvvisare, e sarà la melodia scelta a determinare,<br />
frase per frase 3 , la metrica del testo.<br />
Il lavoro comparativo, dunque, richiede si una traduzione<br />
musicale e dei contesti performativi, ma soprattutto una<br />
traduzione testuale critica, contestualizzata. È necessario<br />
capirsi, perché è nel testo che si manifestano la genialità<br />
del poeta ed il suo messaggio, il saper fare espresso<br />
nell’hic et nunc di cui parla Macchiarella 4 . Bisogna poi<br />
stabilire quali aspetti comparare. In questo senso potrebbe<br />
essere interessante organizzare incontri tematici<br />
in cui, di volta in volta, l’aspetto centrale sia, per esempio,<br />
la forma poetica, il concetto di sfida, le situazioni<br />
performative, la relazione tra improvvisazione e musica,<br />
e così via.<br />
L’incontro di Nuoro ha sofferto in parte questo problema,<br />
sebbene l’intenzione proclamata fosse quella di<br />
iniziare a conoscersi attraverso una breve presentazione,<br />
tralasciando per il momento l’approccio comparativo. Ci<br />
si è potuti così affacciare all’improvvisazione poetica<br />
araba con interventi sulla poesia estemporanea della<br />
Tunisia e del Marocco; ad alcune tradizioni della Penisola<br />
Iberica, in particolare quelle della Catalogna, di Mallorca<br />
e delle Baleari; alle pratiche improvvisative in Argentina<br />
e Brasile per l’America Latina; per chiudere infine con le<br />
tradizioni italiane e francesi: Toscana, Lazio, Sardegna e<br />
Corsica 5 .<br />
È comunque nostra responsabilità, in quanto studiosi, ridurre<br />
le distanze traducendo i testi 6 e proponendo<br />
ascolti guidati, richiamando l’attenzione dell’ascoltatore<br />
sugli aspetti che si vuole analizzare. L’obiettivo che ci si<br />
propone è affascinante quanto ambizioso; si tratta di un<br />
lungo percorso che va affrontato con pazienza e tenacia.<br />
Più o meno al margine del dialogo scientifico è stato avviato<br />
anche un discorso “istituzionale”. Mi riferisco all’apertura<br />
dei lavori che porteranno a proporre all’UNESCO<br />
l’iscrizione dell’improvvisazione poetica come Patrimonio<br />
Immateriale dell’Umanità.<br />
Sebbene le intenzioni dichiarate dall’ente non sempre si<br />
traducono in un interesse concreto verso le comunità,<br />
tanto è vero che l’etichetta UNESCO viene spesso utilizzata<br />
come mero richiamo turistico da enti locali che non<br />
agiscono in primo luogo per il bene degli interessati, ritengo<br />
proficuo affrontare il discorso a partire dal dialogo<br />
tra ricercatori e poeti. Gli addetti ai lavori dell’UNESCO<br />
svolgono sostanzialmente funzioni politiche, diplomatiche,<br />
burocratiche, e le comunità locali corrono il rischio<br />
di diventare pedine di un gioco di potere che non le be-<br />
neficia affatto. Credo sia responsabilità del ricercatore,<br />
per quanto sia possibile, accompagnare i differenti<br />
gruppi sociali e difendere i loro interessi. Funzione implicitamente<br />
richiesta dalla stessa UNESCO, dato che la<br />
compilazione dei formulari per l’scrizione alle liste è<br />
estremamente complessa.<br />
Spesso lo sguardo del ricercatore, il mio incluso, è etereo,<br />
troppo distante dalla realtà; è giustamente critico di<br />
fronte a certi meccanismi globali eticamente discutibili,<br />
ma se tali meccanismi sono inevitabili, è preferibile che il<br />
ricercatore ne faccia parte, vegliando così sugli interessi<br />
dei protagonisti. Per questa ragione condivido totalmente<br />
le parole di Pietro Clemente, quando sottolinea<br />
che l’obiettivo è lavorare lentamente e bene.<br />
Per lavorare bene bisogna incontrarsi, conoscersi, fare ricerca.<br />
Il documento che è stato presentato, e di cui parlerò<br />
a seguire, è semplicemente una bozza, una dichiarazione<br />
di intenti. Alla fine dell’incontro è stata richiesta<br />
la firma dei partecipanti con l’unico scopo di formalizzare<br />
l’impegno a continuare il lavoro iniziato.<br />
Sebbene il testo non fosse definitivo, ho voluto evitare di<br />
apporre la mia firma sul documento in nome di una comunità<br />
che in nessun momento mi ha scelto come suo<br />
rappresentante. Forse il mio sentire è dettato da un eccesso<br />
di zelo in quanto giovane ricercatore, tuttavia mi è<br />
parsa la soluzione più sensata.<br />
Pochi giorni dopo l’incontro di Nuoro mi sono recato in<br />
Argentina – dove sto continuando la ricerca sul campo –<br />
ed ho affrontato coi payadores l’argomento, mettendoli<br />
al corrente del progetto coordinato dall’Italia. Così facendo<br />
sono venuto a conoscenza del fatto che la<br />
Segretería de Cultura de la Nación dell’Argentina (corrisponde<br />
al Ministero per i Beni Culturali italiano) sta avviando<br />
la pratica di patrimonializzazione per la payada<br />
rioplatense su richiesta degli stessi payadores.<br />
David Tokar, giovane payador della provincia di Buenos<br />
Aires, insieme al suo collega Luis Genaro, collabora stabilmente<br />
con l’Intendente alla Cultura del suo paese. Da<br />
questa collaborazione – che si concretizza con performance<br />
periodiche nell’ambito di alcuni atti ufficiali cittadini<br />
– e dall’intenzione di trovare fondi per garantirne la<br />
continuità, nasce l’idea di presentare la payada di San<br />
Vicente come bene di interesse locale. La pratica avvia<br />
così una serie di contatti che porta a due antropologhe,<br />
Marian Moya e Monica Lacarrieu, docenti universitarie e<br />
collaboratrici della Segretería de Cultura. Nei prossimi<br />
giorni è in programma una riunione tra le due parti nella<br />
quale i payadores dovranno stilare un documento da<br />
loro approvato e a partire dal quale andranno compilati<br />
gli inventari. Informerò nella prossima occasione di incontro<br />
sull’avanzamento dei lavori, con lo scopo di introdurre<br />
la dichiarazione argentina all’interno del programma<br />
internazionale che si sta avviando. Al momento<br />
entrambe le parti hanno dato la loro approvazione per<br />
unirsi al progetto.<br />
Tale situazione pone comunque l’accento sulle difficoltà<br />
che comporta la coordinazione di una dichiarazione internazionale<br />
alla quale andranno ad aggiungersi eventuali<br />
progetti locali in corso, i quali, prima di tutto, devono<br />
essere individuati, valutati ed eventualmente incorporati.