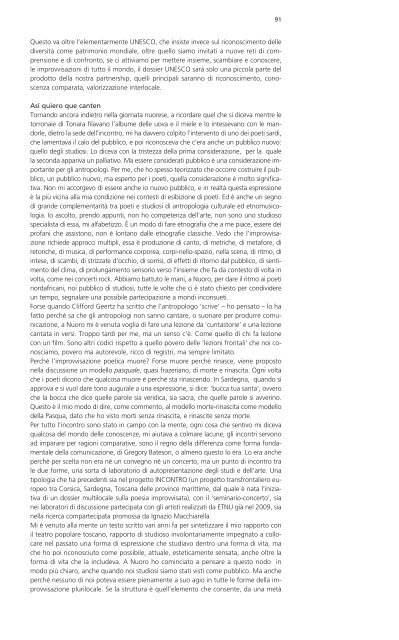Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Questo va oltre l’elementarmente UNESCO, che insiste invece sul riconoscimento delle<br />
diversità come patrimonio mondiale, oltre quello siamo invitati a nuove reti di comprensione<br />
e di confronto, se ci attiviamo per mettere insieme, scambiare e conoscere,<br />
le improvvisazioni di tutto il mondo, il dossier UNESCO sarà solo una piccola parte del<br />
prodotto della nostra partnership, quelli principali saranno di riconoscimento, conoscenza<br />
comparata, valorizzazione interlocale.<br />
Así quiero que canten<br />
Tornando ancora indietro nella giornata nuorese, a ricordare quel che si diceva mentre le<br />
torronaie di Tonara filavano l’albume delle uova e il miele e lo intessevano con le mandorle,<br />
dietro la sede dell’incontro, mi ha davvero colpito l’intervento di uno dei poeti sardi,<br />
che lamentava il calo del pubblico, e poi riconosceva che c’era anche un pubblico nuovo:<br />
quello degli studiosi. Lo diceva con la tristezza della prima considerazione, per la quale<br />
la seconda appariva un palliativo. Ma essere considerati pubblico è una considerazione importante<br />
per gli antropologi. Per me, che ho spesso teorizzato che occorre costruire il pubblico,<br />
un pubblico nuovo, ma esperto per i poeti, quella considerazione è molto significativa.<br />
Non mi accorgevo di essere anche io nuovo pubblico, e in realtà questa espressione<br />
è la più vicina alla mia condizione nei contesti di esibizione di poeti. Ed è anche un segno<br />
di grande complementarità tra poeti e studiosi di antropologia culturale ed etnomusicologia.<br />
Io ascolto, prendo appunti, non ho competenza dell’arte, non sono uno studioso<br />
specialista di essa, mi alfabetizzo. È un modo di fare etnografia che a me piace, essere dei<br />
profani che assistono, non è lontano dalle etnografie classiche. Vedo che l’improvvisazione<br />
richiede approcci multipli, essa è produzione di canto, di metriche, di metafore, di<br />
retoriche, di musica, di performance corporea, corpi-nello-spazio, nella scena, di ritmo, di<br />
intese, di scambi, di strizzate d’occhio, di sorrisi, di effetti di ritorno dal pubblico, di sentimento<br />
del clima, di prolungamento sensorio verso l’insieme che fa da contesto di volta in<br />
volta, come nei concerti rock. Abbiamo battuto le mani, a Nuoro, per dare il ritmo ai poe ti<br />
nordafricani, noi pubblico di studiosi, tutte le volte che ci è stato chiesto per condividere<br />
un tempo, segnalare una possibile partecipazione a mondi inconsueti.<br />
Forse quando Clifford Geertz ha scritto che l’antropologo ‘scrive’ – ho pensato – lo ha<br />
fatto perché sa che gli antropologi non sanno cantare, o suonare per produrre comunicazione,<br />
a Nuoro mi è venuta voglia di fare una lezione da ‘cuntastorie’ e una lezione<br />
cantata in versi. Troppo tardi per me, ma un senso c’è. Come quello di chi fa lezione<br />
con un film. Sono altri codici rispetto a quello povero delle ‘lezioni frontali’ che noi conosciamo,<br />
povero ma autorevole, ricco di registri, ma sempre limitato.<br />
Perché l’improvvisazione poetica muore? Forse muore perché rinasce, viene proposto<br />
nella discussione un modello pasquale, quasi frazeriano, di morte e rinascita. Ogni volta<br />
che i poeti dicono che qualcosa muore è perché sta rinascendo. In Sardegna, quando si<br />
approva e si vuol dare tono augurale a una espressione, si dice: ‘bucca tua santa’, ovvero<br />
che la bocca che dice quelle parole sia veridica, sia sacra, che quelle parole si avverino.<br />
Questo è il mio modo di dire, come commento, al modello morte-rinascita come modello<br />
della Pasqua, dato che ho visto morti senza rinascita, e rinascite senza morte.<br />
Per tutto l’incontro sono stato in campo con la mente, ogni cosa che sentivo mi diceva<br />
qualcosa del mondo delle conoscenze, mi aiutava a colmare lacune, gli incontri servono<br />
ad imparare per ragioni comparative, sono il regno della differenza come forma fondamentale<br />
della comunicazione, di Gregory Bateson, o almeno questo lo era. Lo era anche<br />
perché per scelta non era né un convegno né un concerto, ma un punto di incontro tra<br />
le due forme, una sorta di laboratorio di autopresentazione degli studi e dell’arte. Una<br />
tipologia che ha precedenti sia nel progetto INCONTRO (un progetto transfrontaliero europeo<br />
tra Corsica, Sardegna, Toscana delle province marittime, dal quale è nata l’iniziativa<br />
di un dossier multilocale sulla poesia improvvisata), con il ‘seminario-concerto’, sia<br />
nei laboratori di discussione partecipata con gli artisti realizzati da ETNU già nel 2009, sia<br />
nella ricerca compartecipata promossa da Ignazio Macchiarella.<br />
Mi è venuto alla mente un testo scritto vari anni fa per sintetizzare il mio rapporto con<br />
il teatro popolare toscano, rapporto di studioso involontariamente impegnato a collocare<br />
nel passato una forma di espressione che studiavo dentro una forma di vita, ma<br />
che ho poi riconosciuto come possibile, attuale, esteticamente sensata, anche oltre la<br />
forma di vita che la includeva. A Nuoro ho cominciato a pensare a questo nodo in<br />
modo più chiaro, anche quando noi studiosi siamo stati visti come pubblico. Ma anche<br />
perché nessuno di noi poteva essere pienamente a suo agio in tutte le forme della improvvisazione<br />
plurilocale. Se la struttura è quell’elemento che consente, da una metà<br />
91