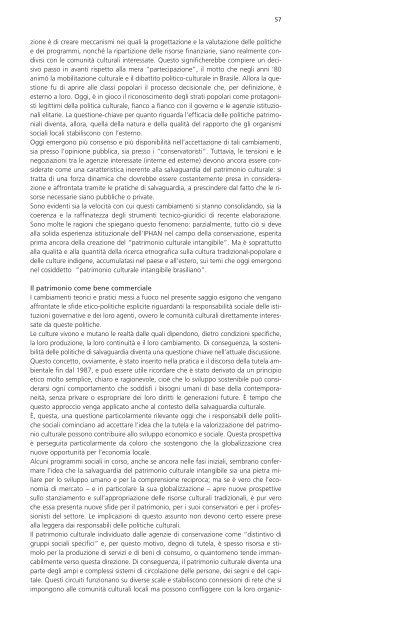Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Antropologia museale, n. 28-29, 2011 - Dipartimento Storia Culture ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
zione è di creare meccanismi nei quali la progettazione e la valutazione delle politiche<br />
e dei programmi, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie, siano realmente condivisi<br />
con le comunità culturali interessate. Questo significherebbe compiere un decisivo<br />
passo in avanti rispetto alla mera “partecipazione”, il motto che negli anni ’80<br />
animò la mobilitazione culturale e il dibattito politico-culturale in Brasile. Allora la questione<br />
fu di aprire alle classi popolari il processo decisionale che, per definizione, è<br />
esterno a loro. Oggi, è in gioco il riconoscimento degli strati popolari come protagonisti<br />
legittimi della politica culturale, fianco a fianco con il governo e le agenzie istituzionali<br />
elitarie. La questione-chiave per quanto riguarda l’efficacia delle politiche patrimoniali<br />
diventa, allora, quella della natura e della qualità del rapporto che gli organismi<br />
sociali locali stabiliscono con l’esterno.<br />
Oggi emergono più consenso e più disponibilità nell’accettazione di tali cambiamenti,<br />
sia presso l’opinione pubblica, sia presso i “conservatoristi”. Tuttavia, le tensioni e le<br />
negoziazioni tra le agenzie interessate (interne ed esterne) devono ancora essere considerate<br />
come una caratteristica inerente alla salvaguardia del patrimonio culturale: si<br />
tratta di una forza dinamica che dovrebbe essere costantemente presa in considerazione<br />
e affrontata tramite le pratiche di salvaguardia, a prescindere dal fatto che le risorse<br />
necessarie siano pubbliche o private.<br />
Sono evidenti sia la velocità con cui questi cambiamenti si stanno consolidando, sia la<br />
coerenza e la raffinatezza degli strumenti tecnico-giuridici di recente elaborazione.<br />
Sono molte le ragioni che spiegano questo fenomeno: parzialmente, tutto ciò si deve<br />
alla solida esperienza istituzionale dell’IPHAN nel campo della conservazione, esperita<br />
prima ancora della creazione del “patrimonio culturale intangibile”. Ma è soprattutto<br />
alla qualità e alla quantità della ricerca etnografica sulla cultura tradizional-popolare e<br />
delle culture indigene, accumulatasi nel paese e all’estero, sui temi che oggi emergono<br />
nel cosiddetto “patrimonio culturale intangibile brasiliano”.<br />
Il patrimonio come bene commerciale<br />
I cambiamenti teorici e pratici messi a fuoco nel presente saggio esigono che vengano<br />
affrontate le sfide etico-politiche esplicite riguardanti la responsabilità sociale delle istituzioni<br />
governative e dei loro agenti, ovvero le comunità culturali direttamente interessate<br />
da queste politiche.<br />
Le culture vivono e mutano le realtà dalle quali dipendono, dietro condizioni specifiche,<br />
la loro produzione, la loro continuità e il loro cambiamento. Di conseguenza, la sostenibilità<br />
delle politiche di salvaguardia diventa una questione chiave nell’attuale discussione.<br />
Questo concetto, ovviamente, è stato inserito nella pratica e il discorso della tutela ambientale<br />
fin dal 1987, e può essere utile ricordare che è stato derivato da un principio<br />
etico molto semplice, chiaro e ragionevole, cioè che lo sviluppo sostenibile può considerarsi<br />
ogni comportamento che soddisfi i bisogni umani di base della contemporaneità,<br />
senza privare o espropriare dei loro diritti le generazioni future. È tempo che<br />
questo approccio venga applicato anche al contesto della salvaguardia culturale.<br />
È, questa, una questione particolarmente rilevante oggi che i responsabili delle politiche<br />
sociali cominciano ad accettare l’idea che la tutela e la valorizzazione del patrimonio<br />
culturale possono contribuire allo sviluppo economico e sociale. Questa prospettiva<br />
è perseguita particolarmente da coloro che sostengono che la globalizzazione crea<br />
nuove opportunità per l’economia locale.<br />
Alcuni programmi sociali in corso, anche se ancora nelle fasi iniziali, sembrano confermare<br />
l’idea che la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile sia una pietra miliare<br />
per lo sviluppo umano e per la comprensione reciproca; ma se è vero che l’economia<br />
di mercato – e in particolare la sua globalizzazione – apre nuove prospettive<br />
sullo stanziamento e sull’appropriazione delle risorse culturali tradizionali, è pur vero<br />
che essa presenta nuove sfide per il patrimonio, per i suoi conservatori e per i professionisti<br />
del settore. Le implicazioni di questo assunto non devono certo essere prese<br />
alla leggera dai responsabili delle politiche culturali.<br />
Il patrimonio culturale individuato dalle agenzie di conservazione come “distintivo di<br />
gruppi sociali specifici” e, per questo motivo, degno di tutela, è spesso risorsa e stimolo<br />
per la produzione di servizi e di beni di consumo, o quantomeno tende immancabilmente<br />
verso questa direzione. Di conseguenza, il patrimonio culturale diventa una<br />
parte degli ampi e complessi sistemi di circolazione delle persone, dei segni e del capitale.<br />
Questi circuiti funzionano su diverse scale e stabiliscono connessioni di rete che si<br />
impongono alle comunità culturali locali ma possono confliggere con la loro organiz-<br />
57