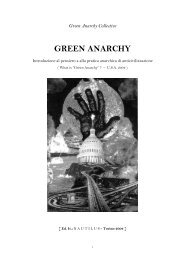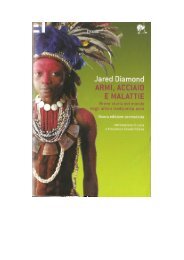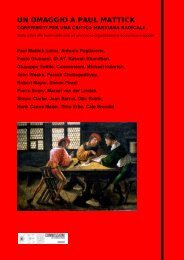Nicholas Georgescu-Roegen, Bioeconomia, 2003 - contra-versus
Nicholas Georgescu-Roegen, Bioeconomia, 2003 - contra-versus
Nicholas Georgescu-Roegen, Bioeconomia, 2003 - contra-versus
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
144<br />
CAPITOLO SESTO<br />
Per l'entropia della miscela semplice di due gas ideali distinti che<br />
siano alla stessa pressione P e alla stessa temperatura T, vale la famosa<br />
formula di Gibbs:<br />
dove m, + m, = m è la somma delle moli, R è la costante del gas e<br />
a,, C, le caratteristiche fisiche dei gas. La miscelazione di due gas<br />
con la stessa temperatura e la stessa pressione fa quindi aumentare<br />
l'entropia diL9<br />
una formula molto nota, che attualmente viene applicata più o<br />
meno a proposito.<br />
Di solito questa formula viene citata con riferimento a un paradosso<br />
evidenziato dallo stesso Gibbs (cfr. Seeger 1974): se i due gas<br />
sono identici, la [6] è sempre positiva, anche se la miscela non provoca<br />
alcun cambiamento entropico. C'è però un altro aspetto della<br />
[6] che deriva da un'osservazione di Max Planck (1706, p. 104) e<br />
che è pertinente a questa discussione: Planck ha osservato che per<br />
quanto riguarda la [6], «sarebbe più appropriato parlare di dissipazione<br />
di materia che di dissipazione di energia».20<br />
Secondo le formule sia [6] sia [5], per una data m si ha la massima<br />
dissipazione quando m, = m,. Si consideri però il caso in cui<br />
m, = 1 e m, = 10loO; allora AS diventa del tutto trascurabile; ma,<br />
secondo un concetto intuitivo di dissipazione, sembra logico sostenere<br />
che, se ilgas 1 è quello che conta, la dissipazione, dal punto di<br />
vista dell'uo,mo, è molto maggiore in questo secondo caso che non<br />
nel primo. E in quest'ultimo caso che si può veramente dire che<br />
una mole del gas 1 non è più disponibile; in effetti, riunire quelle<br />
l9 Dato che questo stesso particolare tecnico si ripresenterà nel I 6, può esscrc opportuno<br />
aggiungere chc I'entalpia, H, non cambia. L'entalpia, che corrisponde d a nozione intuitiva di<br />
contenuto calorico, è la quantiti di energia termica necessaria per portare una soitanza dallo zero<br />
assoluto alla sua temperatura attuale a pressione costante; in pratica I'entalpia è il potere ca-<br />
lorifico di un combustibile, cioè la qiiantità massima di energia termica ottenibile facendolo<br />
bruciare.<br />
Comprerisibilrnente, Planck non disse *dissipazione di massa».<br />
ANALISI ENERGETICA E VAI.UTAZIONti ECONOiMIC~l I45<br />
molecole sarebbe arduo quanto riunire le molecole dell'aria che re-<br />
spirò Platone, molte delle quali fanno parte di ogni respiro che ina-<br />
liamo!<br />
È ovvio che si possono ritrovare tutte le perle di una collana che<br />
si sia rotta in una stanza, in un teatro, o addirittura in qualche punto<br />
di Manhattan, purché si sia disposti a impiegare tempo ed energia<br />
sufficienti e a consumare numerosi oggetti nella ricerca; ma l'estra-<br />
polazione di questo processo macroscopico al livello microscopico<br />
deile molecole, o anche di piccoli pezzi di materia, è chiaramente<br />
inammissibile. In base a tutto quel che sappiamo, come si può cre-<br />
dere alla possibilità di riunire, anche se non proprio tutte, pratica-<br />
mente tutte le molecole di gomma dei pneumatici consumati, tutto<br />
il piombo dissipato attraverso i tubi di scappamento, o tutto il rame<br />
delle monete logorate con l'uso? E addirittura in un tempo finito e<br />
ragionevole? Si deve concludere che a livello microscopico il pro-<br />
cesso che permette di riunire le perle di una collana rotta richiede-<br />
rebbe, oltre a strumenti difficilmente concepibili, un tempo infi-<br />
nito. Si tratta quindi di un'operazione che appartiene alla stessa<br />
categoria della macchina irreversibile e al progetto di Planck per<br />
utilizzare il calore degli oceani. Planck conclude addirittura che,<br />
dato che AS>O, «la diffusione, come l'attrito e la conduzione del ca-<br />
lore, è un processo irreversibile» (Planck 1906, p. 113; 1910, p. 78).<br />
L'analisi precedente mostra comunque come la [6] dia una mi-<br />
sura dell'intensità di diffusione opposta a quella che sembrerebbe<br />
ragionevole, dato il tipo di operazione che attualmente effettuiamo<br />
sulla materia: secondo quella formula, mescolare un vagone di aghi<br />
1 con un vagone di paglia provoca una diffusione maggiore che non<br />
perdere quell'ago particolare in un vagone di paglia; il problema del<br />
suo ritrovamento corrisponde al problema di un riciclaggio com-<br />
pleto a queilo dell'estrazione di un minerale da una roccia qual-<br />
siasi. E facile estrarre metallo da un giacimento ricco, ma il com-<br />
pito diventa sempre più difficile con la diminuzione del contenuto<br />
metallico, e per un contenuto, per esempio, di 10-'"' diventa im-<br />
possibile.<br />
Si considerino due miscugli, uno di 10 t di limatura di ferro con<br />
10 t di sabbia fine, l'altro di 10 t di limatura di ferro con 10 miliardi<br />
di t di sabbia fine; sebbene il contenuto di ferro sia lo stesso nei due