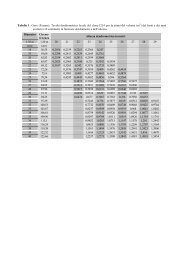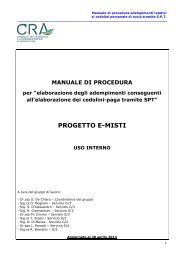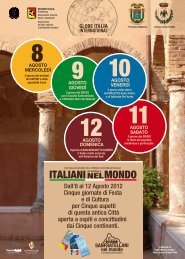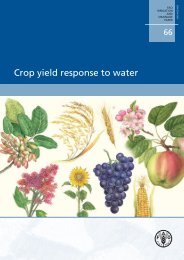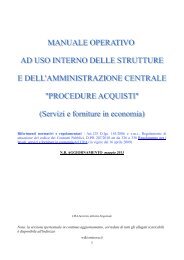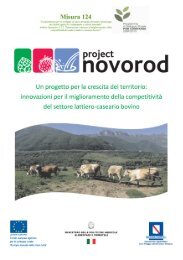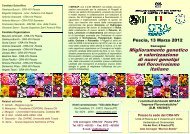Progetto Co.Al.Ta. II Sintesi dei risultati - Cra
Progetto Co.Al.Ta. II Sintesi dei risultati - Cra
Progetto Co.Al.Ta. II Sintesi dei risultati - Cra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Damiani.qxp 25/02/2008 10.08 Pagina 77<br />
Introduzione<br />
La valorizzazione del carciofo di Pietrelcina è una<br />
delle strategie proposte nel progetto COALTA1 per<br />
sostituire la coltivazione del tabacco nell'area del<br />
beneventano. <strong>Ta</strong>le coltura diffusa da oltre un secolo<br />
nella zona presenta due significative caratteristiche<br />
che la rendono particolarmente interessante: la<br />
tardività che gli permette di fornire prodotto in un<br />
periodo in cui il carciofo locale è assente e l'alto<br />
contenuto di inulina che lo rendono particolarmene<br />
adatto per la terapia di disfunzioni meataboliche<br />
<strong>dei</strong> lipidi e <strong>dei</strong> glucidi (del Piano et al., 2006).<br />
L'analisi di tali caratteristiche in carciofaie della<br />
zona ha mostrato tuttavia una variabilità tra ed<br />
entro carciofaie che giustifica ulteriori studi per<br />
caratterizzare la variabilità entro piante dell'accessione<br />
e per definire un genotipo tipico di<br />
Pietrelcina che si disitngua anche molecolarmente<br />
dal carciofo Romanesco da cui indubitabilmente<br />
deriva. Lo scopo di tale lavoro è stato quindi lo studio<br />
tramite marcatori molecolari della variabilità<br />
genetica della specie Cynara scolymus L. con l'intento<br />
applicativo di definire un pattern molecolare<br />
distintivo di cv locali campane.<br />
Materiali e metodi<br />
E' stato estratto il DNA da 66 piante: 38 piante da<br />
13 aziende della zona di Pietrelcina, 6 dell'ecotipo<br />
Pietrelcina conservato presso la banca del germoplasma<br />
del CRPV di Sassari (piante 7.x), 16 di carciofo<br />
Capuanello da due aziende (piante 5.x e 6.x), 4 di<br />
Romanesco recuperate in centro e sud Italia (9.x e<br />
4.x), e due altre piante fuori tipo (8 ecotipo Scafati e<br />
10 allungato umbro). L'analisi molecolare è stata<br />
eseguita valutando il polimorfismo di regioni microsatellitarie<br />
e il polimorfismo generato con la tecnica<br />
AFLP (Vos et al., 1995) utilizzando una sola coppia<br />
di primer derivati dalla restrizione con gli enzimi<br />
EcoRI e MseI ed utilizzando le basi selettive ACT e<br />
CAA ai due rispettivi siti di taglio. E' stata anche<br />
<strong>Progetto</strong> <strong>Co</strong>.<strong>Al</strong>.<strong>Ta</strong>. <strong>II</strong> 77<br />
Caratterizzazione molecolare di accessioni di carciofo di<br />
Pietrelcina<br />
<strong>Ta</strong>viani P, Menconi L, Rubini A, <strong>Co</strong>zzolino E 1 , Leone V 1 , Damiani F<br />
Istituto Genetica Vegetale CNR via Madonna <strong>Al</strong>ta 130, 06128<br />
Perugia 075 5014862, fax 0755014869,<br />
francesco.damiani@igv.cnr.it;<br />
1Unità di ricerca per le colture alternative al tabacco CRA, via<br />
Vitiello 116, 84018 Scafati (SA)<br />
applicata la tecnica S-Sap che consiste nell'amplificazione<br />
di DNA ristretto con un primer ancorato al<br />
sito di taglio ed uno ricavato dalla sequenza di un<br />
retrotrasposone endogeno. Per l' S-Sap sono stati utilizzati<br />
primer ancorati al sito di taglio MseI aventi le<br />
basi selettive CAA, CAC e CAT in combinazione<br />
con un primer disegnato sul retrotrasposone<br />
CYRE5 (Acquadro et al., 2006). Nell'analisi <strong>dei</strong><br />
<strong>risultati</strong>, i profili di ogni combinazione di primers<br />
sono stati riportati come dati di presenza assenza<br />
della banda per ogni campione costruendo una<br />
matrice binaria unica per S-SAP e AFLP, da cui è<br />
stata calcolata la matrice delle distanze genetiche<br />
con l'indice di Nei, seguita da una analisi cluster con<br />
il metodo UPGMA e rappresentata graficamente da<br />
un dendrogramma elaborato con il software<br />
NTSYS-pc (Rohlf, 1993). Per l'analisi <strong>dei</strong> microsatelliti<br />
ci si è basati sulle tecniche ed i primer sviluppati<br />
in carciofo da Acquadro et al (2003; 2005).<br />
Sono state utilizzate 12 combinazioni di primer SSR<br />
e per ogni coppia di primer è stato mantenuto il<br />
nome del codice del locus. Per un confronto diretto<br />
<strong>dei</strong> <strong>risultati</strong> ottenuti con i marcatori "multi-locus"<br />
(S-SAP e AFLP) e a "singolo locus" (SSR) è stata<br />
eseguita un'analisi di raggruppamento cluster con<br />
relativo dendrogramma anche dalla matrice della<br />
distanza genetica costruita con i marcatori SSR. Le<br />
due matrici sono state quindi combinate e con le<br />
stesse modalità si è costruito un dendogramma complessivo<br />
della variabilità genetica osservata.<br />
Risultati<br />
Dall'analisi AFLP e S-SAP si sono ottenute 141<br />
bande polimorfiche, mentre l'analisi SSR condotta<br />
su 12 loci ha evidenziato la presenza di un totale di<br />
26 alleli. Di questi, 3 alleli sono presenti in tutte le<br />
piante del controllo Pietrelcina (piante 7.x) e non<br />
condivisi con altre accessioni ad eccezione di uno<br />
con la n. 10. I dendogrammi ottenuti dall'analisi di<br />
similarità con i due tipi di marcatori danno <strong>risultati</strong><br />
molto simili e l'ulteriore elaborazione ottenuta<br />
raggrupando tutti i dati è riportata in fig. 1.<br />
Solo due accessioni ( n.7 e n. 6) risultano omogenee<br />
e distinguibili, le 38 piante collezionate nella<br />
zona di Pietrelcina sono alquanto eterogenee,