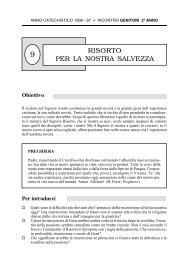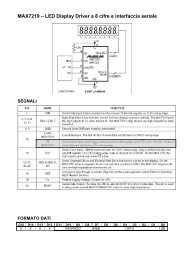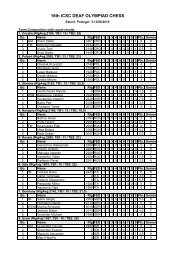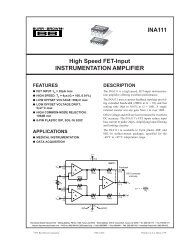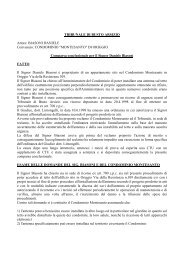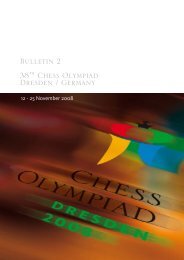La composizione chimica del protoplasma;
La composizione chimica del protoplasma;
La composizione chimica del protoplasma;
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
15Supponendo anche di avere <strong>del</strong>le cellule <strong>del</strong>lo spessore adatto per l’osservazione nonostante questonon potrebbero sopravvivere a lungo ad una osservazione visto che il microscopio non è il loroambiente ideale ed è anche per questo motivo che si usano cellule coltivate in vitro.<strong>La</strong> morte <strong>del</strong>la cellula rappresenta un problema per l’osservazione in quanto i tessuti vanno incontroad una rapida degenerazione falsando il risultato <strong>del</strong>l’osservazione, per questo motivo la cellula deveessere opportunamente preparata.<strong>La</strong> preparazione avviene attraverso una serie di passaggi che sono:- fissazione: consiste nell’uccidere la cellula con un procedimento che non rovini i tessuti coni cosiddetti cross leganti che stabiliscono legami covalenti fra le molecole.Alcuni esempi di queste sostanze sono: gli aldeidi (formaldeide, formalina eglutoraldeide) e l’alcool etilico, l’alcool metilico, l’acetone e il cloroformio.Generalmente vengono usati in soluzione acquosa.Si usano anche dei procedimenti fisici anche se meno frequentemente che sono: usodi calore e congelamento.- inclusione: per procedere all’affettamento <strong>del</strong>la cellula è necessario renderla rigida e questo siottiene con l’inclusione. Tale processo consiste nel far penetrare in tutti gli interstizi<strong>del</strong>la cellula la paraffina (bagno di paraffina) che a 50 - 60 °C è liquida mentre atemperatura ambiente solidifica. Non essendo però compatibile con l’acqua ènecessario disidratare il campione con soluzioni di alcool a concentrazioni crescenti.<strong>La</strong> paraffina non interagisce però con l’alcool per cui bisogna usare degli intermediaricome il toluolo o il benzolo.Vi è però un problema, molte molecole lipidiche vengono eliminate durante iltrattamento così ultimamente al posto <strong>del</strong>la paraffina si usano dei monomeri chevengono in seguito polimerizzati cioè induriti.A questo punto il preparato può essere affettato con l’uso di microtomi.- colorazione: si usano coloranti in soluzioni acquose e, per questo è necessario rimuovere laparaffina con benzolo (sparaffinate) poi, bisogna reidratare progressivamente ilcampione. Ora si può procedere alla colorazione.I coloranti si legano a diverse componenti <strong>del</strong>la cellula spesso sfruttando leinterazioni fra molecole acide e molecole basiche.A questo punto si può “montare” il preparato chiuso tra due vetrini di basso spessore e conl’aggiunta di alcune resine sintetiche che conservano il campione.Microscopio elettronico a trasmissione;Nel microscopio elettronico al posto di radiazioni luminose si utilizzano fasci di elettroni.<strong>La</strong> risoluzione <strong>del</strong> microscopio elettronico è dipendente dal voltaggio al quale lavora, la tensione ècompresa tra 10.000 e 100.000 Volt.Per l’osservazione biologica si usano regolarmente tensioni intermedie <strong>del</strong>l’ordine dei 50.000 Volt;con questa tensione si ottiene una risoluzione teorica di 0,2 nm mentre quella reale è leggermenteinferiore: 2 - 5 A.Lo spessore dei preparati deve essere inferiore a quello dei preparati per la microscopia ottica, infattideve essere pari a 70 nm.Il microscopio elettronico è costituito da una colonna di dimensioni considerevoli (altezza di 2 m.)sulla sommità <strong>del</strong>la quale è posto il catodo costituito da un filamento di tungsteno che resoincandescente emette elettroni.Questi stessi elettroni attraversano l’anodo sottostante che serve a focalizzare il fascio.