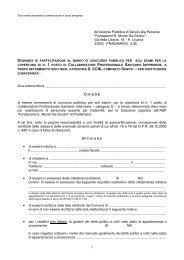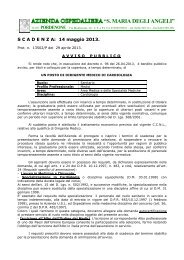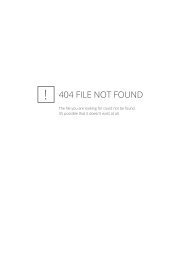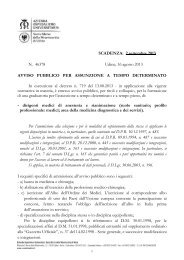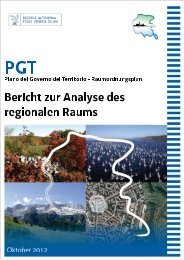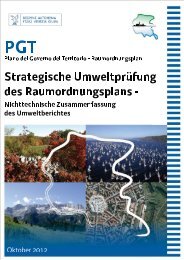Tiere furlane 3 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Tiere furlane 3 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Tiere furlane 3 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
84 •<br />
Pe n z i 2007 = Diogene Penzi,<br />
Vicende socio-economiche del<br />
contado di Fanna-Cavasso nel<br />
1700, Tipografi a Sartor, Pordenone,<br />
2007.<br />
Pi r o n a 1862 = Giulio Andrea<br />
Pirona, Vocabolario botanico<br />
friulano, Tipografi a Giuseppe<br />
Seitz, Udine, 1862.<br />
rizzolatti 1991 = andreina<br />
Ciceri, Piera Rizzolatti, Vita<br />
tradizionale in Val Pesarina,<br />
Parte seconda, Comune di Prato<br />
Carnico, 1991.<br />
ru B i n i 1909 = Domenico Rubini,<br />
Bullettino della Associazione<br />
agraria friulana, serie V, volume<br />
XXVI, 1909.<br />
sPizzo 2009 = Antonietta Spizzo,<br />
I fagioli di Pradumbli, in Miceli<br />
Al nasseve dut! Autoproduzione di sementi in<br />
Ara di Tricesimo<br />
Fabiano, Costantini Enos (a cura<br />
di), La biodiversità coltivata -<br />
Storie di persone e agricoltura<br />
tradizionale tra <strong>Friuli</strong> e Carinzia,<br />
Forum, Udine, 2009.<br />
za n n i e r 1992 = Sergio Zannier,<br />
Il cibo della quotidianità, in<br />
Michelutti Manlio (a cura di),<br />
Âs, Int e Cjere, Società fi lologica<br />
friulana, Udine, 1992.<br />
La fi losofi a del nonno era basica, ma granitica: no si strasse, no si bute vie nie, no si compre ce che si po fâ di bessôi.<br />
Applicata all’orto signifi cava autoproduzione delle sementi nei limiti del possibile.<br />
Così Angelo Bertino (1902 - 1983), nativo di Colloredo di Montalbano, ma che per tanti anni ha fatto parte della mia famiglia in<br />
Ara di Tricesimo, faceva in proprio le sementi di (lasciatemi usare i nomi nella sua lingua): lidric di tai, salate verzelade, savôrs,<br />
fasûi (Borlot alt), vuaìnis (plachis, lungjis, verdis), fasuli neri (une “miezelane”: ne fasuli ne vuaine; cuant che la vuaine e jere tant<br />
fate si faseve in padiele, si lis crevave un tic e si tirave vie il fîl), cocis (il coçut clâr al faseve masse tripe, chel vert a ’n fâs mancul),<br />
cudumars (mangjâju piçui; se tu ju lassis vignî ogni tic grancj a fasin la panse), pomodoros, ai, camomile...<br />
Per il radicchio il procedimento era il seguente: le piante ritenute più interessanti erano lasciate andare a seme, poi il nonno le raccoglieva<br />
in mazzi che appendeva ad una trave in luogo ventilato. Una volta essiccati sbriciolava con le mani le parti che portavano<br />
i semi e poi utilizzava un setaccio per separare i semi dalle impurità. Se la quantità era elevata ricorreva alla val (il verbo è valâ o<br />
svalâ), un arnese di vimini fatto a conchiglia, con due anse e col margine ribassato da un lato (Nuovo Pirona) che serve a mondare<br />
le sementi agitandole: al faseve i macs e ju picjave; cuant ch’al ere sut lu specolave cu lis mans, po lu tamesave planc planc, e<br />
s’al ere tant al doprave la val par svalâ el penç.<br />
Per altre essenze come prezzemolo e insalate il procedimento era simile. Le piante da essiccare potevano anche essere poste su<br />
dei panni e, quindi, battute per separare i semi dai fusti.<br />
I fagioli erano lasciati secjâ su la plante, poi portati sul cjast (no vignive la bestie in chê volte), quindi erano specolâts e la cernita<br />
veniva fatta sul tavolo della cucina.<br />
Pomodori, zucche e cetrioli erano evidentemente soggetti ad un trattamento diverso. Il primo frutto, tanto atteso, non doveva essere<br />
raccolto per nessuna ragione, ma lasciato sulla pianta fi no a completa maturazione. Solo a questo punto il pomodoro, la zucca, il<br />
cetriolo venivano prelevati, tagliati a metà e lasciati asciugare al sole fi nchè era possibile ricavarne i semi che venivano debitamente<br />
puliti dai residui di polpa: al striçave il pomodoro, al lavave lis sepis tal tamês, lis suiave ben ben ben e lis meteve tai sacuts.<br />
I semi ottenuti venivano riposti entro sacchetti di tela (sacuts di peçot, tocs di linzûi vecjos), legati debitamente con uno spago dal<br />
quale pendeva regolarmente un rettangolino di legno sul quale il nonno, col lapis copiativo, scriveva, talvolta in italiano, più spesso<br />
in friulano lidric, salate, savôrs... I sacchetti appesi sui trâfs te àrie ‘sulle travi dell’aia’ erano pronti per la semina dell’anno successivo.<br />
I risultati? Al nasseve dut!<br />
Il nonno produceva anche la semente del saròs ‘sorgo’ con cui fabbricava scovis e scôi e, naturalmente, anche del sorc ‘mais’. Le<br />
qualità di quest’ultimo erano il Nostran (panole rosse, curte e mucule) e il Cincuantin che era pes bestiis, ma col quale si faceva<br />
anche il pan di sorc mescolandone la farina con quella di segale (cu la siale), una volta considerato una leccornia (une fetute a<br />
merinde...). Per la semina del mais si usavano i semi della parte centrale della pannocchia (si specolave la panole e tal mieç de<br />
panole si samenave), non si utilizzavano i semi della ponte, la parte distale, e del poc, la parte prossimale.<br />
Che cosa si acquistava? Di sementi solo qualche busta di carote. Pe cevole si cjoleve el cevolin, però al è vignût dopo, prin e jere<br />
la plantute.<br />
Si acquistavano anche lis plantutis di impastanâ ‘piantine da trapianto’: lidric d'inviâr, melanzane, pevarons, verze, verzotins, brocui<br />
di fuee... delle quali ci si riforniva li di Vît, uno storico vivaio tricesimano gestito da una famiglia di contadini (bacans) detti appunto<br />
chei di Vît.<br />
(Da un’intervista a Fabiola Bertino, Ara di Tricesimo, settembre 2009)<br />
S