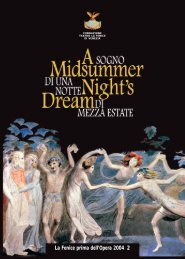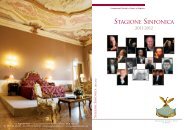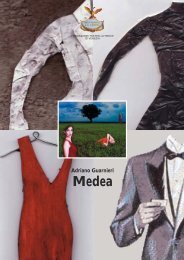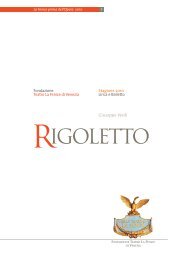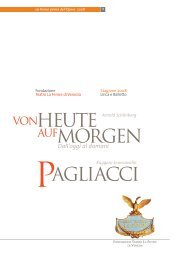Gaetano Donizetti Maria Stuarda - musica ... - Teatro La Fenice
Gaetano Donizetti Maria Stuarda - musica ... - Teatro La Fenice
Gaetano Donizetti Maria Stuarda - musica ... - Teatro La Fenice
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Maria</strong> <strong>Stuarda</strong> in breve<br />
a cura di <strong>Maria</strong> Giovanna Miggiani<br />
Dopo il successo milanese di Anna Bolena nel 1830, la fama di <strong>Gaetano</strong> <strong>Donizetti</strong> (1797-1848)<br />
era ormai consolidata in tutta Italia. Nel marzo 1834, dopo un’assenza di sedici mesi, il compositore<br />
bergamasco tornava a Napoli con tre incarichi di prestigio: la nomina a «maestro di contrappunto<br />
e composizione del Real Collegio di <strong>musica</strong>» con lo stipendio di quattrocento ducati<br />
al mese, la commissione per un gala reale in luglio e la composizione di un’opera seria per il <strong>Teatro</strong><br />
di San Carlo.<br />
Per quest’ultimo compito, <strong>Donizetti</strong> scelse un soggetto tragico, la <strong>Maria</strong> Stuart di Schiller<br />
(Weimar, 1800), particolarmente apprezzato dai romantici più avvertiti. <strong>La</strong> scelta di un soggetto<br />
schilleriano, sull’esempio del Guillaume Tell rossiniano (1829), suggerisce un interesse specifico<br />
del compositore in vista del proprio lancio internazionale. In effetti, alla fine di quello stesso<br />
1834 <strong>Donizetti</strong> si sarebbe recato a lavorare a Parigi, dove lo aveva invitato Rossini, da tempo residente<br />
nella capitale francese.<br />
In quegli anni <strong>Maria</strong> <strong>Stuarda</strong> circolava per i palcoscenici della penisola grazie alla compagnia<br />
di Gustavo Modena, nella traduzione italiana di Andrea Maffei (1829). Non potendo disporre del<br />
grande librettista Felice Romani, irritato nei suoi confronti e in procinto di cambiare attività, <strong>Donizetti</strong><br />
ricorse a un esordiente di appena diciassette anni, lo studente di legge calabrese Giuseppe<br />
Bardari, in seguito mai più attivo per le scene liriche. L’inesperienza del giovane collaboratore favorì<br />
il diretto coinvolgimento del compositore nella stesura del testo, e la «tragedia lirica» che ne<br />
derivò è dal punto di vista drammatico uno dei libretti più vivi del teatro donizettiano.<br />
Il 19 luglio 1834 l’opera era già pronta e <strong>Donizetti</strong> iniziò le prove pur non avendo ancora ricevuto<br />
l’approvazione della censura. Ai primi di settembre, nella prima prova con l’orchestra,<br />
Giuseppina Ronzi De Begnis interpretò l’invettiva di <strong>Maria</strong> (che chiama la rivale «meretrice» e<br />
«vil bastarda», in quanto figlia di Anna Bolena) contro Elisabetta, Anna Delsere, in modo così<br />
realistico da causare l’ira della collega, che le balzò addosso. Ne nacque una rissa che fece scandalo<br />
e il re, dietro sollecitazione della moglie <strong>Maria</strong> Cristina – lontana discendente di <strong>Maria</strong><br />
<strong>Stuarda</strong> – o per una generalizzata avversione nei confronti di violenze e fatti di sangue, ne proibì<br />
la rappresentazione. Il librettista Pietro Salatino, già collaboratore di <strong>Donizetti</strong>, ebbe allora il<br />
compito di scrivere un libretto completamente diverso tratto dalle Istorie fiorentine di Machiavelli,<br />
cui il compositore adattò gran parte della <strong>musica</strong> composta per <strong>Maria</strong> <strong>Stuarda</strong>: il lavoro andò<br />
così in scena a Napoli il 18 ottobre 1834 sotto il titolo di Buondelmonte.<br />
<strong>Maria</strong> Malibran, informata delle polemiche, si entusiasmò del soggetto di <strong>Maria</strong> <strong>Stuarda</strong> e insistette<br />
per interpretare personalmente l’opera alla Scala. Dopo una revisione del libretto, probabilmente<br />
ad opera del poeta scaligero Calisto Bassi che realizzò alcune modifiche volute dalla<br />
censura, il dramma, articolato in quattro parti (al contrario della partitura manoscritta, divisa in<br />
due atti), approdò a Milano con il suo vero titolo il 30 dicembre 1835. Tuttavia la Malibran volle<br />
deliberatamente ignorare i cambiamenti concordati con la censura, e lo spettacolo fu proibito


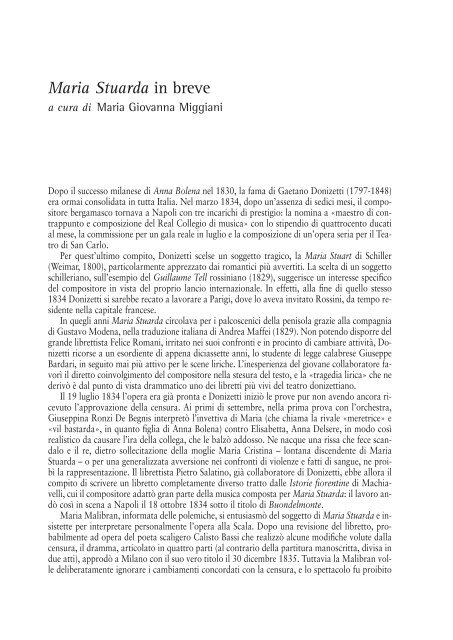

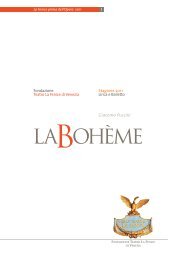
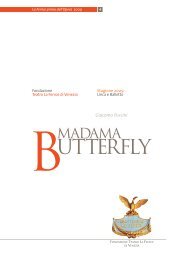

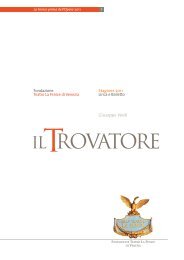
![[PDF] Vedi documento - Teatro La Fenice](https://img.yumpu.com/16094697/1/184x260/pdf-vedi-documento-teatro-la-fenice.jpg?quality=85)
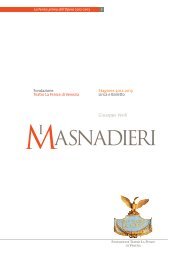
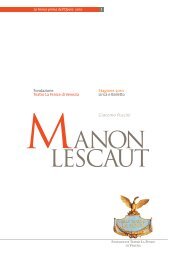
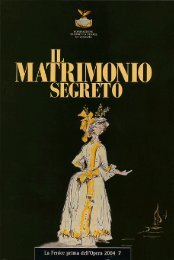
![[PDF] Otello press comunication - Teatro La Fenice](https://img.yumpu.com/16064258/1/184x260/pdf-otello-press-comunication-teatro-la-fenice.jpg?quality=85)