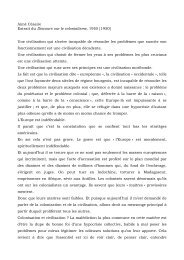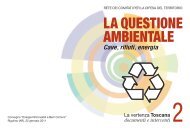CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
migliore perché connette due proprietà strutturali suggerendo anche un nesso<br />
causale tra di esse.<br />
Ciò che è chiaro comunque è che spiegare significa derivare logicamente, e<br />
che ogni spiegazione va presentata come una derivazione logica. Nel caso E sia<br />
un evento singolare effettivamente accaduto la derivazione logica può essere<br />
data da uno o più fatti noti come accaduti mediante una o più leggi di natura.<br />
Seguendo Hempel, l’evento da spiegare E (explanandum) si deriva da un<br />
explanans che consta di una classe di leggi L1 & …& Ln e di condizioni iniziali<br />
C1….Ck.<br />
Questa idea apparentemente banale, nota come teoria delle leggi di copertura o<br />
schema di HemperlOppenheim, in realtà è una fonte di problemi. Ne<br />
distingueremo due tipi: in primis bisogna porre delle restrizioni su questa<br />
definizioni iniziale. Supponiamo per esempio che E e C1 siano identiche o<br />
logicamente equivalenti oppure due descrizioni dello stesso fenomeno. In questo<br />
caso avremmo che Ci è un elemento della spiegazione di E, cioè che E spiega E.<br />
Questo può sembrare assurdo ma nella storia della scienza si è verificato più<br />
spesso di quanto non si pensi. Nella commedia di Molière “Il Borghese<br />
Gentiluomo” si ironizza suglia aristotelici che spiegavano la capacità dell’oppio<br />
di far dormire dicendo che possedeva un virtus dormitiva. Per un neopositivista il<br />
significato di questo enunciato è indistinguibile dall’explanandum (le proceduree<br />
di verifica sono identiche), per cui in questo caso, nonostante le apparenze, si<br />
spiega E mediante E. Altre condizioni restrittive hanno lo scopo di evitare altre<br />
banalizzazioni: per esempio se A spiega E, non bisogna permetter che E spieghi<br />
A, quindi bisogna garantire che questa relazione non sia simmetrica.<br />
Ma la più interessante difficoltà è stata vista da Hempel per il fatto che L1…<br />
Ln possono essere non leggi ineccepibili ma leggi probabilisticoinduttive (p.es<br />
il 99% dei fiammiferi sfregati si accende). Questo impone una correzione dello<br />
schema iniziale perché l’explanandum in questo caso non segue con la certezza<br />
del 100% ma con una certezza inferiore. Stando così le cose dobbiamo precisare<br />
il grado di certezza (probabilità) della conclusione specificandolo anche<br />
formalmente. Per Hempel –che distingue questo schema chiamandolo statisticoinduttivo<br />
la probabilità della conclusione date le premesse deve comunque<br />
essere molto alta (regola dell’alta probabilità) .<br />
Il modello SI (StatisticoInduttivo) ha dei problemi propri che si aggiungono<br />
ai problemi del modello ND (NomologicoDeduttivo). Ci limitiamo ad accennare