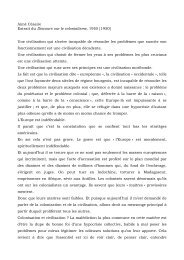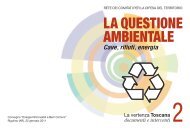CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
formulazione delle leggi, sembra che questo sia impossibile nella descrizione<br />
della cosiddetta realtà fenomenica.<br />
Quanto precede forse basta da solo a spiegare il moltiplicarsi impressionante di<br />
saggi filosofici sulla causalità a partire dal 1960 circa, quando viene pubblicato<br />
“Causation in Law” di Hart & Honorè, due filosofi del diritto consapevoli<br />
dell’importanza che hanno le considerazioni causali nell’accertamento delle<br />
responsabilità penali. Certo questo trend è in parte motivato dall’esaurirsi del<br />
positivismo logico alla fine degli anni 50. Ma sarebbe un errore pensare che<br />
questa fioritura sia legata al postpositivismo, cioè al filone di pensiero della linea<br />
HansonKuhnFeyerabend. In realtà questa corrente filosofica è ben poco<br />
interessata all’analisi concettuale e si è limitata a mettere l’accento sul ruolo che<br />
hanno le teorie scientifiche nel rispondere alla domanda “qual è la causa del<br />
fenomeno x”? Di che cosa si tratti si può vedere facilmente da un esempio.<br />
Supponiamo che si verifichi un incidente stradale conclusosi con la morte di un<br />
conducente che in stato di ubriachezza passava con il rosso. Supponiamo di<br />
chiedere a un vigile urbano, a un medico, a un sociologo qual è la causa del<br />
decesso. Avremo verosimilmente delle risposte diverse. L’uno dirà che l’evento<br />
si è prodotto perché l’autista è passato con il rosso, l’altro indicherà la causa in<br />
un’emorragia inarrestabile, il terzo nel fatto che il guidatore era un alcolista. I tre<br />
soggetti sono influenzati da paradigmi diversi e individuano cause diverse.<br />
Individuare una causa significherebbe dunque usare un certo insieme di<br />
presupposti di sfondo (una teoria, un insieme di pregiudizi) per distinguere ciò<br />
che è rilevante da ciò che non è rilevante. Tutto ciò è indubbiamente vero sul<br />
piano della psicologia della ricerca scientifica, ma elude uno dei problemi<br />
centrali della filosofia della scienza, e cioè che esistono catene causali<br />
“oggettive”, cioè che i vari soggetti possono riconoscere come tali<br />
indipendentemente dal peso che ciascuno può voler assegnare ai singoli membri<br />
della catena? Questo problema è solo uno dei molti che sono stati recentemente<br />
oggetto di dibattito nella filosofia della causalità, dove con questo termine<br />
intendo rifermi a una nuova area di ricerca su temi comuni spesso scollegati,<br />
che attualmente vengono perseguite con strumenti diversi (logici, linguistici,<br />
algebrici, statistici) da studiosi di diversa estrazione che parlano linguaggi<br />
diversi.<br />
Vediamo insieme alcuni temi importanti da esaminare con la massima