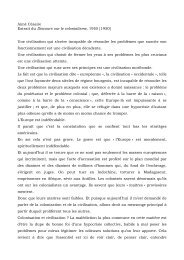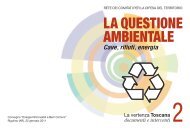CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
presi dai suoi studenti nel corso delle lezioni. Ciò che cambiava rispetto al<br />
Tractatus primariamente era la teoria del significato. Nel Tractatus una<br />
proposizione è significante se e solo se è vera o falsa, e la sua verità consiste<br />
nell’essere rispecchiamento (immagine) di un fatto atomico o molecolare. Ma il<br />
secondo Wittgenstein, influenzato forse dallo studio dell’etnoantropologia<br />
(sappiamo che scrisse una recensione a “Il ramo d'Oro” di Frazer) vede ora che<br />
il significato di un enunciato non è offerto dalla verificabilità di un suo rapporto<br />
proiettivo con il mondo dall’insieme di regole che ne governano l’uso. Allo<br />
stesso modo in cui il significato della torre negli scacchi, poniamo, è dato non<br />
dall’avere la forma di una torre ma dall’insieme di regole che ne governano l’uso<br />
nel gioco degli scacchi, così il senso di una parola come, poniamo, “bellezza”<br />
non è dato dal riferirsi a un oggetto chiamato “bellezza” ma dalle regole che ne<br />
governano l’uso in una lingua come l’italiano (teoria dei giochi linguistici). Il<br />
linguaggio comune, non il linguaggio perfetto della logica, diventa dunque<br />
l’oggetto primario di indagine insieme allo slogan “non chiedete il significato,<br />
chiedete l’uso”. I seguaci di Wittgenstein in Inghilterra (Strawson, Anscombe,<br />
Ryle, Toulmin), che sono tuttora numerosi, trasformarono questa filosofia in una<br />
“filosofia del linguaggio ordinario”, che dal loro punto di vista si riduceva di<br />
fatto all’analisi della lingua inglese.<br />
Wittgenstein aveva familiarità con la cosiddetta “teoria della Gestalt”,<br />
secondo cui non esiste un vedere che non sia percezione strutturata di una forma.<br />
Esempi famosi sono il cubo di Necker e l’immagine del duckrabbit , una figura<br />
ambigua che può essere “letta” come un papero o un coniglio e che Wittgenstein<br />
riproduce nelle Ricerche Filosofiche. La tesi di Wittgenstein è che la<br />
disponibilità di un certo linguaggio condiziona la percezione stessa. Chi non ha<br />
mai visto la neve, come certi popoli dell’Africa,non possiede nel suo linguaggio<br />
la parola “neve” e non può riconoscere qualcosa come neve. Nello stesso tempo,<br />
come osservava il linguista Benjiamin Lee Whorf, gli esquimesi che hanno venti<br />
termini diversi per indicare tipi di neve, “vedono” diversi tipi di neve che noi<br />
non siamo in grado di riconoscere come tali.<br />
Il secondo Wittgenstein dunque rovescia il rapporto tra linguaggio e<br />
osservazione. Applicata all’epistemologia questa concezione aveva alcune<br />
immediate implicazioni, evidenziate da N.R.Hanson in Patterns of Discovery