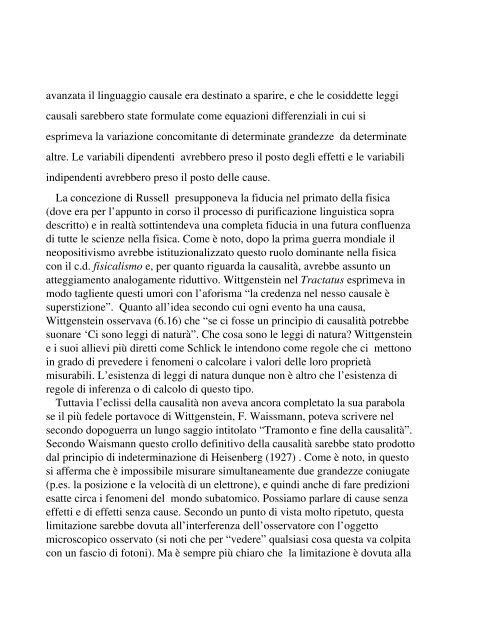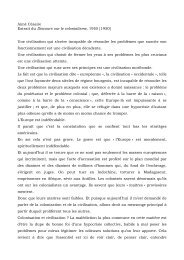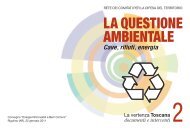CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
avanzata il linguaggio causale era destinato a sparire, e che le cosiddette leggi<br />
causali sarebbero state formulate come equazioni differenziali in cui si<br />
esprimeva la variazione concomitante di determinate grandezze da determinate<br />
altre. Le variabili dipendenti avrebbero preso il posto degli effetti e le variabili<br />
indipendenti avrebbero preso il posto delle cause.<br />
La concezione di Russell presupponeva la fiducia nel primato della fisica<br />
(dove era per l’appunto in corso il processo di purificazione linguistica sopra<br />
descritto) e in realtà sottintendeva una completa fiducia in una futura confluenza<br />
di tutte le scienze nella fisica. Come è noto, dopo la prima guerra mondiale il<br />
neopositivismo avrebbe istituzionalizzato questo ruolo dominante nella fisica<br />
con il c.d. fisicalismo e, per quanto riguarda la causalità, avrebbe assunto un<br />
atteggiamento analogamente riduttivo. Wittgenstein nel Tractatus esprimeva in<br />
modo tagliente questi umori con l’aforisma “la credenza nel nesso causale è<br />
superstizione”. Quanto all’idea secondo cui ogni evento ha una causa,<br />
Wittgenstein osservava (6.16) che “se ci fosse un principio di causalità potrebbe<br />
suonare ‘Ci sono leggi di naturà”. Che cosa sono le leggi di natura? Wittgenstein<br />
e i suoi allievi più diretti come Schlick le intendono come regole che ci mettono<br />
in grado di prevedere i fenomeni o calcolare i valori delle loro proprietà<br />
misurabili. L’esistenza di leggi di natura dunque non è altro che l’esistenza di<br />
regole di inferenza o di calcolo di questo tipo.<br />
Tuttavia l’eclissi della causalità non aveva ancora completato la sua parabola<br />
se il più fedele portavoce di Wittgenstein, F. Waissmann, poteva scrivere nel<br />
secondo dopoguerra un lungo saggio intitolato “Tramonto e fine della causalità”.<br />
Secondo Waismann questo crollo definitivo della causalità sarebbe stato prodotto<br />
dal principio di indeterminazione di Heisenberg (1927) . Come è noto, in questo<br />
si afferma che è impossibile misurare simultaneamente due grandezze coniugate<br />
(p.es. la posizione e la velocità di un elettrone), e quindi anche di fare predizioni<br />
esatte circa i fenomeni del mondo subatomico. Possiamo parlare di cause senza<br />
effetti e di effetti senza cause. Secondo un punto di vista molto ripetuto, questa<br />
limitazione sarebbe dovuta all’interferenza dell’osservatore con l’oggetto<br />
microscopico osservato (si noti che per “vedere” qualsiasi cosa questa va colpita<br />
con un fascio di fotoni). Ma è sempre più chiaro che la limitazione è dovuta alla