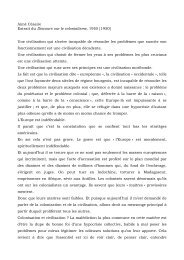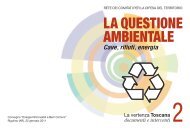CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
CLAUDIO PIZZI LEZIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA a. a. 20102011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sarebbe stata egualmente tempesta, come avveniva prima dell’invenzione dei<br />
barometri.<br />
Qualcuno può sostenere che questo “esperimento mentale” è l’unico vero test<br />
per la genuinità delle correlazioni causali. Si ipotizza in altre parole che un certo<br />
evento C non si sia verificato e ci si chiede che cosa ne sarebbe dell’evento<br />
successivo E.<br />
Un asserto come “se non ci fosse stato c non si sarebbe verificato e” è un<br />
periodo ipotetico della irrealtà, che i logici oggi chiamano condizionale<br />
controfattuale. Max Weber ha teorizzato l’essenzialità di questo metodo in un<br />
ben noto saggio sulla metodologia delle scienze storicosociali. Non solo<br />
riusciamo così ad eliminare le cause spurie, ma anche a dare un peso alle cause<br />
genuine. Che cosa ha causato la I guerra Mondiale? Se non fossero stati sparati i<br />
colpi di pistola di Sarajevo la guerra si sarebbe comunque verificata anche se in<br />
modi leggermente diversi, quindi quell’evento (casus belli) si può qualificare<br />
come causa accidentale.<br />
Purtroppo la distinzione tra condizione sufficiente e condizione necessaria non<br />
è mai stata chiara nella letteratura filosofica fino all’ultimo secolo, e la<br />
confusione è presente in molti autori. Un esempio clamoroso è fornito dallo<br />
stesso Hume, che in un passo celebre definisce la causa così: un oggetto seguito<br />
da un altro, dove tutti gli oggetti simili al primo sono seguiti da oggetti simili al<br />
secondo. O, in altri termini dove, se il primo non ci fosse stato, il secondo non<br />
sarebbe mai esistito (Enquiry). Questo passo ha fatto versare fiumi di inchiostro<br />
perché appare che nella prima parte del passo Hume definisce la causa come<br />
condizione ceters paribus sufficiente, mentre nella seconda usa un condizionale<br />
controfattuale.<br />
Questa ambivalenza è stata incorporta da J.L.Mackie in una delle più<br />
complesse e interessanti teorie della causa oggi disponibili. Secondo MacKie le