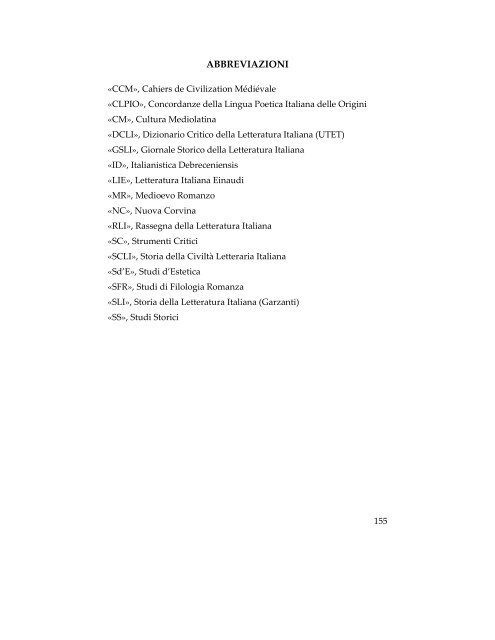- Page 1 and 2:
ANGELO PAGANO LA SCUOLA POETICA SIC
- Page 4 and 5:
4 I N D I C E Prefazione 5 Introduz
- Page 7 and 8:
INTRODUZIONE Il presente lavoro int
- Page 9 and 10:
ca letteraria si è ancora una volt
- Page 11 and 12:
la realtà e della realizzazione di
- Page 13 and 14:
esse, conformemente alla funzione d
- Page 15 and 16:
hanno piuttosto la funzione di riap
- Page 17 and 18:
dall’ eco infinita. In altri term
- Page 19 and 20:
CAPITOLO I LA MAGNA CURIA DI FEDERI
- Page 21 and 22:
lare meglio i vasti territori del s
- Page 23 and 24:
Tuttavia una ragione per la quale F
- Page 25 and 26:
da definirsi vir inquisitor et sapi
- Page 27 and 28:
Purtuttavia le cronache narrano che
- Page 29 and 30:
specie di età sveva che si coglie
- Page 31 and 32:
CAPITOLO II I RAPPORTI CON LA LIRIC
- Page 33 and 34:
gono dalle fila della piccola nobil
- Page 35 and 36:
Questi rapporti platonici, una spec
- Page 37 and 38:
nessione la tecnica adottata e i pr
- Page 39 and 40:
CAPITOLO III LE ALTRE FONTI Andrea
- Page 41 and 42:
Riprendendo poi un passo di San Ger
- Page 43 and 44:
Per Giacomo da Lentini amore è con
- Page 45 and 46:
Tanto per cominciare c’è un ampi
- Page 47 and 48:
A questo punto bisogna ricordare, c
- Page 49 and 50:
Il motivo principale per il quale G
- Page 51 and 52:
Tre cose sono in una concordanza, c
- Page 53 and 54:
Tra i versi dell’Ars, degli Amore
- Page 55:
È ovviamente il creatore del sonet
- Page 58 and 59:
iti, ma che trapiantato in ambiente
- Page 60 and 61:
zione cominciano la loro attività
- Page 62 and 63:
me i funzionari della Magna Curia,
- Page 64 and 65:
da Lentini e agli altri rimatori fe
- Page 66 and 67:
66 Due cavalier valenti d’un para
- Page 68 and 69:
ni di Aimeric nei poeti federiciani
- Page 70 and 71:
stiche auliche e porta con sé modi
- Page 72 and 73:
in cui la donna sa come ribattere a
- Page 74 and 75:
”permeabilità” dei singoli aut
- Page 76 and 77:
Erla o il canonico Thomasin von Zir
- Page 78 and 79:
appartiene veramente al re Giovanni
- Page 80 and 81:
lo negli anni di prigionia può ess
- Page 82 and 83:
del tempo di Federico II 42 ; il V
- Page 84 and 85:
Immaginare forma e organizzazione d
- Page 87 and 88:
CAPITOLO VI LA LINGUA L’uso della
- Page 89 and 90:
diocribus, ex ore quorum iudicium e
- Page 91 and 92:
È proprio dalla forma linguistica
- Page 93 and 94:
murir s’illa ’nd’à gioia, ch
- Page 95 and 96:
CAPITOLO VII LA METRICA Le struttur
- Page 97 and 98:
siciliani più raffinati alternavan
- Page 99 and 100:
che, come ad esempio quella religio
- Page 101 and 102:
sibile senza grandi problemi che l
- Page 103 and 104: Le strutture metriche adoperate dai
- Page 105 and 106: Le origini del sonetto sono ancora
- Page 107 and 108: culturale voluto da Federico e dive
- Page 109 and 110: CAPITOLO VIII IL LINGUAGGIO POETICO
- Page 111 and 112: Dai dati assolutamente sicuri che s
- Page 113 and 114: Madonna, dir vo voglio como l’amo
- Page 115 and 116: [e] per zo, [ma]donna mia, a voi no
- Page 117 and 118: (Antonelli 1992:2) che lo stesso Ch
- Page 119 and 120: E per aviso-viso-in tale viso De lo
- Page 121 and 122: L’amante possiede una tavolozza d
- Page 123 and 124: al perire, ne so’ il danneggiato,
- Page 125 and 126: in danno che poria sortire a manti,
- Page 127 and 128: a cui prega ogni amanti, li miei so
- Page 129 and 130: mento minacciata dalla follia, inte
- Page 131 and 132: Da una parte, insomma, si afferma u
- Page 133 and 134: e l’identificazione di una novit
- Page 135 and 136: E si vedano anche «Uno disio d’a
- Page 137 and 138: Molte sono le dittologie sinonimich
- Page 139 and 140: È molto importante sottoporre all
- Page 141 and 142: zioni stilnovistiche (Fabio 1968:56
- Page 143 and 144: e, ancora, ai vv. 31-2: e attento a
- Page 145 and 146: e de l’amare rendere dolzore; e d
- Page 147 and 148: essi si ritrovano quasi parafrasati
- Page 149 and 150: Ma in te, Amore, veggio lo contraro
- Page 151 and 152: CONCLUSIONI Interpretare un testo l
- Page 153: e, il sentimento dell’approssimar
- Page 157 and 158: Edizioni della Scuola siciliana: BI
- Page 159 and 160: del canone (a cura di R. Coluccia e
- Page 161 and 162: Folena, G., Cultura poetica dei pri
- Page 163 and 164: Pagano, A., Federico II e la nascit
- Page 165: Duby, G., Il modello cortese, in: G