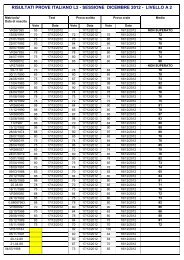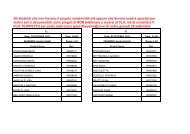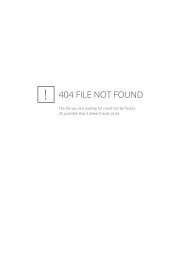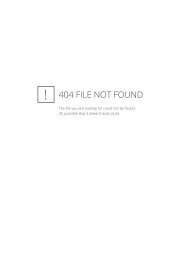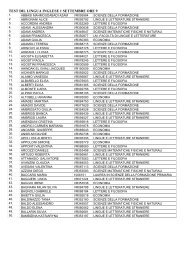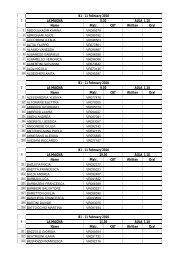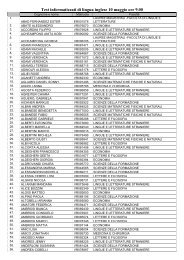Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...
Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...
Alma Poloni «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
taverne pubbliche e private, e più in generale a dedicarsi al commercio di generi<br />
alimentari all’ingrosso e al minuto, l’ambito sul quale maggiormente incidevano<br />
il dazio della grattarola - che come già detto gravava sulle compravendite<br />
di bestie vive o morte - e l’insieme di imposte indirette percepite come<br />
in qualche modo legate alla grattarola, perché sempre pertinenti alla vendita<br />
di alimenti: il dazio della beccheria, che colpiva la vendita di carne macellata,<br />
il dazio del formaggio, del pane e, soprattutto, del vino. I cittadini che, invece,<br />
preferivano non rimanere esclusi da un giro d’affari che, in un contesto<br />
di crescita demografica quale era quello della seconda metà del Quattrocento,<br />
si faceva sempre più allettante, rinunciavano implicitamente a godere di un<br />
regime daziario privilegiato e si dovevano adattare alle stesse condizioni fiscali<br />
degli altri «vicini».<br />
Gli equilibri comunitari non erano dunque regolati soltanto dalle leggi<br />
dello Stato, ma anche - o forse soprattutto - da un delicato meccanismo di<br />
patti e intese, di concessioni e riconoscimenti tra i diversi attori sociali, i cittadini,<br />
le élites locali, i «vicini». Si trattava naturalmente di un equilibrio molto<br />
precario, continuamente messo in discussione e ricalibrato. Era infatti nell’ordine<br />
delle cose che prima o poi una delle parti rompesse i patti o si spingesse<br />
oltre i limiti tracciati dagli accordi e dalle consuetudini. Tali confini del resto<br />
non erano sempre così chiari: per esempio, non era affatto agevole distinguere<br />
le operazioni commerciali destinate all’autoconsumo da quelle a scopo<br />
di lucro. È comprensibile che con una certa frequenza qualcuno pensasse di approfittare<br />
degli ampi margini di ambiguità che, forse volutamente, contraddistinguevano<br />
i rapporti tra i diversi protagonisti locali così come erano definiti<br />
da arrangiamenti in larga parte informali e da convenzioni non sempre<br />
esplicitate fino in fondo.<br />
Non stupisce dunque che una parte molto rilevante - forse la più rilevante<br />
- della documentazione relativa alla vita delle comunità dell’età tardo medievale<br />
e moderna, e non solo dello Stato veneziano, riguardi proprio controversie,<br />
contestazioni, dispute giudiziarie e conflitti di ogni genere, che dovevano<br />
costituire esperienze molto familiari per qualsiasi abitante anche del più<br />
isolato Comune di montagna. È nell’ambito di queste controversie - e quelle<br />
tra cittadini e «vicini», che ci interessano in questa sede, erano tra le più frequenti<br />
- che il quadro giuridico disegnato dalle diverse fonti del diritto rientrava<br />
in gioco. In tutte le fasi dello scontro, infatti, le parti in conflitto si richiamavano<br />
di continuo a questo orizzonte legale, peraltro anch’esso tutt’altro<br />
che nitido, cercando di utilizzarlo contro l’avversario.<br />
51