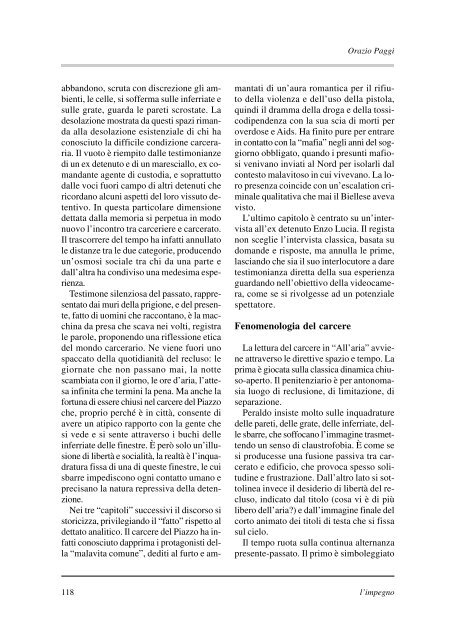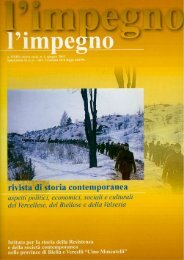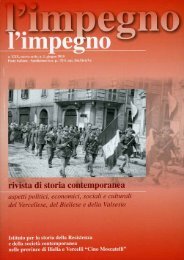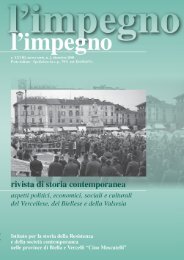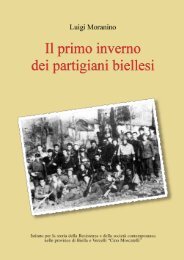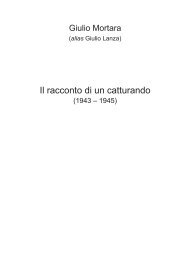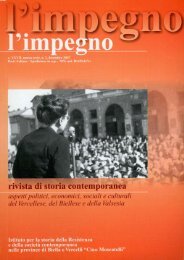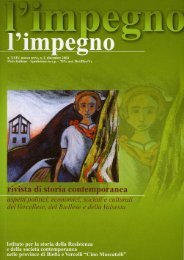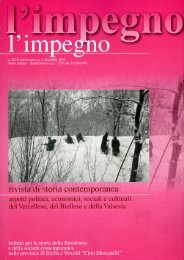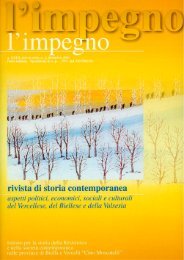Giorgio Marincola e la missione “Bamon” - Istituto per la storia della ...
Giorgio Marincola e la missione “Bamon” - Istituto per la storia della ...
Giorgio Marincola e la missione “Bamon” - Istituto per la storia della ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
abbandono, scruta con discrezione gli ambienti,<br />
le celle, si sofferma sulle inferriate e<br />
sulle grate, guarda le pareti scrostate. La<br />
deso<strong>la</strong>zione mostrata da questi spazi rimanda<br />
al<strong>la</strong> deso<strong>la</strong>zione esistenziale di chi ha<br />
conosciuto <strong>la</strong> difficile condizione carceraria.<br />
Il vuoto è riempito dalle testimonianze<br />
di un ex detenuto e di un maresciallo, ex comandante<br />
agente di custodia, e soprattutto<br />
dalle voci fuori campo di altri detenuti che<br />
ricordano alcuni aspetti del loro vissuto detentivo.<br />
In questa partico<strong>la</strong>re dimensione<br />
dettata dal<strong>la</strong> memoria si <strong>per</strong>petua in modo<br />
nuovo l’incontro tra carceriere e carcerato.<br />
Il trascorrere del tempo ha infatti annul<strong>la</strong>to<br />
le distanze tra le due categorie, producendo<br />
un’osmosi sociale tra chi da una parte e<br />
dall’altra ha condiviso una medesima es<strong>per</strong>ienza.<br />
Testimone silenziosa del passato, rappresentato<br />
dai muri del<strong>la</strong> prigione, e del presente,<br />
fatto di uomini che raccontano, è <strong>la</strong> macchina<br />
da presa che scava nei volti, registra<br />
le parole, proponendo una riflessione etica<br />
del mondo carcerario. Ne viene fuori uno<br />
spaccato del<strong>la</strong> quotidianità del recluso: le<br />
giornate che non passano mai, <strong>la</strong> notte<br />
scambiata con il giorno, le ore d’aria, l’attesa<br />
infinita che termini <strong>la</strong> pena. Ma anche <strong>la</strong><br />
fortuna di essere chiusi nel carcere del Piazzo<br />
che, proprio <strong>per</strong>ché è in città, consente di<br />
avere un atipico rapporto con <strong>la</strong> gente che<br />
si vede e si sente attraverso i buchi delle<br />
inferriate delle finestre. È <strong>per</strong>ò solo un’illusione<br />
di libertà e socialità, <strong>la</strong> realtà è l’inquadratura<br />
fissa di una di queste finestre, le cui<br />
sbarre impediscono ogni contatto umano e<br />
precisano <strong>la</strong> natura repressiva del<strong>la</strong> detenzione.<br />
Nei tre “capitoli” successivi il discorso si<br />
storicizza, privilegiando il “fatto” rispetto al<br />
dettato analitico. Il carcere del Piazzo ha infatti<br />
conosciuto dapprima i protagonisti del<strong>la</strong><br />
“ma<strong>la</strong>vita comune”, dediti al furto e am-<br />
Orazio Paggi<br />
mantati di un’aura romantica <strong>per</strong> il rifiuto<br />
del<strong>la</strong> violenza e dell’uso del<strong>la</strong> pisto<strong>la</strong>,<br />
quindi il dramma del<strong>la</strong> droga e del<strong>la</strong> tossicodipendenza<br />
con <strong>la</strong> sua scia di morti <strong>per</strong><br />
overdose e Aids. Ha finito pure <strong>per</strong> entrare<br />
in contatto con <strong>la</strong> “mafia” negli anni del soggiorno<br />
obbligato, quando i presunti mafiosi<br />
venivano inviati al Nord <strong>per</strong> iso<strong>la</strong>rli dal<br />
contesto ma<strong>la</strong>vitoso in cui vivevano. La loro<br />
presenza coincide con un’esca<strong>la</strong>tion criminale<br />
qualitativa che mai il Biellese aveva<br />
visto.<br />
L’ultimo capitolo è centrato su un’intervista<br />
all’ex detenuto Enzo Lucia. Il regista<br />
non sceglie l’intervista c<strong>la</strong>ssica, basata su<br />
domande e risposte, ma annul<strong>la</strong> le prime,<br />
<strong>la</strong>sciando che sia il suo interlocutore a dare<br />
testimonianza diretta del<strong>la</strong> sua es<strong>per</strong>ienza<br />
guardando nell’obiettivo del<strong>la</strong> videocamera,<br />
come se si rivolgesse ad un potenziale<br />
spettatore.<br />
Fenomenologia del carcere<br />
La lettura del carcere in “All’aria” avviene<br />
attraverso le direttive spazio e tempo. La<br />
prima è giocata sul<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssica dinamica chiuso-a<strong>per</strong>to.<br />
Il penitenziario è <strong>per</strong> antonomasia<br />
luogo di reclusione, di limitazione, di<br />
separazione.<br />
Peraldo insiste molto sulle inquadrature<br />
delle pareti, delle grate, delle inferriate, delle<br />
sbarre, che soffocano l’immagine trasmettendo<br />
un senso di c<strong>la</strong>ustrofobia. È come se<br />
si producesse una fusione passiva tra carcerato<br />
e edificio, che provoca spesso solitudine<br />
e frustrazione. Dall’altro <strong>la</strong>to si sottolinea<br />
invece il desiderio di libertà del recluso,<br />
indicato dal titolo (cosa vi è di più<br />
libero dell’aria?) e dall’immagine finale del<br />
corto animato dei titoli di testa che si fissa<br />
sul cielo.<br />
Il tempo ruota sul<strong>la</strong> continua alternanza<br />
presente-passato. Il primo è simboleggiato<br />
118 l’impegno