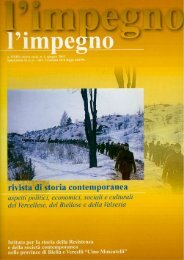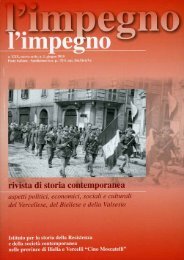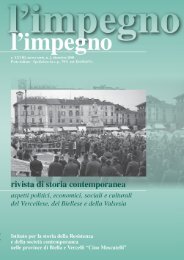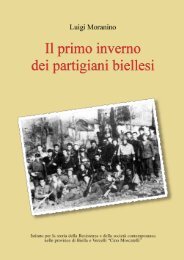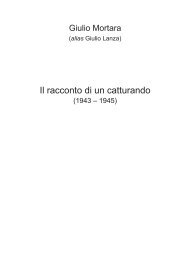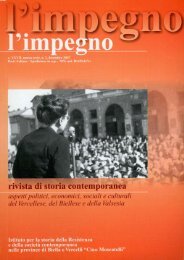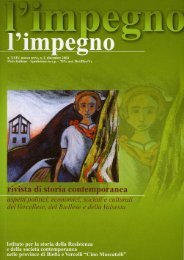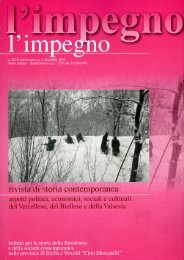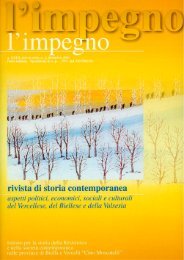Giorgio Marincola e la missione “Bamon” - Istituto per la storia della ...
Giorgio Marincola e la missione “Bamon” - Istituto per la storia della ...
Giorgio Marincola e la missione “Bamon” - Istituto per la storia della ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Storie parallele<br />
sempre che nel regime di libertà da esso inaugurato<br />
si devono bensì reprimere i disordini<br />
che fossero <strong>per</strong> nascere a minacciare l’ordine<br />
sociale, ma nul<strong>la</strong> fare <strong>per</strong> prevenirli. Ampia<br />
libertà a tutti di agire, di discutere e di filosofare,<br />
diritto allo Stato so<strong>la</strong>mente di intervenire,<br />
quando l’ordine viene vio<strong>la</strong>to» 5 .<br />
Partico<strong>la</strong>rmente, era avversa al socialismo,<br />
<strong>per</strong>ché fondato su una visione materialistica<br />
del<strong>la</strong> vita: «Un cristiano non può<br />
essere un socialista, <strong>per</strong>ché il socialismo è<br />
un sistema indubbiamente irreligioso <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
fonte da cui deriva, <strong>per</strong> gli intenti a cui mira,<br />
<strong>per</strong> <strong>la</strong> dottrina che professa» 6 . Riconosceva<br />
<strong>la</strong> proprietà privata, che doveva conciliarsi<br />
con l’uso sociale del<strong>la</strong> ricchezza, e criticava<br />
nei liberali l’individualismo egoistico e<br />
l’arricchimento <strong>per</strong>sonale. A Vercelli, nel frattempo,<br />
era nata <strong>la</strong> Democrazia cristiana di<br />
don Romolo Murri, che stava e<strong>la</strong>borando<br />
una dottrina sociale volta a conciliare democrazia<br />
e religione, dottrina e socialismo 7 .<br />
A Vercelli, d’altro canto, <strong>per</strong> rispondere<br />
alle esigenze di crescita culturale delle masse<br />
popo<strong>la</strong>ri, dopo le società di mutuo soccorso<br />
e le coo<strong>per</strong>ative di fine Ottocento, era<br />
nata “La Risaia”, il 1 dicembre del 1900. Il<br />
<strong>per</strong>iodico divenne ben presto il mezzo di tu-<br />
te<strong>la</strong> dei braccianti agricoli, <strong>la</strong> loro voce, promuovendo<br />
uguaglianza e giustizia sociale.<br />
Dal 24 marzo del 1901 agiva <strong>la</strong> Camera del<br />
<strong>la</strong>voro <strong>per</strong> contrastare lo sfruttamento senza<br />
limiti e <strong>per</strong> organizzare le forme spontanee<br />
di protesta di o<strong>per</strong>ai e contadini; nell’agosto<br />
si erano costituiti <strong>la</strong> Federazione regionale<br />
agrico<strong>la</strong> piemontese (Frap) e le leghe<br />
di resistenza nei comuni risicoli. Nel<strong>la</strong><br />
testata de “La Risaia” si stagliavano le figure<br />
di un agrario e di un prete che sorvegliavano<br />
i mondariso ricurvi sotto il sole, ad<br />
indicare una doppia pesante oppressione.<br />
Strumenti di propaganda erano le conferenze<br />
che si tenevano nei vari centri al fine di<br />
educare ed influenzare le forze del <strong>la</strong>voro.<br />
«Già a scuo<strong>la</strong> dovetti scoprire che il mondo<br />
era diviso in ricchi e poveri. Il contrasto,<br />
allora, nei paesi del Vercellese era molto più<br />
marcato di oggi. Si arrivava a scuo<strong>la</strong>, noi figli<br />
di braccianti, con abiti che erano tutti una<br />
toppa. Ai piedi calzavamo zoccoli interamente<br />
di legno, muniti di grossi chiodi e di<br />
intrecciature di filo di ferro <strong>per</strong> prolungarne<br />
<strong>la</strong> durata. Chi abitava nelle grandi tenute<br />
arrivava a scuo<strong>la</strong> con il fagottino del mangiare<br />
sotto il braccio. I figli degli agrari arrivavano<br />
invece in barroccio e il bidello, e an-<br />
5 MARIO CAPELLINO, Movimento cattolico e Ppi nel Vercellese, Vercelli, Tip. Besso, 1981,<br />
p. 52. Citazione tratta da “Vessillo di Sant’Eusebio”, 5 novembre 1904. Dallo stesso libro si<br />
traggono importanti informazioni su Crescentino. L’asilo infantile, dal 1845, e l’orfanotrofio<br />
femminile, dal 1847, erano retti dai cattolici; in passato, <strong>la</strong> fondazione dell’Ospedale (1578)<br />
e dell’Associazione delle Dame di carità (1662) avevano radicato una profonda tradizione<br />
di carità cristiana. A San Silvestro era sorto l’asilo, nel 1881, e il Comitato parrocchiale nel<br />
1882, al fine di partecipare al dibattito culturale e diffondere i principi di fede, in idem, p. 24.<br />
6 Idem, p. 54.<br />
7 «La <strong>la</strong>icità dello Stato non è un atteggiamento che lo Stato possa prendere, di quando<br />
in quando, di fronte a questioni speciali, ma è <strong>la</strong> difesa dello sviluppo di principi essenziali<br />
e fondamentali, che oggi determinano lo stato religioso delle coscienze. Si è <strong>la</strong>ici <strong>per</strong>ché si<br />
ammette <strong>la</strong> incompetenza dello Stato in materia religiosa, <strong>per</strong>ché si pensa che tutti abbiano<br />
dovere e diritto di costituirsi da se stessi <strong>la</strong> propria fede, le proprie credenze, senza intervento<br />
estraneo. Si è <strong>la</strong>ici <strong>per</strong>ché si distingue il fatto religioso dal fatto politico». Citazione tratta<br />
da un discorso di Murri del 1913, in AA. VV., Il Par<strong>la</strong>mento Italiano. Da Giolitti a Sa<strong>la</strong>ndra,<br />
volume VIII, Mi<strong>la</strong>no, Nuova Cei, 1990, p. 349.<br />
a. XXIX, n. s., n. 1, giugno 2009 77