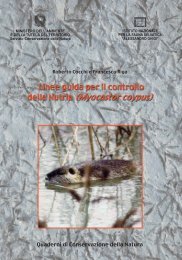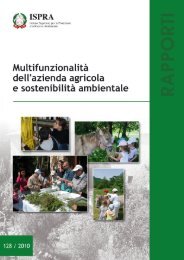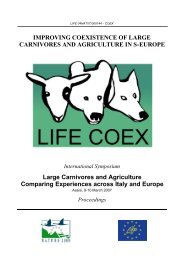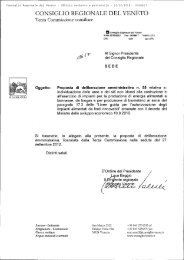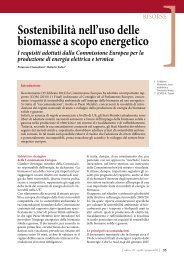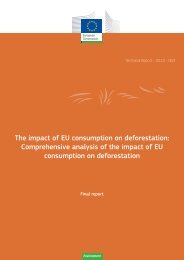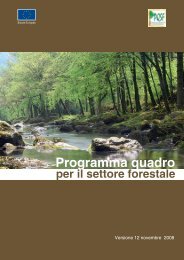Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti
Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti
Energia eolica e sviluppo locale - Ambiente e Territorio - Coldiretti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7. Impatto ambientale e paesaggistico<br />
gettista misure fondamentali per evitare le opposizioni locali e alcuni problemi ambientali. Le misure<br />
che derivano dall’interazione col pubblico possono essere probabilmente più innovative, percorribili e<br />
accettabili di quelle proponibili solo dai progettisti in base a considerazioni meramente tecniche. Le<br />
modifiche ai progetti, effettuate nelle fasi iniziali della pianificazione e della progettazione, sono più<br />
facili e economicamente meno rilevanti di quelle effettuate in una fase avanzata della progettazione<br />
o addirittura in corso d’opera. I Progetti, i Piani e i Programmi che non devono essere modificati sono<br />
infatti molto più economici, efficaci e tempestivi. Una partecipazione fin dalle prime fasi è efficace e<br />
previene il crescendo di frustrazioni e contrapposizioni che si manifesta quando le decisioni sono prese<br />
ignorando le istanze locali, evitando quindi la successiva partecipazione forzata che si ha quando le<br />
posizioni sono ormai radicalizzate. La realizzazione di un progetto procede di solito con costi più contenuti<br />
e senza particolari asprezze se i residenti locali sono d’accordo con la proposta. Le proteste sono<br />
minori, gli sforzi più costruttivi e alcuni impatti possono essere evitati o sensibilmente ridotti. Ricerche<br />
anche recenti hanno dimostrato come il giudizio del pubblico, e le pressioni che eventualmente possono<br />
essere esercitate, siano considerate tra i fattori più importanti nella preparazione degli studi di impatto<br />
ambientale, determinandone la qualità. L’esperienza ormai acquisita dimostra, quindi, che i benefici<br />
complessivi superano di gran lunga i costi della partecipazione, nonostante le spese e l’impegno che un<br />
processo partecipativo completo, integrato in tutte le fasi della pianificazione e progettazione, potrà<br />
avere” (Ammassari e Palleschi, 2007:47).<br />
Indubbiamente, il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte di governo resta un’esperienza<br />
minoritaria, punteggiata da un crescente numero di “buone pratiche”, riconosciute e incentivate<br />
dall’Unione Europea oltre che dalle politiche urbane e di <strong>sviluppo</strong> <strong>locale</strong> degli stati nazionali, ma non<br />
si configura ancora come una prassi consolidata e indiscussa. Si tratta, comunque, di un campo di<br />
sperimentazione che riguarda in modo più specifico i governi locali, contribuendo così a distinguerli<br />
dalle amministrazioni di rango nazionale e segnando la più netta rottura rispetto alle pratiche delle<br />
amministrazioni burocratiche del ‘900.<br />
All’interno di un approccio partecipativo, si possono trovare metodi e tecniche diversi per raggiungere<br />
gli obiettivi proposti. I metodi rappresentano diverse e alternative interpretazioni operazionali<br />
degli approcci, ed individuano puntualmente come preparare e condurre un processo partecipativo<br />
nel suo complesso. Le tecniche sono strumenti con fini conoscitivi, analitici, rappresentativi, comunicativi<br />
e così via, mirati a risolvere singoli passaggi operativi all’interno dell’approccio metodologico<br />
scelto. Metodi diversi usano spesso tecniche simili, ad esempio per raccogliere informazioni, preferenze<br />
o giungere a decisioni condivise. Molte delle tecniche - quali quelle sulla gestione di dinamiche<br />
di gruppo - vengono da campi anche molto lontani dalla pianificazione e progettazione di interventi<br />
di <strong>sviluppo</strong> <strong>locale</strong>, come la psicologia, applicata a contesti di promozione del cambiamento nei contesti<br />
più diversi, compresi quelli del settore privato.<br />
Gli approcci possono essere distinti sulla base dei gradini della scala di Arnstein (1969) della partecipazione<br />
(vedi tabella): egli ha messo in luce non solo che esistono vari livelli di partecipazione,<br />
ma anche che “poca partecipazione” può significare “falsa partecipazione” (tokenism, cioè “dare un<br />
contentino”).<br />
Potere ai cittadini<br />
Partecipazione irrisoria<br />
Non partecipazione<br />
Controllo ai cittadini – autoproduzione/autogestione<br />
Potere delegato<br />
Partenariato – collaborazione/coinvolgimento<br />
Consultazione<br />
Informazione/comunicazione<br />
Smorzamento<br />
Trattamento terapeutico<br />
Manipolazione<br />
83