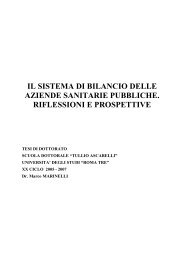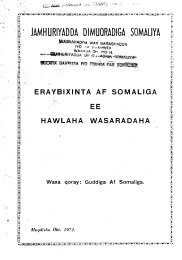Introduzione, testo critico, traduzione e note del De orthographia di ...
Introduzione, testo critico, traduzione e note del De orthographia di ...
Introduzione, testo critico, traduzione e note del De orthographia di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[IV.6.2] E coloro che escludono la ‘k’, sostengono si tratti più <strong>di</strong> sigla che <strong>di</strong> una<br />
lettera, dal momento che con essa in<strong>di</strong>chiamo ‘kalumnia’ ‘kaput’ ‘kalendae’: con la stessa<br />
si abbrevia il nome ‘Kaeso’. Sostengono, dunque, che non sia opportuno annoverarla tra le<br />
lettere più <strong>di</strong> quella sigla con cui si in<strong>di</strong>cano le parole ‘centuria’ e ‘Gaia’. Questo genere <strong>di</strong><br />
sigla lo ve<strong>di</strong>amo nei monumenti epigrafici quando è in<strong>di</strong>cato qualche liberto <strong>di</strong> donna: gli<br />
antichi infatti vollero che tutte le donne in generale a partire da una categoria specifica<br />
prendessero il nome <strong>di</strong> ‘Gaia’. Invece coloro che <strong>di</strong>fendono il fatto che sia una lettera la<br />
giu<strong>di</strong>cano necessaria per quei nomi che iniziano con la lettera ‘k’ quando questa risuona<br />
insieme con la ‘a’. Da qui anche alcuni ‘fe<strong>del</strong>issimi’ sottoscrivono ‘karissime’ con ‘k’ e<br />
‘a’. Che se per questo si mostrasse necessaria dovremmo temere <strong>di</strong> aver bisogno anche <strong>di</strong><br />
altre lettere con le quali scrivere ‘Cicero’ o ‘Commodus’.<br />
[IV.6.3] Si è <strong>di</strong>scusso anche <strong>del</strong>la lettera ‘q’, e molti l’hanno esclusa dal momento<br />
che non è altro se non ‘c’ e ‘u’ e che ‘quis’ ugualmente può essere scritto con ‘c’ ‘u’ ‘i’ ‘s’.<br />
Anche lo stesso segno con cui è in<strong>di</strong>cata, se solo osservi l’antico aspetto <strong>del</strong>la lettera, rivela<br />
che le lettere ‘c’ e ‘u’ sono fuse insieme: perciò molti scrissero ‘quis’ ‘quae’ ‘quid’ nella<br />
forma ‘qis’ ‘qae’ ‘qid’, dal momento che nella ‘q’ c’era la ‘c’ e la ‘u’. Ma <strong>di</strong> questo<br />
argomento <strong>di</strong>remo in seguito quando si dovrà parlare <strong>del</strong>l’ortografia. Ora bisogna passare a<br />
questioni relative alla norma <strong>del</strong>lo scrivere.<br />
[V.1] Mentre avvio la <strong>di</strong>scussione sulla norma <strong>del</strong>lo scrivere, mi viene in mente<br />
come prima cosa che alcuni giu<strong>di</strong>carono si dovesse scrivere così come parliamo e<br />
ascoltiamo, altri in certe circostanze contrariamente a come parliamo e ascoltiamo.<br />
Certamente il modo <strong>di</strong> pronunciare talvolta è tale che le lettere, pur scritte, vengono<br />
pronunciate. Così, infatti, quando <strong>di</strong>ciamo ‘illum ego’ e ‘omnium optimum’, la ‘m’ allo<br />
stesso modo chiude ‘illum’ e ‘omnium’ né tuttavia appare pronuncia. Al contrario<br />
quando <strong>di</strong>ciamo ‘hic est ille’, scriviamo un solo ‘c’ e ne ascoltiamo due, cosa che appare<br />
nella metrica. Infatti:<br />
‘hoc erat alma parens quod me per tela per ignes<br />
eripis’,<br />
se una sola ‘c’ chiudesse questa sillaba, il verso sarebbe acefalo e non potrebbe iniziare da<br />
quella sillaba lunga che è necessaria all’esametro. Dunque bisogna scrivere con due ‘c’,<br />
‘hocc erat alma parens’, oppure ammettere che alcune parole sono scritte in un modo e<br />
pronunciate in un altro. Siamo infatti privi <strong>di</strong> alcune lettere che tuttavia il suono <strong>del</strong>la<br />
pronuncia richiede, come quando <strong>di</strong>ciamo ‘uirtus’ e ‘uirum fortem consulem Scipionem’:<br />
scoprirai che attraverso la ‘i’ è giunta alle orecchie quasi una lettera esotica. E nella<br />
36