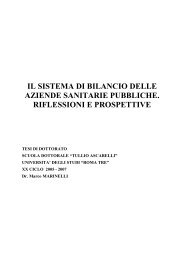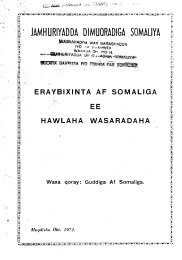Introduzione, testo critico, traduzione e note del De orthographia di ...
Introduzione, testo critico, traduzione e note del De orthographia di ...
Introduzione, testo critico, traduzione e note del De orthographia di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
aspirazione, come in ‘ualens’, ‘uitulus’, ‘primitiuus’, ‘genetiuus’, ma anche in quelle<br />
parole nelle quali questa lettera è unita alla ‘q’, come nel caso <strong>di</strong> ‘quis’. Infatti se questa ‘u’<br />
fosse in tutto e per tutto una vocale, senza dubbio questa sillaba sarebbe lunga, dal<br />
momento che mai due vocali si incontrano, se non per formare una sillaba lunga. Perciò<br />
anche in ‘equus’ la ‘u’ sarà impiegata come consonante; e in verità all’u<strong>di</strong>to sarebbe stato<br />
sufficiente che ‘equus’ fosse scritto con una sola ‘u’, la regola tuttavia ne esige due. Infatti,<br />
poiché al caso genitivo si ha ‘equi’, al dativo ‘equo’, ed essendo l’ultima vocale a<br />
determinare la <strong>di</strong>stinzione <strong>del</strong>la declinazione, mentre le consonanti non subiscono alcun<br />
cambiamento, è necessario che anche il nominativo ‘equus’ conservi intatta la consonante<br />
che si trova nella forma ‘equo’ e che abbia fin dall’inizio un’altra ‘u’, così che, aggiunta<br />
una ‘i’, formi il nominativo plurale.<br />
[V.5.2] Tuttavia osserviamo che la lettera ‘u’ è inserita irregolarmente in alcune<br />
parti <strong>del</strong> <strong>di</strong>scorso, come nel caso <strong>di</strong> ‘urguere’. E così in entrambi i casi, che si debba<br />
inserire la ‘u’ oppure no, abbiamo la testimonianza <strong>di</strong> Virgilio, il quale <strong>di</strong>ce:<br />
senza ‘u’, così:<br />
urg[u]entur poenis’<br />
‘quibusue<br />
‘ungere tela manu ferrumque armare ueneno’.<br />
Infatti che non si debba <strong>di</strong>re ‘unguo’ risulta chiaro dal fatto che non c’è nessun verbo che<br />
termini in ‘uo’, sia monosillabico che bisillabico, che non conservi la stessa ‘u’ nel<br />
preterito, come ‘uoluo uolui’, ‘eruo erui’. Ma ‘ungo’ fa ‘unxi’, come ‘pingo’ ‘pinxi’,<br />
‘fingo’ ‘finxi’. Tuttavia nel nome che da esso deriva si riconosce nuovamente una ‘u’,<br />
inserita in modo tale da non poter essere eliminata, come si legge nello stesso Virgilio:<br />
‘et pinguis unguine ceras’;<br />
e uso corrente si adopera ‘unguentum’. [V.5.3] La stessa cosa accade anche in<br />
‘hirci’, che gli antichi chiamavano ‘hirqui’. Infatti sebbene nel pronunciare ‘hirci’ non<br />
inseriamo la lettera ‘u’, tuttavia ve<strong>di</strong>amo che essa rimane nel nome che deriva da ‘hircus’,<br />
sicché chiamiamo ‘hirquitalli’ coloro che sono in età adulta. [V.5.4] Anche in ‘antiquus’<br />
ve<strong>di</strong>amo che la lettera ‘u’ trova posto mentre non lo trova in ‘posticus’; infatti ‘antiquus’ è<br />
formato da ‘post’ cosa che appare dalle in<strong>di</strong>cazioni scritte sui<br />
templi.<br />
[VI.1] Passiamo ora alle preposizioni e iniziamo da quella su cui Cicerone ha fatto<br />
annotazioni nell’Orator. Diverso è infatti l’uso per quel che riguarda ‘ab’, ‘a’, ‘abs’, ‘au’,<br />
come quando <strong>di</strong>ciamo ‘a me’, quin<strong>di</strong> ‘ab illo’, ‘abstulit’, ‘aufert’, forma quest’ultima<br />
40