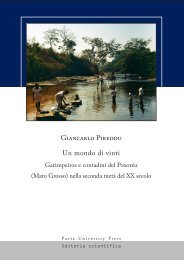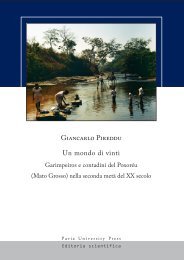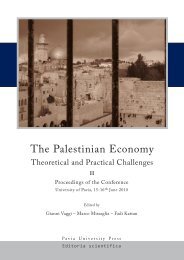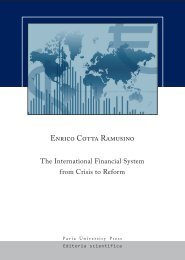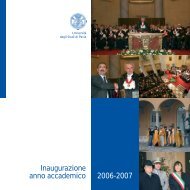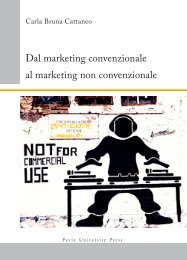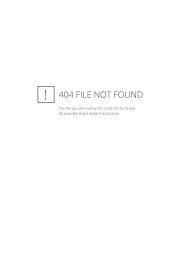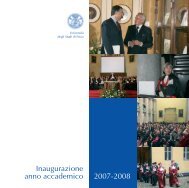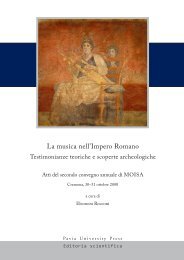Musica che affronta il silenzio - Scritti su Toru Takemitsu - Pavia ...
Musica che affronta il silenzio - Scritti su Toru Takemitsu - Pavia ...
Musica che affronta il silenzio - Scritti su Toru Takemitsu - Pavia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Musica</strong> <strong>che</strong> <strong>affronta</strong> <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio. <strong>Scritti</strong> <strong>su</strong> Tru Takemit<strong>su</strong><br />
nami<strong>che</strong> del s<strong>il</strong>enzio. A tale proposito va ricordato l’episodio – citato dallo stesso Cage<br />
(1971, p. 32) – 9 accaduto a Harvard nel 1951 quando, entrato in una camera anecoica,<br />
sperimentò in realtà due <strong>su</strong>oni, uno più alto e uno più basso: <strong>il</strong> tecnico del <strong>su</strong>ono gli<br />
spiegò <strong>che</strong> erano i <strong>su</strong>oni, rispettivamente, del sistema nervoso e della circolazione del<br />
sangue. Questa esperienza contribuisce evidentemente a sciogliere l’opposizione tra<br />
<strong>su</strong>ono e s<strong>il</strong>enzio, dimostrando <strong>che</strong> esiste tra di essi una continuità reale: infatti, quando<br />
udiamo un <strong>su</strong>ono, operano an<strong>che</strong> dei <strong>su</strong>oni normalmente non-udib<strong>il</strong>i <strong>che</strong> siamo soliti<br />
indicare sbrigativamente con la parola ‘s<strong>il</strong>enzio’. Di qui l’interesse di Cage per cogliere<br />
i <strong>su</strong>oni udib<strong>il</strong>i nel loro originarsi dal ‘s<strong>il</strong>enzio’. Proprio in base a esperienze come queste<br />
si può affermare <strong>che</strong> <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio non è niente, ma è la matrice vitale, oltre <strong>che</strong> <strong>il</strong><br />
luogo finale, di ogni possib<strong>il</strong>e <strong>su</strong>ono. 10 In tal senso <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio è paragonab<strong>il</strong>e –<br />
ut<strong>il</strong>izzando ancora una volta un’immagine cara al buddhismo zen – 11 all’oceano e alle<br />
<strong>su</strong>e onde: ogni onda ha, certo, una propria natura rispetto alla massa dell’oceano, ma da<br />
questo emerge e a questo inevitab<strong>il</strong>mente ritorna, così come note e <strong>su</strong>oni nascono dal<br />
s<strong>il</strong>enzio e in esso si d<strong>il</strong>eguano. Ciò <strong>che</strong> in questa tradizione di pensiero accomuna la<br />
dimensione acustica del s<strong>il</strong>enzio e quella visiva dello spazio è <strong>il</strong> carattere della vacuità<br />
intesa non come realtà inerte o, addirittura, come ri<strong>su</strong>ltato di un annientamento, ma<br />
come enorme serbatoio di potenze attive, siano esse determinate come cose o come<br />
eventi, come forme o come <strong>su</strong>oni, come parole o come fatti. In questa prospettiva è<br />
possib<strong>il</strong>e evidenziare <strong>il</strong> fatto <strong>che</strong>, in ampie porzioni della <strong>su</strong>a produzione musicale,<br />
Takemit<strong>su</strong> fa uso sapiente di ma: immesso nelle composizioni non tanto come semplice<br />
pausa o frammento di s<strong>il</strong>enzio tra note, quanto come spazio musicale ricco di<br />
tensione, 12 ovvero come momento dell’ascolto in cui si fa percepib<strong>il</strong>e la venuta dei<br />
<strong>su</strong>oni dal s<strong>il</strong>enzio e <strong>il</strong> loro ritorno a esso. Il senso di questa ut<strong>il</strong>izzazione di ma da parte<br />
di Takemit<strong>su</strong> è stato ben individuato ed espresso da Koozin quando, a proposito di<br />
alcuni brani pianistici del compositore giapponese, parla di «scivolamenti nell’ombra e<br />
nel s<strong>il</strong>enzio» <strong>che</strong> producono una condizione in cui «si è portati a udire <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio <strong>che</strong><br />
scaturisce al termine di questo tipo di figura come la diretta conseguenza dell’evento<br />
sonoro precedente. In questo senso l’evento sonoro ingloba <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio all’interno del<br />
brano come elemento attivo anziché passivo». 13<br />
Questa dialettica tra s<strong>il</strong>enzio e <strong>su</strong>oni, costitutiva dell’arte musicale, non ha un senso e una<br />
valenza di carattere esclusivamente tecnico, ma può as<strong>su</strong>mere un significato e un valore di<br />
carattere conoscitivo – e, addirittura, spirituale. Questo apre una riflessione <strong>su</strong>lla musica come<br />
9<br />
Edizione originale Experimental Music: Doctrine (1955), in S<strong>il</strong>ence, Wesleyan University Press,<br />
Middletown, 1961.<br />
10<br />
Cfr. an<strong>che</strong> Cage (1971, p. 70).<br />
11<br />
An<strong>che</strong> se forse non è del tutto vero <strong>che</strong> Cage, nel pensare questo, abbia solo ricalcato le orme dei sentieri<br />
buddhisti (cfr. Porzio 1995).<br />
12<br />
È da ricordare <strong>che</strong> nel linguaggio dei musicisti giapponesi <strong>il</strong> «vuoto viene indicato con espressioni attive».<br />
Cfr. Satoaki (2004, p. 118); cfr. an<strong>che</strong> Koozin (1990, p. 34) cit. in Burt (2003, p. 219) e Miyamoto (1996).<br />
13<br />
Koozin (1990, p. 34), cit. in Burt (2003, p. 219).<br />
57