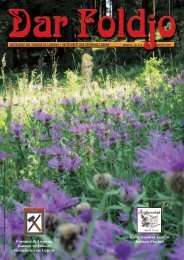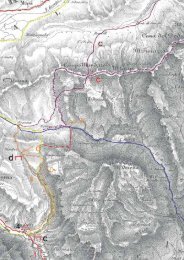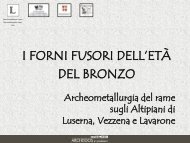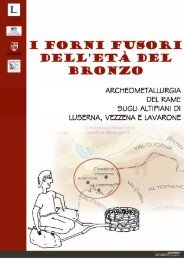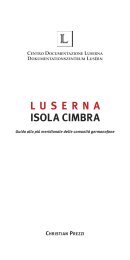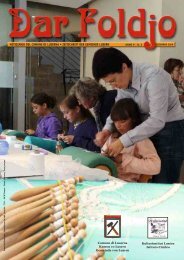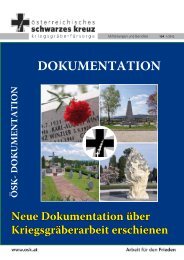Isole di cultura.pdf - Centro Documentazione Luserna
Isole di cultura.pdf - Centro Documentazione Luserna
Isole di cultura.pdf - Centro Documentazione Luserna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
su Identità, avente per tema il recupero dei materiali ferrosi, “ la gente delle zone <strong>di</strong> confine<br />
ed in particolare quella <strong>di</strong> <strong>Luserna</strong>, martoriata più <strong>di</strong> altre dal fuoco dell’artiglieria<br />
perché vicino al forte e al fronte, trovò la possibilità <strong>di</strong> riprendersi economicamente sfruttando<br />
le macerie che aveva appunto provocato la guerra.” 128<br />
Le prime attività iniziarono all’inizio del 1935 nelle zone <strong>di</strong> Passo Vezzena. Vedendo nel<br />
recupero dei rottami una possibile risorsa in tempo <strong>di</strong> grave <strong>di</strong>soccupazione, il Comune<br />
acquistò il 3 giugno 1935 l’ex fortezza austoungarica <strong>di</strong> Cima Campo (Werk Lusérn) 129 , al<br />
fine <strong>di</strong> recuperare il ferro in essa contenuto.<br />
La fortificazione fu demolita dall’impresa Mon<strong>di</strong>ni che, in seguito all’autorizzazione <strong>di</strong><br />
sparo delle mine del 16 giugno 130 , iniziò i lavori <strong>di</strong> abbattimento.<br />
L’estrazione <strong>di</strong> travi, putrelle e ton<strong>di</strong>ni dalle macerie fu affidata ad operai locali.<br />
Parallelamente, si sviluppò sempre più l’attività <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong> proiettili e delle loro<br />
schegge su tutto il territorio dell’Altopiano. Con decreto del 20 marzo del 1930, 131 lo Stato<br />
cedeva alle singole amministrazioni comunali la proprietà dei materiali e dei rottami bellici,<br />
permettendo in questo modo ai Comuni <strong>di</strong> autorizzare la popolazione locale allo<br />
sfruttamento <strong>di</strong> questa risorsa. Per quanto riguarda <strong>Luserna</strong>, tutti coloro che lo desiderarono<br />
furono autorizzati allo scavo, a con<strong>di</strong>zione, però, che il terreno fosse successivamente<br />
ripristinato. 132<br />
Per in<strong>di</strong>viduarli si cercavano gli avvallamenti lasciati dalle deflagrazioni, sondando il<br />
terreno con una verga d’acciaio che permetteva <strong>di</strong> controllare la resistenza alla penetrazione<br />
del suolo. L’eventuale morbidezza in<strong>di</strong>cava il già avvenuto recupero del residuato.<br />
Poi si iniziava lo scavo per un <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 3 metri ed una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2–2,5. Me<strong>di</strong>amente<br />
il recupero dei frammenti <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>gno <strong>di</strong> questo calibro richiedeva anche tre<br />
giorni <strong>di</strong> duro lavoro, rendendo agli operai 35–40 lire. 133 Secondo la ricostruzione fatta<br />
sulla base <strong>di</strong> interviste ad anziani, da un or<strong>di</strong>gno da 280 mm, del peso <strong>di</strong> circa 250 kg, si<br />
ricavavano, oltre alla ghisa, più <strong>di</strong> un chilogrammo <strong>di</strong> preziose vere <strong>di</strong> rame e circa 5 chilogrammi<br />
<strong>di</strong> ottone della testata (Sprengkapls).<br />
Tenendo conto dello stato <strong>di</strong> crisi che ancora serpeggiava e del fatto che la stagione lavorativa<br />
<strong>di</strong> un recuperante era più lunga <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> un muratore, queste attività si rivelarono<br />
abbastanza red<strong>di</strong>tizie, anche perché sia donne sia bambini poterono essere occupati<br />
per le attività apparentemente meno pesanti. Alle prime era affidato il compito <strong>di</strong><br />
trasportare i rottami che gradualmente venivano estratti sino in paese, dove vi erano i<br />
centri <strong>di</strong> raccolta. Ai bambini era invece affidato il compito <strong>di</strong> portare agli adulti il pasto<br />
<strong>di</strong> mezzogiorno e <strong>di</strong> raccogliere gli Shrapnels (in cimbro plai-marmar), piccole biglie <strong>di</strong><br />
piombo contenute nei proiettili anti-fanteria, che venivano fusi in piastre dello spessore<br />
128 V. Pedrazza, Gli anni del ricupero, in Identità , n°6 – <strong>di</strong>cembre 1991, pag.26.<br />
129 ACL, SP, Cat. V, VII-36, Inventario dei beni comunali 1933 aggiornato nel 1937.<br />
130 Aerchivio del Comune <strong>di</strong> <strong>Luserna</strong>, Sezione Post-unitari, Carteggi e Atti degli Affari Comunali (a seguire<br />
CL, SP, CAAC), 1935, VII-49, cat.XIV [sicurezza pubblica], prot. 1960.<br />
131 Materiali e rottami bellici, in Bollettino del Consiglio Provinciale dell’Economia <strong>di</strong> Trento, anno VII, n° 4 –<br />
aprile 1930, pag. 111.<br />
132 CL, SP, CAAC, 1936, VII-56, cat.XV [oggetti <strong>di</strong>versi], <strong>di</strong>chiarazione d’obbligo del 24 novembre.<br />
133 Per un paragone, in quegli anni un buon muratore guadagnava circa 2 lire all’ora.<br />
103