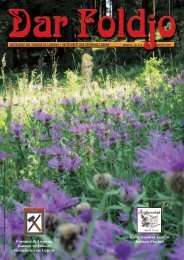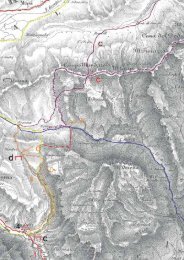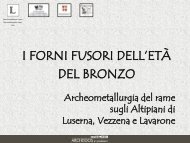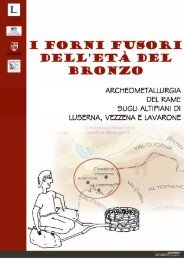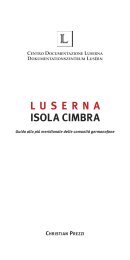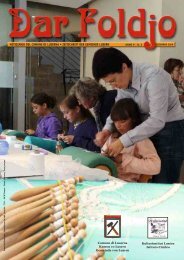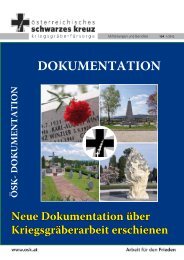Isole di cultura.pdf - Centro Documentazione Luserna
Isole di cultura.pdf - Centro Documentazione Luserna
Isole di cultura.pdf - Centro Documentazione Luserna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
lazione celtica che abitava il Friuli prima dell’invasione romana 251 . Al Della Stua fece eco<br />
Niccolò Grassi, che in un’operetta storica sulla Carnia, ricordando la presenza della reliquia<br />
a Sauris, per rendere ragione della lingua tedesca parlata in questa comunità ne faceva<br />
risalire le origini agli antichi Cimbri, costretti dalla sconfitta subita ad opera dei Romani<br />
a cercare rifugio nelle valli alpine 252 .<br />
Il passaggio del Friuli dalla Repubblica <strong>di</strong> Venezia al dominio asburgico, sancito dal Trattato<br />
<strong>di</strong> Campoformido (1797), suscitò l’interesse del mondo accademico <strong>di</strong> lingua tedesca<br />
per le isole linguistiche <strong>di</strong> origine germanica nella regione. Si occuparono così <strong>di</strong> Sauris<br />
e della sua lingua Josef Bergmann, il dottor Lotz, Carl von Czoernig, riportandone<br />
tutti le origini e la <strong>cultura</strong> ad una matrice tedesca. Il primo considerava i Saurani un residuo<br />
<strong>di</strong> un’antica popolazione tedesca in Friuli. Il dottor Lotz, con lo pseudonimo <strong>di</strong><br />
Mupperg, nel 1876 propose per l’i<strong>di</strong>oma saurano una derivazione dal Goto o dal Longobar<strong>di</strong>co.<br />
Per verificare la tesi del Mupperg, il barone von Czoernig nel 1880 si spostò appositamente<br />
da Trieste a Sauris, riconoscendo nella lingua locale una ra<strong>di</strong>ce franco-bavarese<br />
e sottolineando la somiglianza con la parlata <strong>di</strong> Gottschee, isola linguistica tedesca<br />
nella Carniola 253 .<br />
Si deve, però, ad uno stu<strong>di</strong>oso saurano la prima indagine linguistica approfon<strong>di</strong>ta, che<br />
si rivelò illuminante anche ai fini della ricostruzione storica. Nel Saggio <strong>di</strong> <strong>di</strong>alettologia<br />
sauriana (1882), il sacerdote Luigi Lucchini in<strong>di</strong>viduò nei <strong>di</strong>aletti delle valli carinziane <strong>di</strong><br />
Möll e <strong>di</strong> Lesach le forme linguistiche più vicine a quelle del <strong>di</strong>aletto saurano 254 . Nella<br />
stessa opera, come già accennato, egli riferì la tra<strong>di</strong>zione, “ancor fresca” ai suoi tempi, secondo<br />
la quale in passato i Saurani solevano recarsi ogni anno in processione a Heiligenblut<br />
(Sagriz) in Carinzia, tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cui non si poteva più ricostruire la motivazione,<br />
ma che alcuni sospettavano “potesse avere qualche relazione coll’origine <strong>di</strong> Sauris”.<br />
Anche il geografo Giovanni Marinelli, riconosciuta l’appartenenza delle parlate tedesche<br />
della Carnia al ramo alto tedesco, in<strong>di</strong>viduava, sulla base del <strong>di</strong>aletto, delle leggende e<br />
degli usi, la zona d’origine della comunità saurana in qualche vallata del Tirolo o dell’al-<br />
251 Giordano Brunettin fa giustamente notare che nell’epoca in cui Della Stua scrive (seconda metà del<br />
‘700) era già stata portata a compimento la “venetizzazione” del territorio <strong>di</strong> <strong>cultura</strong> e lingua tedesche<br />
dell’alta valle del Piave e soprattutto delle zone montane interessate dall’emigrazione <strong>di</strong> popolazioni<br />
tirolesi e carinziane. Atale scopo fu ampiamente favorito lo stanziamento <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> famiglie<br />
provenienti dai territori da lungo tempo soggetti alla Repubblica veneta nei <strong>di</strong>stretti alpini dai<br />
quali la Serenissima traeva il legname per le esigenze del proprio Arsenale.<br />
252 N. Grassi, Notizie storiche della provincia della Carnia , U<strong>di</strong>ne, Fratelli Gallici, 1782, pp. 173–174.<br />
253 Le varie ipotesi avanzate dai linguisti tedeschi sono riassunte in L. Lucchini, Saggio…, cit., pp. 7–11 e<br />
in Brunettin, Illazioni…, cit., pp. 50, 59–60, note 49–50.<br />
254 L. Lucchini, Saggio…, cit., pp. 13–14: «Certamente il Sauriano s’avvicina moltissimo a’ <strong>di</strong>aletti <strong>di</strong><br />
Möllthal e <strong>di</strong> Lesachthal. Ame bastò sfogliare alquanto il Kärntisches Wörterbuch del Lexer per vedere<br />
come tante forme e tanti mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>re che io credeva tutto propri del nostro <strong>di</strong>aletto si trovano altresì<br />
ne’ parlari delle valli principalmente del Möll e <strong>di</strong> Lesach . Io credo pertanto che appunto nel nostro<br />
vernacolo paragonato co’ vari <strong>di</strong>aletti tedeschi, e specialmente con quelli della Carintia, si<br />
possano rinvenire quelle notizie che indarno doman<strong>di</strong>amo a’ perduti documenti; poiché le lingue,<br />
quantunque a poco a poco si trasformino, conservano però una fisionomia che il tempo, fosse pure<br />
<strong>di</strong> nove secoli quanti pressoché ne conta Sauris <strong>di</strong> esistenza, non può del tutto scancellare». Il Lucchini<br />
non fornì, però, elementi a sostegno <strong>di</strong> questa datazione.<br />
179