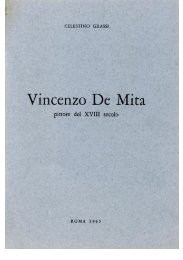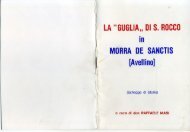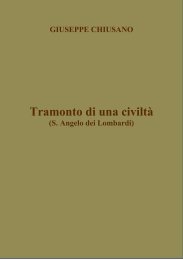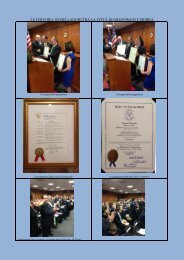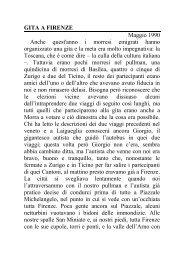Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Steiner <strong>di</strong>ce che tutta questa roba ci ha allontanato dal <strong>di</strong>alogo con la letteratura e che<br />
la funzione della critica dovrebbe essere piuttosto quella <strong>di</strong> suggerire “esecuzioni”,<br />
cioè come accade nell’esecuzione musicale, dove il musicista appunto “esegue” un<br />
testo, uno spartito musicale, o nella recitazione dell’attore, che recitando fa vivere il<br />
testo, ne crea l’esperienza. Critica come esecuzione e come persuasione: anche<br />
quest’ultimo è in fondo un termine desueto, poco apprezzato dalle generazioni <strong>dei</strong><br />
critici - scienziati e <strong>dei</strong> critici - tecnocrati: eppure il compito <strong>di</strong> una critica capace <strong>di</strong><br />
rispettare la vita <strong>dei</strong> testi dovrebbe essere proprio quello <strong>di</strong> persuadere il lettore<br />
dell’essenzialità della lettura, del valore del testo e della necessità del rapporto con<br />
esso.<br />
Francesco De Sanctis in fondo era già tutto questo: la sua critica, <strong>di</strong>cevo prima, è<br />
un continuo <strong>di</strong>alogo con i testi, è un <strong>di</strong>alogo che ne fa vivere il valore, anche da un<br />
punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>verso ed opposto, antagonistico, anche rifiutando e negando. Nel<br />
momento in cui fa delle riserve su <strong>di</strong> un autore, nel momento in cui mostra che in<br />
quell’opera c’erano delle cose che non andavano, che non vi si dà una sintesi autentica<br />
<strong>di</strong> vita, nel momento stesso in cui <strong>di</strong>ce questo in realtà si trova ad “eseguire” il testo, ci<br />
mostra la sua ricchezza e i suoi motivi <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zione. Un esempio può essere dato<br />
da quelle bellissime pagine su Metastasio all’inizio del capitolo della Storia su La<br />
nuova letteratura: pagine che io non leggevo da tempo e che ho riletto per questa<br />
occasione. Metastasio è l’autore che dovrebbe essere insomma la summa della<br />
negatività nell’ottica <strong>di</strong> De Sanctis, perché è l’ultimo che raccoglie quel formalismo,<br />
quella <strong>di</strong>mensione esteriore e retorica dell’anima italiana che, come prima in<strong>di</strong>cava<br />
Palumbo, per De Sanctis costituisce “il vizio profondo dell’anima italiana”. Eppure<br />
parlando <strong>di</strong> Metastasio De Sanctis tira fuori riflessioni acutissime sulla <strong>di</strong>mensione<br />
“popolare” del suo linguaggio e ad<strong>di</strong>rittura ad un certo punto, sottolineando la bellezza<br />
<strong>di</strong> certe situazioni metastasiane, invita ad abbandonarsi al loro effetto, superando le<br />
possibili riserve della critica e dell’estetica, con questa formidabile battuta: “E se<br />
l’estetica non l’intende, tanto peggio per l’estetica”. E questo dopo che lui stesso ha<br />
proposto una serie <strong>di</strong> riserve, <strong>di</strong> sottili richiami al legame <strong>di</strong> Metastasio con un passato<br />
<strong>di</strong> cui egli è ormai l’ultimo rappresentante. Il critico storico è insomma qualcuno che<br />
nel suo <strong>di</strong>alogo con i testi si trova spesso a contrastare e contendere: ma il suo <strong>di</strong>alogo<br />
è così forte, così vivo, così intenso, proprio perché è intrecciato a tutti quei contrasti. Il<br />
critico non è uno che sta a contemplare la realtà testuale passivamente, come giu<strong>di</strong>ce<br />
imparziale (e qui De Sanctis è in fondo molto più avanti rispetto a Croce): non è uno<br />
che giu<strong>di</strong>ca, ma uno che sta lì sempre a combattere, che ogni volta che <strong>di</strong>aloga con un<br />
testo o con un’esperienza letteraria mette in gioco se stesso e quin<strong>di</strong> mette in gioco<br />
giustamente anche la propria parzialità; ma proprio in questo mettere in gioco la<br />
propria parzialità riesce a catturare la verità <strong>dei</strong> testi molto <strong>di</strong> più del critico freddo e<br />
<strong>di</strong>staccato, o <strong>di</strong> quello che misura col goniometro o con qualsiasi altro strumento la<br />
struttura e le forme del linguaggio letterario. Wellek qui sottolinea giustamente una<br />
cosa notata anche da altri (ma so che il capitolo della sua Storia della critica moderna<br />
su De Sanctis è stato in gran parte ispirato proprio dal collega Della Terza che forse ci<br />
potrà <strong>di</strong>re qualcosa in proposito): e cioè che De Sanctis arrivò “persino a vedere nel<br />
critico un attore, per analogia col teatro”. La metafora dell’attore è molto interessante<br />
e Wellek tra l’altro fa riferimento ad una battuta dello stesso De Sanctis, che nota che