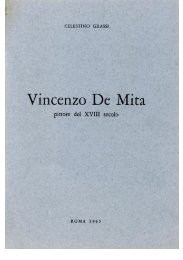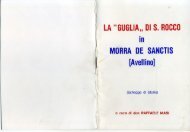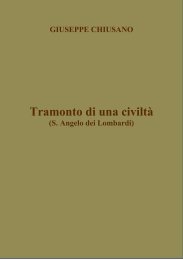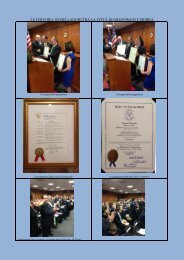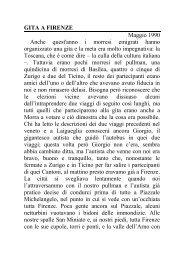Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
il critico e l’attore “non riproducono semplicemente il mondo poetico, ma lo<br />
integrano, empiono le lacune”. Ma qui occorre molta <strong>di</strong>screzione: se a <strong>di</strong>rlo e a farlo è<br />
De Sanctis va benissimo; se invece ci imbattiamo in qualche critico “selvaggio” che<br />
vuol riempire le lacune del testo letterario, allora teniamoci lontani. De Sanctis è<br />
attentissimo alla concretezza <strong>dei</strong> testi, anche se non possiede tutti gli adeguati dati <strong>di</strong><br />
tipo filologico, se non ha a <strong>di</strong>sposizione testi sempre vagliati criticamente (ma va<br />
notato che troppo facile è per molti critici contemporanei andare ad in<strong>di</strong>viduare gli<br />
errori materiali, oggettivi, <strong>di</strong> tipo filologico <strong>di</strong> De Sanctis: quando questi ci sono, non<br />
si tratta <strong>di</strong> un suo limite, ma del limite <strong>di</strong> una cultura e <strong>dei</strong> materiali storici a sua<br />
<strong>di</strong>sposizione). La critica oggi possiede strumenti, dati conoscitivi, repertori e archivi <strong>di</strong><br />
tutti i tipi, per cui anche il critico caprone, che non capisce assolutamente niente, può<br />
riuscire ad azzeccare certe cose che De Sanctis non poteva sapere: e mi sembrano<br />
francamente ri<strong>di</strong>coli certi saggi in cui si denunciano gli errori <strong>di</strong> De Sanctis, si osserva<br />
con pedanteria che il critico irpino, poveretto, attribuiva il testo tal <strong>dei</strong> tali ad un<br />
autore, mentre invece era <strong>di</strong> un altro, o attribuiva ad un autore ben preciso <strong>dei</strong> testi che<br />
invece poi si sono rivelati apocrifi, etc. Si tratta della normale <strong>di</strong>alettica dello sviluppo<br />
delle conoscenze: ed è chiaro che dobbiamo naturalmente situare De Sanctis nel<br />
momento in cui ha scritto, ha lavorato.<br />
Dicevo del <strong>di</strong>alogo: bisogna notare in proposito che anche questo contrastare con i<br />
testi letterari, riconoscerli nella forza <strong>di</strong> uno scontro, rilevarne la concretezza anche nel<br />
contrasto, tutto ciò è legato ad un conflitto che è interno stesso alla riflessione e al<br />
pensiero estetico <strong>di</strong> De Sanctis: il conflitto, non sempre risolto tra forma e contenuto,<br />
che è una delle essenziali e ben note spinte <strong>di</strong>namiche della sua critica. Anche se in<br />
ultima analisi la sua attenzione va precipuamente al contenuto, lo scatto determinante<br />
della sua critica sta proprio nel modo in cui egli in<strong>di</strong>vidua e descrive questi rapporti e<br />
contrasti <strong>di</strong>versi, questo vario atteggiarsi della forma e del contenuto. Il contenuto non<br />
è qualche cosa <strong>di</strong> astratto, <strong>di</strong> esteriore: come <strong>di</strong>cevamo prima, è la vita, il modo <strong>di</strong><br />
atteggiarsi della vita. E non si trascuri il fatto che questa idea dell’opera come vita<br />
lascerà tracce notevoli anche nella cultura successiva, per esempio in Pirandello:<br />
nell’estetica <strong>di</strong> Pirandello si dà più <strong>di</strong> un legame, spesso implicito, con il modello <strong>di</strong><br />
De Sanctis, come può vedersi perfino nella definizione del personaggio come “forma<br />
vivente” nella famosa prefazione ai Sei personaggi in cerca d'autore.<br />
E <strong>di</strong>cevo che il dramma storico dell’Italia nella Storia della letteratura italiana si<br />
svolge come nel filo <strong>di</strong> un <strong>di</strong>alogo con i testi e con gli autori, in questa continua<br />
tensione vitale e morale che compone il percorso a cui ha fatto riferimento Palumbo,<br />
da un Me<strong>di</strong>oevo dove c’è una fortissima tensione morale, però legata al dominio della<br />
trascendenza, alla rivoluzionaria scoperta rinascimentale della realtà mondana. Questa<br />
rivoluzione comporta, però la per<strong>di</strong>ta della tensione morale, una per<strong>di</strong>ta che fa<br />
emergere da una parte il regno del comico, dell’in<strong>di</strong>fferenza, dell’ironia, e dall’altra il<br />
formalismo retorico - letterario. In questo percorso, così schematicamente riassunto,<br />
trovano una collocazione molto intensa proprio Machiavelli e Guicciar<strong>di</strong>ni. In<br />
proposito Palumbo ha estratto dal capitolo su Machiavelli quella citazione che io<br />
troppo amo, sulle campane che suonano quando Roma viene liberata e lo storico sta<br />
scrivendo appunto il capitolo su Machiavelli: citazione che è il punto nodale della<br />
Storia letteraria <strong>di</strong> De Sanctis, il punto in cui, come <strong>di</strong>ceva Palumbo, la storia della