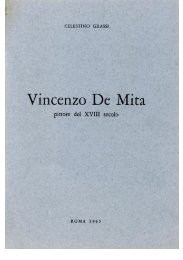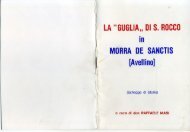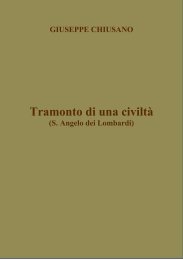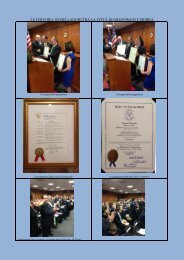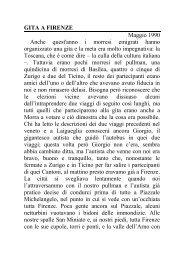Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Atti dei seminari di studi desanctisiani - Morreseemigrato.Ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
costruisce una storia della letteratura, e la storia della letteratura fa tutt’uno con la<br />
storia dell’ethos, della fibra morale del popolo italiano. La saldatura è possibile, anzi<br />
necessaria, perché la letteratura riflette, non imme<strong>di</strong>atamente, ma attraverso<br />
l’elaborazione fantastica, la vita spirituale dello scrittore, i suoi sentimenti, la sua<br />
coscienza morale. “De Sanctis sapeva bene”, ci ricorda Valitutti (p. 51), “che essa (la<br />
poesia) è opera della fantasia, ma sapeva anche che in essa si rispecchia la generale<br />
vita spirituale del poeta, e varia con il variare <strong>di</strong> questa vita. Perciò egli ricercò sempre<br />
l’arte nell’unità dello spirito e della storia”. Va aggiunto che De Sanctis non stacca lo<br />
scrittore dal- l’ethos della sua epoca, anche quando il rapporto è <strong>di</strong> contrasto e <strong>di</strong><br />
conflitto. Diceva il mio maestro Luigi Russo che la poesia è un fiore che attinge il<br />
cielo, ma ha le sue ra<strong>di</strong>ci nella terra.<br />
Per passare al concetto <strong>di</strong> riforma intellettuale e morale bisogna tener conto<br />
dell’interpretazione che De Sanctis dà della storia morale e civile dell’Italia. E, come<br />
si sa, un’interpretazione pessimistica, <strong>di</strong>scussa e <strong>di</strong>scutibile, il cui nodo più importante<br />
è l’interpretazione del Rinascimento. Nell’età moderna l’Italia, invece <strong>di</strong> arrivare,<br />
come altri paesi dell’Europa, ad una riforma religiosa, aveva iniziato un processo <strong>di</strong><br />
decadenza religiosa; invece <strong>di</strong> costituirsi, come auspicava Machiavelli, in un grande<br />
Stato, era caduta sotto il dominio straniero. I vizi che avevano caratterizzato la<br />
decadenza dell'Italia, erano per De Sanctis il guicciar<strong>di</strong>nismo, l’assenteismo civico,<br />
l’accademismo. Egli aveva piena coscienza che il Risorgimento era opera <strong>di</strong> un’élite<br />
ristretta <strong>di</strong> intellettuali e politici, che il popolo italiano, anche se unito in un solo Stato,<br />
non si era affatto liberato da quei vizi, che l’uomo del Guicciar<strong>di</strong>ni era sempre il tipo<br />
d’italiano più comune a tutti i livelli sociali. Questa interpretazione della storia d’Italia<br />
fa tutt’uno col bisogno della riforma intellettuale e morale che liberi la società italiana<br />
da questi vizi e nella formazione <strong>di</strong> una nuova coscienza unifichi realmente il paese;<br />
senza quella riforma l’unità politica resterà un guscio vuoto. Valitutti, senza forzature,<br />
riconduce a questo concetto centrale della riforma tutta l’attività politica <strong>di</strong> De Sanctis,<br />
in particolare quella da lui svolta come ministro: per es., anche l’introduzione<br />
dell’educazione fisica nelle scuole, su cui vi sono in questo libro ottime pagine, prende<br />
il suo senso pieno nel tipo nuovo <strong>di</strong> uomo che si vuole creare attraverso la riforma, un<br />
uomo in contatto equilibrato e sano con la realtà, a cominciare da quello del suo corpo:<br />
la proposta si capisce bene nella polemica antiromantica e antiintellettualistica <strong>di</strong> De<br />
Sanctis. Il concetto desanctisiano <strong>di</strong> riforma intellettuale e morale implica, e Valitutti<br />
lo mette bene in evidenza, il concetto del primato della cultura nella storia: la cultura,<br />
che non è solo etica, ma <strong>di</strong> cui l’etica è parte essenziale, anzi il fuoco vitale, muove e<br />
<strong>di</strong>rige la società: perciò ogni rinnovamento della società dev’essere rivoluzione<br />
culturale (questo pericoloso termine è usato non da un maoista, ma, con certe riserve,<br />
dallo stesso Valitutti).<br />
Quest’interpretazione unitaria a me pare quasi del tutto convincente; una ragione<br />
sarà che io vi ero pre<strong>di</strong>sposto da tempo. Infatti la lettura mi ha riportato agli anni della<br />
mia giovinezza, cioè agli anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> presso la Facoltà <strong>di</strong> Lettere e la Scuola Normale<br />
<strong>di</strong> Pisa, intorno al 1940. Allora in quell’ambiente il <strong>di</strong>battito sull’impostazione e sul<br />
metodo della critica letteraria era molto vivo: Luigi Russo stava elaborando una delle<br />
sue opere più polemiche, quella sulla critica letteraria contemporanea. Egli non<br />
intendeva rompere con la base dell’estetica crociana, con la <strong>di</strong>alettica <strong>dei</strong> <strong>di</strong>stinti, ma